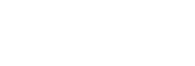In apertura: Mostra Rileggere il Risorgimento (© Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Torino)
Al Museo del Risorgimento di Torino è stata recentemente organizzata la mostra Rileggere il Risorgimento. Torino / Italia: 1884-2024 con la quale si ricorda il primo allestimento del Museo del Risorgimento all’Esposizione Generale Italiana del 1884 al parco del Valentino. La mostra offre l’opportunità di ragionare sull’attualità della storia risorgimentale attraverso oggetti prestati per l’occasione da molti musei italiani e la loro – aggiornata – interpretazione. L’intervista ad Alessandro Bollo, direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, si deve a Paola E. Boccalatte.
Le Esposizioni nazionali e internazionali nascono a metà Ottocento con la finalità di illustrare e promuovere le conquiste e i progressi dei diversi Paesi in ambito scientifico, artistico, industriale. L’Esposizione Generale Italiana del 1884 a Torino fu un appuntamento centrale nella storia della città e dell’Italia, noto oggi perlopiù per l’unica parte che, sebbene nata come monumento effimero, è ancora prezioso testimone di quel momento: il borgo medievale con la sua Rocca. Ma in quell’esposizione c’era un’altra sezione eccezionale.
Sì, l’Esposizione Generale Italiana del 1884 costituiva un momento emblematico per Torino, un episodio capace di rappresentare una svolta nell’elaborazione di una nuova immagine della città che, superato il trauma dello spostamento della capitale a Firenze prima, e a Roma poi, anelava a diventare una città moderna, manifatturiera, nella quale si coniugavano scienza e industrializzazione, pace sociale e interclassismo. Pensata sul modello dell’Esposizione parigina del 1878, si sviluppava lungo il parco del Valentino a ridosso del fiume Po. I giornali dell’epoca descrivono una città invasa da visitatori italiani e stranieri, ammaliati dai tanti prodotti del lavoro e dai prodigi dell’industria e della tecnica. Si contano 14.237 espositori; i visitatori al termine dell’evento saranno circa tre milioni.
Nell’ambito dell’Esposizione Generale, ampio spazio è dato al Risorgimento, inglobato e rielaborato attraverso un grande dispositivo di narrazione, un padiglione dedicato: il Tempio del Risorgimento. Il padiglione, nelle intenzioni degli organizzatori, doveva portare alla costituzione temporanea di una “biblioteca della Rivoluzione italiana, un museo illustrativo della nostra epoca nazionale”.
Nei fatti la sua realizzazione fu il risultato di una chiamata collettiva rivolta ai sindaci, alle istituzioni e ai territori del Regno d’Italia, per raccogliere cimeli e tutto quanto potesse ricordare eroi, luoghi ed episodi della Storia del Risorgimento per esporli in un più ampio racconto, volto a celebrare il processo di unificazione della nazione risorta. Il risultato fu quello di presentare il Risorgimento come momento unificante, un racconto nazional-popolare, conciliatorista e pacificato in una riscritta armonia, molto lontano dalla narrazione di un processo storico caratterizzato e animato da ideali contrapposti e lacerazioni fra vincitori e vinti. Uno dei risultati indiretti dell’esperienza del Tempio del Risorgimento fu che molte delle testimonianze e dei cimeli presenti, una volta ritornati nei territori di origine, rappresentarono il nucleo di future collezioni civiche e Musei del Risorgimento, tra cui Milano, Genova, Brescia e il nascente Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.
Il padiglione, fra l’altro, è ricordato anche al Museo del Risorgimento di Brescia e in una piccola mostra allestita a Reggio Emilia1. Nella mostra che lei ha curato con Silvia Cavicchioli e Daniela Orta, l’oggetto ha un ruolo molto rilevante. Quale logica ha guidato la scelta degli oggetti da esporre?
Nell’ambito della mostra, a distanza di 140 anni dall’Esposizione Generale Italiana si è voluto ripetere e riproporre, con ambizioni certo più limitate, quel coinvolgimento di enti e realtà museali dedicate al periodo risorgimentale. Il risultato è stato un piccolo grande esperimento di collaborazione a cui hanno preso parte, con grande entusiasmo, numerose e prestigiose istituzioni italiane. A tutte loro è stato, infatti, proposto di “rileggere il Risorgimento” con una selezione di oggetti che fossero capaci di esprimere e restituire il valore simbolico del Risorgimento e dei suoi ideali nel presente. Il risultato è un assortimento straordinario di cimeli, vessilli e documenti emblematici di storie collettive e imprese individuali, grandi personaggi della storia e anonimi protagonisti di un comune sentire e agire. Gli enti coinvolti sono stati il Museo del Risorgimento di Milano, il Museo del Risorgimento di Bologna, il Museo del Risorgimento-Istituto Mazziniano di Genova, la Domus Mazziniana di Pisa, il Museo del Risorgimento di Udine, il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia” di Brescia, il Museo del Risorgimento Vittorio Emanuele Orlando di Palermo, il Compendio Garibaldino di Caprera, la Società Napoletana di Storia patria e la Fondazione Cavour di Santena.
Tra i molti importanti cimeli presenti, ne segnalo uno che per molto tempo è stato oggetto di vera e propria venerazione: il plaid che in punto di morte ha coperto Carlo Cattaneo e successivamente Giuseppe Mazzini. Si tratta di un oggetto di uso quotidiano molto semplice che è diventato protagonista di una trasformazione simbolica singolare: è diventato prima cimelio, quindi reliquia laica “per contatto” col corpo dei due massimi teorici del Risorgimento repubblicano, fino a essere definito “bandiera” dallo storico ed editore Pietro Barbera, che lo paragonò nientemeno che al Tricolore. Dopo la morte di Mazzini lo scialle è stato conservato da Agostino Bertani e per passaggi successivi è arrivato in donazione al Comune di Genova che, dal 1934, lo conserva presso l’Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento. Come molti oggetti in esposizione, oggi parla con “voce” diversa alle ragazze e ai ragazzi del 2025; la sua forza simbolica non è più autoevidente ed è qui che deve entrare in azione il museo fornendo un contesto interpretativo e narrativo che sappia coinvolgere, affascinare e interessare le persone. Si tratta di risemantizzare un oggetto di devozione in un dispositivo capace di stimolare la curiosità, l’approfondimento e la comprensione.
Lungo il percorso ci sono alcuni ricevitori telefonici, stratagemma per accedere a contributi audio2. Che tipo di testi sono? A quale esigenza rispondono?
Abbiamo scelto di inserire delle cornette telefoniche (interessante e un po’ sconvolgente vedere come si tratti di un oggetto pressoché sconosciuto tra i più giovani che inizialmente lo osservano incerti cercando di capirne il funzionamento) come strumenti di attivazione di contributi narrativi che danno voce ai direttori e ai conservatori di tutti i musei coinvolti nella mostra. Abbiamo chiesto loro di riflettere sul potere evocativo e testimoniale degli oggetti scelti e sul significato del Risorgimento oggi. Ne è emerso un paesaggio narrativo corale molto interessante per riflettere in termini critici sulla capacità degli oggetti di continuare a parlare resistendo alla prova del tempo e del cambiamento profondo del contesto di ricezione.
Tra i tanti, mi piace segnalare l’intervento di Otello Sangiorgi, direttore del Museo civico del Risorgimento di Bologna che ha voluto chiudere il suo intervento ricordando che “i protagonisti del Risorgimento si sentirono chiamati in causa dalla storia e, con tutti i loro limiti e i loro errori, decisero di rispondere, affermando l’esistenza di qualcosa per cui ‘valeva la pena’ vivere e morire. Gli oggetti esposti ci parlano di persone che, meno di due secoli fa, non hanno esitato a dire ‘io’, a dire ‘noi’”. Riprendendo il ragionamento di Sangiorgi potremmo dire che gli oggetti “parlano” con voce ancora attuale quando le persone a cui fanno riferimento hanno vissuto e incarnato il passato in un modo capace di risuonare e attivare connessioni di senso con le dimensioni esistenziali del nostro presente.
Nella parte finale del percorso ci sono due grandi pannelli. Uno consente di visualizzare il contributo offerto da ogni parte d’Italia alla costruzione di questo percorso espositivo, ma in definitiva anche alla storia dell’unificazione e costruzione del paese. Il secondo invece…
Il secondo pannello (e ultimo dispositivo comunicativo del percorso) consiste in un piccolo gioco per coinvolgere le persone e farle riflettere su uno degli obiettivi della mostra che è quello di creare un ponte tra ieri e oggi, una connessione tra gli eventi e i fatti di quel periodo e la dimensione del contemporaneo. Si tratta di un grande spazio bianco in cui i visitatori possono rispondere a due domande avendo a disposizione solo sei parole tra cui scegliere (che possono essere riportate sulle pareti attraverso adesivi colorati prestampati). Le domande sono “Quali parole associ al Risorgimento” e “Quale di queste parole è importante nel presente”. Le parole a disposizione sono: Rivoluzione, Ideali, Libertà, Patria, Coraggio e Diritti. Il risultato è un grande mosaico colorato di parole che si stratificano e cambiano continuamente, mutando il paesaggio estetico e di significato della mostra. Si creano pertanto campiture cromatiche relative alle parole scelte che consentono di valutare a volo d’uccello le preferenze e le associazioni più ricorrenti e il loro modificarsi anche in relazione alla tipologia e all’età dei visitatori.
Fra i rari e preziosi volumi digitalizzati dalle Biblioteche Civiche e liberamente consultabili e scaricabili nella sezione Biblioteca3 di MuseoTorino (museo digitale della città di Torino realizzato nel 2011 per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)4 ci sono il Catalogo degli oggetti esposti nel padiglione del Risorgimento italiano – “volume-inventario” in quattro impressionanti tomi di tutti i documenti esposti – e il Catalogo degli oggetti e documenti, 60 cimeli scelti, prestati da istituzioni e comuni cittadini in una forma, diremmo oggi, “partecipativa”. C’è ancora spazio oggi, in un museo del Risorgimento, per la partecipazione della cittadinanza?
Il tema della partecipazione rimane centrale per tutti i musei e in particolare per un museo di storia qual è il Museo del Risorgimento. Oggi, infatti, la sfida è quella di lavorare sia sul fronte dell’accessibilità sia su quello dell’attivazione delle persone e delle comunità che possono interagire con le istituzioni museali. Sono diverse le possibilità di inclusione, attivazione e coinvolgimento del pubblico. Diventa però preliminare interrogarsi sul senso ultimo della partecipazione in uno spazio museale che tradizionalmente si presta a una fruizione libera “per attraversamento” dei suoi spazi. In queste condizioni di uso sono piuttosto limitati gli strumenti di mediazione, integrazione e feedback che sono sempre più necessari per una reale comprensione degli oggetti, dei fatti, dei messaggi e delle storie che si intrecciano e compongono il vettore dell’esperienza museale. Per converso le attività educative, i laboratori e le molte iniziative “guidate” e di accompagnamento alla visita consentono di lavorare in profondità e in modo personalizzato sugli elementi di contesto, di fascinazione e di narrazione che l’allestimento da solo spesso non riesce a fornire. Una buona comprensione, un coinvolgimento pieno e consapevole, la possibilità di utilizzare la “materia” del passato come relè interpretativo e come stimolo di autoriflessione spontanea sul presente rappresentano per certi versi il “grado zero” dell’intenzione partecipativa che il museo deve avviare. Su questa si innestano modalità di coinvolgimento che possono prevedere strade anche molto diverse: dalla partecipazione delle persone nella produzione di senso che l’esperienza culturale abilita, alle iniziative di outreach in cui il museo può uscire letteralmente dalle proprie mura tracimando nello spazio pubblico e ampliando così la propria superficie di contatto. L’esperienza estiva “Sotto i Portici del Risorgimento”, del 2024, è nata proprio per creare un punto di incontro tra le persone e il museo nello spazio pubblico dei portici di piazza Carlo Alberto5.
Oggi il Museo del Risorgimento di Torino custodisce una quantità impressionante di oggetti. Molti di essi sono esposti nelle sale ma molti altri sono nei depositi. Che progetti ha il Museo su questa raccolta e sulla sua valorizzazione? Quali sfide deve affrontare? Nuove acquisizioni storiografiche ridefiniscono via via la nostra conoscenza della storia e dei suoi nodi, anche problematici; in che modo le soluzioni museali si sentono sollecitate e rispondono (o possono rispondere) a queste sollecitazioni?
La grande maggioranza degli oggetti della collezione non è esposta, ma accolta nei depositi di Palazzo Carignano. Solo un ventesimo circa del patrimonio complessivo è attualmente esposto (2.560 oggetti). In questo momento forse il problema risiede nel fatto che si dovrebbe ridurre e non aumentare il numero di oggetti in esposizione per facilitare paradossalmente una lettura e una comprensione più efficace del contesto storico e culturale e per estrarre valore narrativo e simbolico dai cimeli e dalle opere presenti.
Nei fatti si sta avviando un nuovo cantiere di lavori che dovrebbe prevedere una riorganizzazione degli spazi in cui, a regime, si possa beneficiare di aree dedicate e depositi visitabili di facile consultazione, aperti su richiesta e rivolti a un pubblico specialistico, capace di creare a sua volta conoscenze e valorizzazione in un ciclo virtuoso di apertura-ricerca-valorizzazione-divulgazione.
Note
1 Una storia per tutti. Nicomede Bianchi e la pedagogia del Risorgimento, mostra a cura di Alberto Ferraboschi, Chiara Panizzi, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 16 novembre 2024-29 marzo 2025.
2 I contributi sono presenti anche alla pagina www.museorisorgimentotorino.it/mostre/rileggere-risorgimento/, ultima consultazione di tutti i link: 7 gennaio 2025.
3 Biblioteca di MuseoTorino, www.museotorino.it/site/library.
4 Su ragioni e genesi del progetto cfr. “Rivista MuseoTorino”, in partic. n. 0 www.museotorino.it/site/library/magazine.
5 Sotto i portici del Risorgimento è il programma di giochi, animazione, didattica, relax e attività culturali nel portico e nell’atrio del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. www.museorisorgimentotorino.it/news/sotto-i-portici-del-risorgimento/.