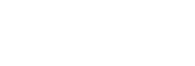In apertura: bambini napoletani a bordo di uno dei treni della felicità (@ Archivio UDI, Bologna).
1. Introduzione
Fra il 1945 e il 1952, l’Unione Donne Italiane (UDI) e il Partito comunista italiano (Pci) organizzarono il trasferimento di circa 70.000 bambini poveri, per salvarli dalla miseria e offrire loro un po’ di benessere presso le famiglie che per alcuni mesi li ospitarono in regioni come l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche, la Liguria e il Piemonte. L’operazione partì da Milano, quando le donne della sezione femminile del Pci ricevettero la visita di Daria Banfi, autrice di testi di pedagogia e libri per l’infanzia. Daria Banfi chiedeva l’aiuto delle compagne per trovare ospitalità per circa otto orfani del suo quartiere. Teresa Noce, che allora era la responsabile per il lavoro femminile, conosceva bene le condizioni drammatiche dei bimbi milanesi e pensò di estendere l’operazione a un numero maggiore di bambini. Vincendo l’iniziale scetticismo dei compagni del partito che volevano che l’operazione includesse solo i figli di ex partigiani e altri compagni, Teresa Noce e le altre donne diedero vita a un’operazione grandissima, che da Milano si estese ad altre città italiane: Torino, Roma, Cassino, Napoli e, dopo il 1948, raggiunse zone della Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna.
L’operazione, allora ufficialmente conosciuta come Movimento per la salvezza dei bambini d’Italia, per molti anni è stata dimenticata ed esclusa dalla memoria storica, nonostante il ruolo fondamentale svolto nell’ambito della ricostruzione nazionale dopo l’esperienza fascista e della Seconda guerra mondiale; nonostante offra una chiave di lettura decisamente nuova ed interessante di quella che era la società dell’epoca, ad esempio per capire i rapporti fra Nord e Sud o la posizione delle donne nell’Italia del dopoguerra. Che dire poi del rapporto fra Stato e società o la rielaborazione del concetto orizzontale di solidarietà in contrapposizione a un’idea perpendicolare di beneficenza?
Negli ultimi anni c’è invece stata una riscoperta della storia, grazie al lavoro di Giovanni Rinaldi, storico orale che si è imbattuto nella vicenda casualmente, mentre conduceva altre ricerche su una serie di rivolte contadine che ebbero luogo a San Savero, in Puglia, nel 1950. Rinaldi ha ricostruito la storia dei treni in due libri, I treni della felicità (Ediesse, 2009) e C’ero anch’io su quel treno (Solferino, 2021)1. Da allora, si sono susseguite una serie di pubblicazioni – accademiche e non solo – produzioni teatrali (I treni della felicità di Laura Sicignano), il romanzo Il treno dei bambini di Viola Ardone e l’omonimo film della Comencini. La storia dei treni della felicità – definizione che si deve ad Alfeo Corassori, allora sindaco di Modena2 – sta entrando a far parte della memoria storica del nostro paese.
Il progetto di ricerca presentato in questo articolo nasce proprio in questo contesto. Grazie a una borsa di ricerca offerta dalla British Academy, sono stati visitati 17 archivi in Italia3 e sono state intervistate 15 persone, sia testimoni diretti che indiretti. La ricerca ha portato alla realizzazione di un sito web, il primo in Italia completamente dedicato alla storia dei treni della felicità. Il sito web, insieme ad un’esperienza di laboratorio condotta in una scuola secondaria di primo grado a Bologna, saranno oggetto di questo articolo e analizzati come esperienze di public history. Sia il sito che il laboratorio sono stati concepiti non solo per diffondere la storia dei treni ma anche per stimolare forme di apprendimento attivo e partecipato della storia, oltre che di riflessione storiografica e di ricostruzione collettiva della memoria storica. Proprio questo è l’insegnamento della public history: connettersi con la società per ripensare la storia come uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per capire e affrontare le grandi sfide del presente.
2. Il sito web
Il sito web, consultabile al link https://arcg.is/00vySq0, è stato concepito e strutturato come una raccolta di fonti varie, principalmente materiale d’archivio, foto e testimonianze. Nasce dalla necessità di far conoscere questa storia ad un pubblico più ampio ma soprattutto di condividere parte del materiale archivistico, attualmente disseminato nei vari archivi in Italia e per questo difficilmente accessibile al pubblico. Attraverso il sito, il linguaggio multimediale viene quindi in supporto della ricerca storica, al fine di valorizzare e disseminare il patrimonio umano, storico e culturale che abbiamo a disposizione sulla vicenda dei treni, perché la storia, nel senso esteso di disciplina, se vuole avere un impatto sulla società deve assolutamente uscire dagli ambienti accademici ed esplorare contesti e modalità nuovi, più accessibili e trasversali4.
La narrazione della storia dei treni attraverso un sito web ha rappresentato un importante momento di riflessione sulle modalità comunicative. Infatti, la public history digitale richiede pratiche e abilità che esulano dalle competenze tradizionali degli storici5. Per cominciare, il materiale archivistico raccolto non poteva essere pubblicato nella sua totalità, il che ha richiesto una prima fase di analisi, selezione e rielaborazione, tenendo presente la diversa tipologia di pubblico rispetto ad un testo accademico. Offrire contenuti facilmente fruibili e allo stesso tempo informativi, dettagliati ma non pedanti si è da subito imposta come una necessità, al fine di rispettare la realtà storica dei contenuti ma presentandola in maniera coinvolgente e interessante, cercando quell’equilibrio che è proprio della public history6. Inoltre, in un sito diventa fondamentale usare prodotti di natura grafica e visiva. La narrazione testuale è stata infatti arricchita anche dall’inserimento di foto dei documenti cartacei, scattate nei vari archivi o condivise dai testimoni. L’uso delle foto permette di abbattere ulteriormente la distanza fisica tra le persone e gli archivi, rendendone il contenuto più concreto e facilmente fruibile.
Mirando a comunicare in maniera chiara e diretta, anche la struttura del sito è stata ritenuta fondamentale. L’indice è ben evidenziato e permette di navigare fra le varie sezioni in modo semplice e veloce. Inoltre, per lo stesso motivo si è voluto dare alla narrazione una struttura lineare, evitando la creazione di più livelli attraverso l’aggiunta di link o schede analitico-descrittive. La parte storica è suddivisa in tre sezioni. La prima ricostruisce il contesto storico che fa da sfondo alla storia dei treni e ne evidenzia i principali aspetti socio-economici e politici. C’è poi una parte dedicata all’UDI, che ripercorre le varie tappe dell’associazione e dimostra il suo ruolo chiave per generazioni di donne italiane, con uno sguardo particolare alle campagne per la tutela dell’infanzia. Infine, l’ultima sezione segue l’evoluzione dell’iniziativa dei treni nel corso degli anni e in relazione alle diverse città che ne beneficiarono. Questa parte storica è seguita da una breve sezione dedicata alla rappresentazione dei treni della felicità nella cultura popolare. Questa mira a far conoscere il materiale a disposizione del pubblico, evitando invece un’analisi dei prodotti culturali, analisi che è stata ritenuta più adatta ad un testo accademico. Infine, il sito presenta una sezione intitolata The stories, dove sono raccolte le varie testimonianze. Lo stile narrativo di quest’ultima sezione è poco accademico, scelta che risponde al desiderio di mantenere e trasmettere la carica emotiva delle storie. Ricostruire e raccontare la storia significa anche prestare attenzione alle singole esperienze che la compongono; andare oltre la sua dimensione ufficiale e politica, per salvaguardare e trasmettere le voci di chi della storia è stato protagonista7. Questo approccio riconosce che la storia ha molteplici dimensioni e che una di queste emerge grazie al contributo delle fonti orali, che offrono una prospettiva ulteriore rispetto a documenti scritti e ufficiali, essendo esse un «recalling of emotions as well as events»8. Riportare le voci dei testimoni fedelmente, senza alterarne lo stile e il tono, corrisponde alla volontà di offrire una dimensione partecipata della storia, in cui il mio ruolo fosse solo di intermediaria e facilitatrice della comunicazione fra i testimoni e il pubblico del sito. La storia viene così caratterizzata come una forma di documentazione collettiva e partecipata, ossia come qualcosa che non ha una dimensione statica e permanente ma che si rinnova proprio grazie alla continua circolarità e condivisione di saperi e conoscenze.
3. Il laboratorio
L’esperienza di laboratorio, svoltasi ad aprile 2024, ha coinvolto due classi della scuola secondaria di primo grado C. Pepoli. Il laboratorio ha previsto due incontri con ogni classe, di due ore ciascuno, coinvolgendo in totale 48 alunni. La fase precedente al laboratorio ha visto una stretta collaborazione con l’UDI di Bologna, che ha costituito il tramite con le scuole della città. Inoltre, alcune volontarie dell’UDI hanno partecipato alla preparazione del laboratorio, revisionando la proposta didattica. È stata così creata una scheda con tutte le informazioni relative al laboratorio, da condividere con l’insegnante prima dell’incontro. Il laboratorio, intitolato I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra passato e presente, aveva i seguenti obiettivi: far conoscere la storia dei treni della felicità; riflettere sui flussi migratori contemporanei; stabilire connessioni fra le esperienze del passato e quelle attuali. A tale scopo, il laboratorio è stato suddiviso in tre parti. La prima parte mirava a sollecitare una discussione con gli studenti intorno al tema del viaggio. A tal fine venivano mostrate tre immagini di persone in partenza: una foto che rappresentava l’emigrazione italiana negli Stati Uniti; una foto che faceva riferimento alle migrazioni moderne, ad esempio dei giovani italiani che si trasferiscono all’estero per studio o per lavoro; una foto che ritraeva rifugiati e richiedenti asilo.
Gli studenti sono stati poi divisi in gruppi, un modo per coinvolgerli direttamente, per stimolare una partecipazione attiva e così superare i limiti della lezione frontale. È stato chiesto loro di stilare una lista di difficoltà che le persone devono affrontare quando emigrano. Come anticipato, lo scopo di questa prima parte era invitare gli allievi a riflettere sul tema del viaggio, stabilendo connessioni fra l’emigrazione passata e presente, fra le esperienze dei rifugiati e richiedenti asilo e quelle dei migranti italiani di ieri e di oggi. Si mirava così a normalizzare la migrazione come un fattore naturale della condizione umana. Al termine di questa prima parte è stata mostrata agli studenti una foto dei treni pieni di bambini, chiedendo loro di descrivere l’immagine e ipotizzare cosa stesse succedendo. Nel laboratorio le immagini sono state ampiamente utilizzate per stimolare la riflessione e la discussione9. Infatti, molti studi hanno dimostrato il valore delle immagini nella didattica, in quanto queste supportano la comprensione dell’argomento trattato e facilitano lo sviluppo di competenze critiche10.
A seguire, è stata fatta una breve presentazione della storia dei treni. Al termine di questa, gli studenti sono stati nuovamente divisi in gruppi. Ad ogni gruppo è stata consegnata una diversa testimonianza, che hanno poi dovuto presentare al resto della classe. In questo modo, gli alunni hanno potuto sviluppare una maggiore connessione con i protagonisti della vicenda e si è rafforzato anche il dialogo fra vecchie e nuove generazioni. Inoltre, l’attenzione posta alle storie individuali ha permesso agli studenti di andare oltre la dimensione collettiva della storia, per avvicinarsi invece alle storie personali che la compongono. Questo ha ricordato loro che la grande storia è sempre fatta dalle persone, sperando così di rafforzare anche la loro coscienza civica e dimostrare il loro valore e potenziale come cittadini. Nell’ultima parte del laboratorio sono state mostrate alcune foto di bambini rifugiati, dando così inizio a una discussione sui flussi migratori contemporanei. Questo ha permesso agli studenti di collegare una storia del passato a una recente. Gli alunni sono stati invitati a riflettere su una serie di aspetti, quali le difficoltà affrontate da rifugiati e richiedenti asilo, le azioni che possiamo compiere per supportare queste persone e una riflessione su come la loro presenza arricchisca la nostra società. In questo modo, gli studenti hanno potuto riflettere sul legame fra passato e presente e quindi capire ed apprezzare il valore educativo della storia come un qualcosa che non appartiene a un tempo e un luogo specifici, ma che si ripete e influenza il nostro presente. La memoria storica così non è fine a se stessa ma diventa parte integrante della società. Stimolare gli studenti a percepire questo legame fra passato e presente li aiuta ad approcciarsi agli eventi passati e presenti in maniera più cosciente ed attiva, andando oltre una passiva incamerazione di informazioni verso una compresione e rielaborazione attive.
Per concludere, gli alunni sono stati di nuovo invitati a lavorare in gruppo alla creazione di un poster per accogliere un gruppo di bambini rifugiati in arrivo nella loro scuola, scenario non reale ma altamente probabile. Agli studenti è stato anche chiesto di spiegare il disegno, di motivare determinate scelte e metterle in relazione con quanto appreso nel corso del laboratorio. Temi ricorrenti dei disegni sono stati l’empatia e l’inclusività, perfettamente in linea con quella lezione di tolleranza e accoglienza che era proprio uno dei fini del laboratorio. Questo dimostra come la storia sia uno strumento valido per formare la coscienza sociale delle future generazioni. Se il compito degli educatori è quello di ispirare e promuovere cambiamenti nella società, ci auguriamo che attività di questo tipo possano essere uno strumento effettivo contro l’intolleranza e la chiusura dilaganti nel mondo, per aiutare le future generazioni a capire e analizzare i flussi migratori contemporanei in maniera più informata e critica. Al termine del laboratorio, agli studenti è stato chiesto un feedback. Complessivamente, i feedback sono rivelati positivi e hanno dimostrato che, per gli studenti, è stato importante conoscere una storia del passato e, ancora di più, poterla mettere in relazione con fatti e vicende che appartengono alla nostra società contemporanea.
4. Obiettivi futuri
A partire dall’esperienza di laboratorio è stata creata una dispensa per insegnanti interessati a parlare della storia dei treni della felicità con i propri alunni. Il prossimo passo, sempre con la collaborazione dell’UDI, prevede la distribuzione di tale dispensa in una serie di scuole italiane. La dispensa conterrà informazioni storiche sulla vicenda dei treni della felicità, sul contesto politico e socio-economico che fa da sfondo alla storia e, ovviamente, informazioni sull’UDI e sul suo operato. Non mancheranno poi le attività da svolgere con gli studenti, sia quelle svolte nel corso del laboratorio che altre aggiuntive. Una sezione importante della dispensa poi presenterà alcune testimonianze, mentre un corpus più esteso sarà comunque a disposizione degli insegnanti tramite il sito. Infine, si spera di arricchire la dispensa con un podcast sui treni, progetto in corso che vede la partecipazione dello storico Giovanni Rinaldi. In questo modo, si mira a favorire l’inclusione della vicenda dei treni nel curriculum nazionale, affinchè la sua memoria sia istituzionalizzata e ufficializzata, preservata e trasmessa alle future generazioni. Una circolarità che porta la disciplina storica, tramite iniziative di public history, ad uscire dai suoi spazi tradizionali, per poi tornarvi, rafforzata e arricchiata da nuovi progetti, visioni alternative, orizzonti ampliati. Uno dei tanti meriti della public history è proprio quello di mettere storici ed accademici in contatto con la società, rendendo possibili e fruttuosi progetti di collaborazione e condivisione del sapere. I confini della storia diventano così più fluidi e permeabili, in uno scambio di idee e approcci che ci permettono di ripensare la disciplina oltre metodi e caratteri tradizionali, riportandola tra le persone. Il valore della storia diviene così evidente, tangibile e democraticamente alla portata di tutti.
Note
1 Un ruolo importante fu svolto anche da Alessandro Piva, autore del documentario Pasta nera (2011).
2 La usò per la prima volta guardando i treni che, da Modena, riportavano a Napoli un gruppo di bambini.
3 Nello specifico, sono stati visitati gli Archivi UDI di Napoli, Bologna, Roma, Genova, Ravenna, Reggio Emilia e Siena; gli Istituti Storici della Resistenza a Napoli, Novara, Modena e Parma; gli Archivi di Stato a Napoli e Modena, il Centro Documentazione Donna a Modena, la Biblioteca Estense a Modena, la Biblioteca Civica a Parma e l’Istituto Gramsci a Roma.
4 Debra J. Donnelly, Contemporary Multi-modal Historical Representations and the Teaching of Disciplinary Understandings, in “History, Journal of International Social Studies”, 2018, vol. 8, n. 1, pp. 113-132.
5 Gianfranco Bandini, Public History of Education. Teorie, Esperienze, Strumenti, Firenze, Firenze University Press, 2023, p. 17.
6 Adam M. Sowards, Being Historically Faithful in Public, in “The Pacific Northwest Quarterly”, vol. 114, n. 2/3, Special Double Issue: Historians and Their Audiences (Spring/Summer 2023), pp. 57-62.
7 Marcello Caruso, Classroom Struggle: Organizing Elementary School Teaching in the 19th Century, New York, Peter Lang, 2015.
8 Bandini, Public History of Education, cit., p. 13.
9 Diane M. Cordell, Using images to Teach Critical Thinking Skills: Visual Literacy and Digital Photography, London/New York, Bloomsbury Publishing, 2015.
10 Anne Nielsen Hibbing, Joan L. Rankin-Erickson, A Picture Is Worth a Thousand Words: Using Visual Images to Improve Comprehension for Middle School Struggling Readers, in “The Reading Teacher”, 2003, vol. 56, n. 8, pp. 758-770.