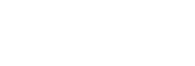In apertura: plancia di gioco durante il 6° turno della 3° parte della prima fase. Si può notare lo sbilanciamento a favore dell’URSS, i cui possedimenti sono contrassegnati dai segnalini rossi (Foto delle Autrici).
Twilight Struggle. The Cold War 1945-1989 è uno dei giochi da tavolo a tema storico più diffusi su scala mondiale. Come suggerisce il titolo, il gioco è incentrato sul periodo della Guerra fredda globale1, attorno ai cui eventi si sviluppano le sue fasi. Pubblicato nel 2005 dalla GMT Games, Twilight Struggle vanta milioni di fan su scala globale – in ludoteca online – al punto che la versione italiana del gioco è oggi introvabile.
Il titolo del gioco richiama il famoso discorso con cui John F. Kennedy inaugurò il 1961: «Ora la tromba ci richiama, non alle armi – anche se di armi abbiamo bisogno –, non alla battaglia – anche se siamo in guerra –, ma ci appella a sopportare il fardello di una lunga lotta crepuscolare», una twilight struggle, appunto2.
1. Giocare alla Guerra fredda
Dimostrandosi fedele alla storiografia classica sulla Guerra fredda, Twilight Struggle ne riproduce, ad un primo livello, la rappresentazione bipolare: si gioca solamente in due, scegliendo di impersonare uno dei due “blocchi”, sovietico o statunitense. Lo scopo del gioco è ovviamente sopraffare il proprio avversario e ci sono differenti modalità per farlo, ognuna delle quali rischiosa e incerta. Ciò che porta alla vittoria, infatti, è una tattica fatta di equilibrio e strategia, piuttosto che azioni prettamente “muscolari”, ben rappresentando la situazione geopolitica coeva.
Ci sono infatti diversi modi per aggiudicarsi la vittoria: 1) raggiungere 20 punti, accumulabili attraverso azioni militari o azioni “speciali”; 2) consolidare la propria presenza in uno dei continenti strategici per ogni fase di gioco, attraverso i requisiti espressi nelle “carte obiettivo”; 3) vincere “passivamente” perché l’avversario fa scoppiare una guerra nucleare. Quest’ultima circostanza si presenta quando si fanno troppi “colpi di stato” in un tempo ravvicinato. Ovvero si sottrae buona parte dell’influenza all’altro giocatore, sbilanciando repentinamente gli equilibri globali. 4) A queste tre modalità se ne aggiunge una quarta, la più “lineare”, che corrisponde alla conclusione delle tre fasi previste dal gioco, in seguito alla quale si conteggiano, sotto forma di segnalini, le influenze presenti sulla plancia per ognuno dei due blocchi. Queste differenti modalità di vittoria entrano in parziale contraddizione tra loro, spingendo i giocatori, da una parte, a imporsi su un numero di stati il più vasto possibile, e dall’altra, obbligandoli a non oltrepassare il punto di rottura degli equilibri mondiali.
Una partita a Twilight Struggle arriva a durare circa tre ore. Nonostante sia relativamente breve per i tempi di un war game, il gioco ci è parso sufficientemente cadenzato da conferire la percezione del conflitto quasi cinquantennale che punta a rappresentare. La partita, infatti, si suddivide in tre periodi, ai quali corrispondono tre mazzi di gioco: “inizio guerra”, “metà guerra” e “fine guerra”. Ogni periodo è suddiviso a sua volta in tre o quattro fasi, ognuna delle quali si compone di sei o sette turni. Nelle fasi iniziali della partita, il setting preimpostato delle influenze in gioco e il mazzo di carte relativo sono sbilanciati in favore dell’espansione russa. In tal modo sono rispecchiati gli eventi storici del periodo stalinista, fino ai fatidici eventi del 1956, la Rivoluzione ungherese e la denuncia dei crimini di Stalin3. Questo sbilanciamento è una strategia attraverso cui mostrare quella che, nel lungo termine, si è rivelata l’«“ironica combinazione” fra l’espansione esterna e il declino interno dell’Unione Sovietica»4. Man mano che si procede col gioco, infatti, si attesta un riassestamento degli equilibri nella fase intermedia – che riflette il periodo di détente –, fino a far pendere l’ago della bilancia in direzione USA nella fase finale.
Come nella realtà storica, tuttavia, la vittoria di nessuno dei due fronti è scontata5. Le statistiche segnano vittorie sufficientemente bilanciate anche dal punto di vista del meccanismo di gioco6.
Come si gioca una mano? Con una dose di caso affidata al tiro dei dadi, ogni giocatore si muove turno per turno sfoderando le carte pescate: otto per ogni fase. Le carte, disposte, come accennato, in tre mazzi, richiamano elementi storicamente rilevanti: eventi o persone, fisiche o giuridiche, del periodo a cui fanno riferimento. A seconda del reale impatto storico dei fatti, le carte e i loro effetti possono andare a privilegiare, sfavorire o porsi come neutrali rispetto alle due fazioni in gioco. Inoltre, una volta entrate in vigore, le carte possono avere validità permanente – come, ad esempio, la carta “NATO” –, o consistere in azioni temporanee che, dopo l’utilizzo, finiscono nel mazzo degli scarti. Queste includono, ad esempio, la “Rivoluzione islamica”7 e “Giovanni Paolo II eletto papa”8.
Una carta particolarmente interessante è “La carta cinese”. Questa, infatti, è l’unica a rimanere scoperta e valida per tutta la durata della partita, un jolly disponibile, a turno, a entrambi i giocatori. Pur essendo, quindi, neutrale, “La carta cinese” deve sempre essere utilizzata per la prima volta dall’URSS, richiamando così gli anni d’oro dell’alleanza sino-sovietica9.

Fig. 1. “La carta cinese” (J. Matthews, A. Gupta, Twilight Struggle: La Guerra fredda 1945-1989. Regolamento, Correggio, Asterion Press, 2011, p. 9).
2. Architettura di gioco: tra fedeltà e narrazione storica
Nonostante Twilight Struggle si dimostri storicamente fedele sotto molti aspetti, presenta tuttavia alcuni punti di criticità. A livello macro, l’elemento più evidente è la riduzione delle forze in gioco alle due potenze del blocco. Questo elemento getta in ombra le posizioni eterogenee degli altri attori geopolitici, ridotti ad un piano di assoggettamento che ne riduce la complessità storica, stilizzandone le alleanze. Rimane ad esempio escluso il movimento dei paesi non-allineati, che, non senza ragione, Lorenz Lüthi ha definito una delle più «grandi vittime» della Guerra fredda10. Allo stesso modo, è assente il protagonismo del continente asiatico – e in particolare della Rpc – sullo scacchiere mondiale nel tardo periodo della guerra. A livello locale, inoltre, si è prestata poca attenzione agli eventi contingenti caratteristici di alcuni stati periferici, i quali, pur essendo circoscritti, presentano un legame indubbio con il contesto internazionale. Questo aspetto, tuttavia, è stato in parte ovviato nelle espansioni del gioco che – anche grazie alla spinta del fandom – hanno incluso carte come “Anni di piombo”.
A livello micro, si può affermare che una grande assente del gioco è la storia sociale. Laddove viene data ampia rilevanza a eventi direttamente correlati alla geopolitica, rimane distante la percezione dell’impatto di questi e del ruolo attivo della società civile nel recepirli e rispondervi attivamente – specie fuori dall’occidente del mondo. I movimenti per i diritti civili, delle donne, dei neri e delle minoranze LGBT; l’espansione del mercato globale e della società dei consumi; le innovazioni tecnologiche e la rivoluzione delle telecomunicazioni, rimangono così sullo sfondo o sono del tutto assenti. Un’eccezione di rilievo è costituita dalla “Corsa allo spazio”, una gara nella gara che concede ai giocatori dei piccoli bonus.

Fig. 2. Carta “Anni di piombo” dell’espansione italiana (https://www.infoludiche.org/ritorna-twilight-struggle-con- quattro-carte-promo/), ultima consultazione: 21 gennaio 2025.
Questo focus sugli aspetti geopolitici potrebbe essere frutto di una scelta volta a rispecchiare le necessità e gli obiettivi del gioco. Al contempo, questo potrebbe riflettere l’orientamento della storiografia sulla Guerra fredda al tempo della pubblicazione del gioco. Infatti, è trascorso solamente un ventennio da quando i New Cold War Studies hanno messo in luce l’importanza degli aspetti sociali e culturali per la comprensione del periodo della Guerra e delle sue conseguenze nel medio-lungo periodo11.
La periodizzazione scelta dagli autori di Twilight Struggle, stimola ulteriori riflessioni. Il gioco data la Guerra fredda dal 1945 al 1989, ovvero dalla conclusione della Seconda guerra mondiale, sino al crollo del muro di Berlino. La scelta di una datazione netta adombra il dibattito storiografico sul tema. Risultano assenti una dichiarazione di guerra, e un atto formale di pacificazione, le periodizzazioni prendono in considerazione «aspetti interni agli stati e alle società»12 su cui si focalizzano.
Buona parte della storiografia sancisce l’inizio della Guerra fredda nella primavera-estate del 1947, col “lancio” della dottrina Truman e poi del Piano Marshall13. Altri studi prediligono il momento in cui questa si estese in maniera più evidente sul piano internazionale, a partire dalla sua “calda” espansione asiatica nella Guerra di Corea (1950-1953)14. Altri ancora partono dal periodo successivo al conflitto coreano, quando la «frattura euro-germanico-asiatica» divenne matura e si avviò il processo di decolonizzazione, contraddistinto dallo scoppio della guerra di Algeria15.
Anche la suddivisione interna e la data di conclusione della Guerra fredda sono oggetto di dibattito. Bruno Bongiovanni, ad esempio, data la chiusura della Guerra attorno al 1975, ossia alla fine del periodo di “coesistenza pacifica” e della guerra del Vietnam. È allora che diviene evidente l’irreversibilità del contrasto sino-sovietico, nonché le ferite del bipolarismo imperfetto, o, come è stato definito da Ottavio Barié, «anomalo»16. La fase successiva al 1975 infatti – con Bongiovanni – contraddistinguerebbe non tanto la fine della guerra, quanto piuttosto dei “blocchi”. Date simboliche di questa progressiva disgregazione sono il 1989, appunto, e il 1991, quando venne sancita la dissoluzione dell’URSS.
Complessivamente, al di là del dibattito sulla periodizzazione, si può sostenere, con Barié, che: «ogni fase, d’altra parte, ha corposissimi momenti interni che smentiscono l’uniformità e la coerenza non solo di tutto l’arco cronologico, ma della fase stessa»17 e Twilight Struggle riesce a ricomporre in maniera piuttosto chiara questa lunga periodizzazione e suddivisione. Con le sue dinamiche il gioco ben riproduce l’apparente “gelo” dal punto di visto bellico il clima di costante tensione geopolitica, accompagnata dal timore per lo scoppio di un terzo conflitto mondiale. Questa tensione è resa vividamente dal gioco in diversi modi che ne consentono un efficace “mimetismo”, operazione fondamentale per la sua buona riuscita, anche al prezzo di tradire i fatti storici.
3. Sensazioni dal campo di battaglia tra tensione e mimesi
Abbiamo già menzionato il successo globale di Twilight Struggle. Capofila di questo fandom fu il co-fondatore della GMT, Gene Billingsley. Egli commentò la propria decisione di finanziare il titolo affermando che lo aveva «riportato alla sua infanzia»18; ma come può effettivamente un gioco da tavolo “riportare” indietro nel tempo il giocatore fino a restituirgli la sensazione della tensione che così profondamente ha segnato e la memoria di questo conflitto? È interessante soffermarsi a riflettere sulla funzione del gioco da tavolo moderno come strumento per interrogare il nostro sguardo sui fatti storici e la lettura che diamo di essi.
Spesso i regolamenti dei giochi ad ambientazione storica sono introdotti da una prefazione dell’autore in cui è presente una sinossi o una descrizione dell’ambientazione, e Twilight Struggle non fa eccezione. Queste descrizioni non forniscono semplici nozioni, ma tentano di restituire le sensazioni dell’epoca storica in cui le partite sono ambientate. Oltre alla sinossi, anche il design – l’insieme delle meccaniche che regolano il movimento del giocatore – ha un ruolo fondamentale nell’accompagnarlo indietro nel tempo per fare propri gli scopi, gli obiettivi e i desideri del personaggio che si sta incarnando.
Come sostiene Goffman, il coinvolgimento nel gioco è il risultato dell’appropriazione da parte del giocatore dei significati che esso veicola da un punto di vista “emico”19. I giocatori, divenuti “personaggi-giocanti” sono immersi nelle necessità dello spazio e del tempo storico del gioco. In altre parole, quando ci muoviamo nello spazio del gioco, «the body does not represent what it performs, it does not memorize the past, it enacts the past, bringing it back to life»20. Le azioni motivate da scopi e obiettivi del proprio personaggio permettono di rievocare le condizioni di uno spazio e di un tempo “altro”. La storia allora non è tanto trasmessa dal gioco al giocatore, ma piuttosto emerge dall’autentico coinvolgimento e dall’assunzione attiva da parte dei giocatori di una “parte”.
Questo non significa, ovviamente, che giocare alla guerra sia assimilabile a viverla; eppure, quando entriamo in gioco, ci immergiamo in un luogo ambiguo, dove i limiti della nostra realtà e quella vissuta dal carattere impersonificato diventano labili. Tuttavia, c’è una differenza sostanziale fra i fatti storici, di cui già conosciamo il decorso, e la partita che ci apprestiamo a giocare: le sorti dell’incontro ludico sono ancora tutte da scrivere.
Se, sedendoci al tavolo, sapessimo già che il giocatore “statunitense” vincerà, probabilmente ci alzeremmo dalla sedia senza nemmeno cominciare. Una partita a Twilight Struggle potrebbe, al contrario, terminare con una radicale riscrittura degli equilibri globali. L’esito della partita dipenderà dall’abilità del giocatore “statunitense” e di quello “sovietico” di far fronte alle sfide “della storia” e spostare le sorti della partita a proprio vantaggio.
Se, da una parte, il gioco ci permette di spaziare con l’immaginazione, dall’altra ci lega indissolubilmente al riferimento storico realmente avvenuto. In questo senso, il gioco storico porta con sé un grande potenziale didattico21. Come giocatori, siamo portati ad appassionarci, assieme con la sfida, al “mestiere di storico” e ad interrogarci su quale sia la “vera” storia della Guerra fredda. Poiché, come sottolinea Scanagatta, «il fatto [storico] non si presenta mai al futuro come puro, [ma] è sempre costituito da una costruzione narrativa»22.
Quello dell’equilibrio fra attendibilità e narrativizzazione storica appare dunque un falso problema, almeno nel mondo del gioco da tavolo, che necessariamente deve trovare un compromesso fra storiografia e meccaniche di gioco. Non sono infatti tanto – o, almeno, non solo – i contenuti nozionistici, quanto i significati profondi e le sensazioni a rimanere nell’esperienza del giocatore. È chiaro che da parte del giocatore ci sia una preferenza tematica che lo porta alla scelta di un titolo specifico (Guerra fredda, Impero romano, guerre puniche, ecc.), eppure la riflessione storiografica che il gioco da tavolo permette non si accontenta di convogliare un sapere nozionistico: piuttosto è volta alla condivisione e alla trasmissione di una conoscenza “esperienziale”.
La forza del gioco da tavolo non sta allora tanto nella potenzialità didattica (che comunque rimane), quanto in quella mimetica, ovvero nella capacità di trasportarci in mondi “altri”, piccoli laboratori controllati dove esercitarci alle complesse dinamiche della realtà.
Note
1 Sulla concettualizzazione “globale” della Guerra fredda si veda Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
2 «Now the trumpet summons us again – not as a call to bear arms, though arms we need – not as a call to battle, though embattled we are – but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, “rejoicing in hope, patient in tribulation” – a struggle against the common enemies of man: tyranny, poverty, disease and war itself». The Gilder Lehrman Institute of American History, https://www.gilderlehrman.org/ap-us-history/period-8?modal=/history-resources/spotlight-primary-source/john-f-kennedys-inaugural-address-1961, ultima consultazione: 21 gennaio 2025.
3 Per approfondire si veda Luciano Canfora, 1956. L’anno spartiacque, Palermo, Sellerio, 2008.
4 Ottavio Barié, Dalla guerra fredda alla grande crisi: il nuovo mondo delle relazioni internazionali, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 62.
5 Sulla complessità del crollo interno dell’URSS, si veda Stephen Kotkin, Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000, Oxford, Oxford University Press, 2008.
6 Su alcuni thread di blog specialistici si segnala però uno sbilanciamento a favore dell’URSS. Ad esempio, Board Game Geek, https://boardgamegeek.com/thread/902860/play-balance, ultima consultazione: 22 gennaio 2025.
7 Twilight Strategy, https://twilightstrategy.com/2012/10/19/muslim-revolution/, ultima consultazione: 21 gennaio 2025.
8 Twilight Strategy, https://twilightstrategy.com/2012/11/08/john-paul-ii-elected-pope/, ultima consultazione: 21 gennaio 2025.
9 Per un’analisi che dà conto di questa alleanza dal punto di vista cinese, si vedano Shen, Zhihua, and Yafeng Xia, Mao and the Sino–Soviet Partnership, 1945–1959: A New History, Lanham, Lexington Books, 2015.
10 Lorenz M. Lüthi, The Non-Aligned Movement and the Cold War, 1961–1973, in “Journal of Cold War Studies”, 2016, vol. 18, n. 4, pp. 98-147, p. 98.
11 Su questa svolta storiografica si veda: Odd Arne Westad (ed.), Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory, New York, Routledge, 2001.
12 Barié, Dalla guerra fredda alla grande crisi, cit., p. 62.
13 n breve, a partire dal marzo del 1947, gli Stati Uniti implementarono misure per contrastare le mire sovietiche sulla Grecia. Nello stesso periodo i ministri comunisti in Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo furono costretti a la- sciare le loro posizioni a causa delle accuse di conflitto d’interesse con le direttive provenienti dall’Unione Sovietica. Per un’analisi più approfondita e di taglio globale si veda Martin McCauley, Origins of the Cold War 1941–1949, London, Routledge, 2021.
14 Ad esempio, l’analisi sul movimento femminista internazionale di Suzy Kim, The Origins of Cold War Feminism During the Korean War, in “Gender & History”, 2019, vol. 31, n. 2, pp. 460-70.
15 Tra gli altri Bruno Bongiovanni, Storia della guerra fredda, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 11-20.
16 Barié, Dalla guerra fredda alla grande crisi, cit., p. 8.
17 Ivi, p. 16.
18 Michael J. Gaynor, They created maybe the best board game ever. Now, Putin is making it relevant again, in “The Washington Post”, July 17, 2018, https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/the-cold-war-themed-board-game-that-feels-more-relevant-than-ever/2018/07/16/45be9be4-7a4e-11e8-93cc-6d3beccdd7a3_story.html.
19 Erving Goffman, Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction, Harmondsworth and Ringwood, Penguin Books, 1972, p. 71.
20 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, Stanford, Stanford University Press, 1990, p. 73.
21 Sul tema si veda il recente articolo di Gian L. Gonzato, Igor Pizzirusso, Giorgio Uberti, Stefania Cogliani, Giochi storici e didattica ludica: il caso dell’urban game “La profezia di Adolfo Venturi”, in “Didattica della storia”, 2024, vol. 6, n. 1, pp. 57-76.
22 Manfredi Scanagatta, Public History e diffusione sociale della storia: la fotografia come fonte privilegiata, in “Rivista di studi di fotografia”, 2017, n. 5, pp. 30-51, p. 36.