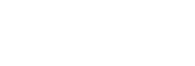In apertura: fermo immagine tratto dal videogioco Call of Duty: WWII (Activision, 2017).
1. Introduzione
Nel videogioco storico il passato è reso attuale grazie alla creazione di un contesto storicamente dettagliato – sia pur in forma romanzata – che trasforma il giocatore da semplice osservatore a protagonista di una storia rappresentata, o meglio simulata, in toni epici1. Si pensi ad esempio a quegli sparatutto di tema bellico, che si concentrano su un livello di scala che segue il percorso individuale di un singolo soldato o, tutt’al più, di un piccolo nucleo combattente. La storia supera in tal modo la disgiunzione temporale tra le figure storiche2, gli ambienti ed i contesti realizzando quello che si può definire un «anacronismo creativo», vale a dire uno scollamento che viene percepito criticamente dal giocatore solo nella misura in cui egli conosca nel dettaglio le associazioni storiche tra eventi e protagonisti3. L’intreccio con il cinema, o la sua diretta derivazione, contribuisce a consolidare tale caratteristica. Molti sparatutto di guerra sono prodotti come spin-off di film di successo: Salvate il soldato Ryan (Spielberg, 1998), ad esempio, ispira titoli di successo come Call of Duty 2, Medal of Honor, Brothers in Arms, Battlefield 1942 e ciò contribuisce a validare come prodotti storici anche sequel di quegli stessi titoli che meno hanno invece a che fare con una rappresentazione “realistica” della storia. Secondo la teoria della persuasione narrativa esiste uno stretto rapporto tra l’utilizzo di un mezzo narrativo e la trasmissione di credenze circa il contenuto della storia. Un fattore centrale di questo processo è il grado di realismo: perché la persuasione avvenga deve esservi coerenza tra la storia rappresentata e la realtà storica4.
2. Narrazione credibile
I videogiochi basati sui conflitti militari, spesso event-driven5, producono ricostruzioni molto dettagliate, con una prospettiva in prima persona che proietta l’utente in una dimensione immersiva di cui diviene testimone oculare6. Nelle simulazioni il giocatore è l’artefice di un sistema complesso di relazioni e il modo in cui interagisce con esse è perfino più importante del legame stretto con i suoi avatar7.
Un elemento caratteristico di questa tipologia di giochi è l’uso di filmati cinematografici per sottolineare lo status “storico” della trama, contribuendo ad esplicitare la chiave interpretativa che vi soggiace. Questo fenomeno è particolarmente osservabile nei videogiochi altamente politicizzati e connessi anzitutto alla Seconda guerra mondiale ma anche alle relazioni internazionali dell’oggi8. Si pensi, ad esempio, alle censure compiute da Cina, Russia e Venezuela su alcuni prodotti, rispettivamente Battlefield 4 (Digital Illusions Creative Entertainment, 2013), Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009) e Mercenaries 2: World in Flames (Pandemic Studios, 2008), che presentando questi paesi quali nemici della civiltà occidentale sarebbero viziati da un «cultural encroachment»9. La presenza di un nemico è insita nella definizione stessa degli sparatutto in prima persona10 e alimenta quel meccanismo paradossale per cui le società hanno bisogno di identificare un nemico ma al tempo stesso non lo vorrebbero poiché lo temono11. Le missioni di gioco cercano quindi di appianare il dissidio interno fornendo un nemico al giocatore12 e chiedendogli di eliminarlo per ristabilire l’ordine. Da qui le molte accuse mosse a quei videogiochi di guerra ambientati in un presente fittizio per la loro capacità di influenzare i giocatori sia negli schieramenti13 sia, soprattutto, nell’esaltazione della violenza come mezzo di risoluzione delle controversie14.
3. La Seconda guerra mondiale sullo schermo
Emblematica della Greatest Generation15, la Seconda guerra mondiale diviene dagli anni Novanta del secolo scorso uno dei temi principali degli sparatutto in prima persona, soprattutto nelle produzioni statunitensi: basti pensare che tra il 1992 e il 2011 questa ambientazione domina nel 62% dei videogiochi realizzati16. Se nel cinema hollywoodiano tale epoca viene presentata nei caratteri epici dello scontro tra bene e male, i videogiochi adattano tale substrato culturale per enfatizzare l’immagine di una “guerra giusta”, combattuta per impedire al nemico di soggiogare il mondo17. Il videogioco, rispetto al film, consente un rapporto differente con la storia, ponendo il giocatore quale parte attiva del mito contemporaneo sulla Seconda guerra mondiale18.
I film di guerra ruotano attorno a un conflitto tra soldati (nemici, commilitoni o soldati vs ufficiali), presentando narrazioni in cui può capitare di trovarsi nella situazione di sacrificare la propria vita per il successo collettivo, tanto che gran parte delle scene è dedicata a discorsi sulla patria, la fratellanza sotto le armi e i valori per cui si combatte; si assiste a un mix di emozioni che spazia dalla frustrazione dell’attesa e dell’addestramento, all’euforia per il fronte e al terrore del combattimento19. Queste dinamiche strutturali sono invece assenti nei videogiochi. Al contrario, l’attenzione è rivolta all’azione e al combattimento20. Dunque, la prima grande differenza con i film è che, mentre in questi si assiste a un crescendo di tensione che culmina in un combattimento, nel videogioco ogni scontro armato è un “last stand”. In altre parole, nel film il significato si costituisce nei rapporti tra scene di azione e di dialogo, riflessione o introspezione. Nel videogioco, invece, vi è un solo percorso di significato: l’azione. Le riflessioni causa-effetto hanno un impatto minimo sul completamento del gioco e per tale motivo spesso questi prodotti, soprattutto quelli di maggior diffusione, incontrano la critica degli storici professionisti21.
Il successo degli Alleati torna costantemente in tutte le componenti del mondo di gioco, predisposto per esaltare la sconfitta nazista. Negli ultimi anni vi è molta attenzione da parte degli sviluppatori per ricreare nel miglior modo possibile ambientazioni verosimili, se non addirittura realistiche: uniformi militari, mezzi di trasporto, armi e abitazioni sono studiate in ogni minimo dettaglio per catapultare il giocatore nell’epoca di riferimento22. Il contesto, più che la trama, diventa centrale nella realizzazione di un valido gameplay, poiché quest’ultimo dipende in primo luogo dal mondo di gioco23. La ripetizione di precisi elementi riflette la conoscenza degli eventi bellici così come viene presentata dai manuali scolastici, ma la inserisce nella simulazione di tiro tipica del genere sparatutto. In tal modo i videogiochi sulla Seconda guerra mondiale creano quello che viene descritto come senso di padronanza – poiché si conosce l’evento e il suo esito – e controllo – poiché il giocatore si impone armi in pugno garantito nel successo dalle dinamiche interne24. I checkpoint e i cicli di morte e rinascita (respawn) propri degli sparatutto in prima persona sono elementi essenziali, che rimarcano un messaggio implicito di questi giochi: «the characteristic act of men at war is not dying, it is killing»25. Nel caso del videogioco la storia è resa interattiva, ma salvo rare eccezioni è ancora predeterminata. Il successo o il fallimento delle missioni non può essere cambiato e non dipende dalle azioni del singolo giocatore: poiché le ferite possono essere rapidamente sanate e la morte non è mai definitiva, il giocatore ha possibilità illimitate (e inevitabili) di successo. Per questo motivo, il fallimento non rappresenta mai una vera minaccia. Inoltre, i giochi sulla Seconda guerra mondiale prendono, con rare eccezioni, il punto di vista degli Alleati. I titoli concettualizzano in modo netto il nemico da combattere e annientare. Lungi dal voler decostruire l’immagine idealtipica del nemico, come avviene invece sempre più spesso nelle produzioni ambientate nel presente, non vi è spazio per equivoci o differenti prese di posizione: le uniche associazioni possibili sono alleati-buoni e nazisti-cattivi26. L’ambientazione bellica 1940-1945 si impone nella coscienza collettiva, soprattutto americana, come una “mythical ‘just war’” nella quale il giocatore si sente legittimato ad eliminare il nemico senza provare alcun senso di colpa poiché è percepito, nella lista dei cattivi, alla stregua di robot e zombie27: lo scopo finale è la vittoria totale, o noi o loro.
Un’altra strategia di autenticazione storica messa in campo dagli sviluppatori è il ricorso a mappe o brevi filmati di guerra introdotti da datazioni topiche e croniche molto precise e inseriti come intermezzo tra le missioni oppure nelle fasi di caricamento del gioco. Queste sequenze, solitamente brevi per non annoiare lo spettatore, ricalcano lo stile dei cinegiornali dell’epoca e hanno la doppia funzione di validare la storicità della trama e di aggiornare il giocatore sugli sviluppi della guerra tra una campagna e l’altra, spesso cronologicamente distanti. Solitamente si tratta di video riprodotti in bianco e nero, in modo tale da collocare in modo anche visuale la trama in un passato remoto, che diviene però estremamente presente nel momento in cui il video termina, la scena riacquista colori vividi e il giocatore riprende le redini del gioco. Si costituisce quindi una particolare tipologia di rapporto tra gioco e mediazione del passato: «[p]lay in and with a reconstruction of historical temporality drawn from the narrative modes of more traditional media such as historical discourse, historical archives, war films and documentaries»28.
Tra i molti titoli disponibili, due sono gli assoluti protagonisti di questo genere, dominando su pc, console e dispositivi mobili: Medal of Honor e Call of Duty.
Medal of Honor (MoH) esce per la prima volta nel 1999 e viene sviluppato in contemporanea con le riprese de Salvate il soldato Ryan di Spielberg che collabora direttamente con gli sviluppatori e di cui si riconoscono i molti debiti tanto nella trama quanto nella regia (saturazione, musiche e inquadrature). Come nel film, infatti, l’utente segue da vicino le missioni di una piccola squadra di soldati il cui punto di partenza, lo sbarco a Omaha Beach, riprende fedelmente la celebre sequenza cinematografica. Lo scopo è creare empatia tra i protagonisti sullo schermo e l’utente, contrariamente alle dinamiche strategiche, con prospettiva dall’alto, fino ad allora dominanti nelle serie “storiche” sullo stesso periodo e solo poco prima rivoluzionate da un altro titolo di successo: Wolfenstein 3D (ID Software – Activision, 1992). MoH ha quindi il merito di introdurre la componente emotiva negli sparatutto sulla guerra mondiale, missione dichiarata nel retro di copertina in occasione dell’uscita del capitolo Frontline (2002): «You don’t play. You Volunteer».
Call of Duty (CoD) inizia la fortunata serie nel 2003 dagli stessi sviluppatori di Medal of Honor che, staccatisi da Electronic Arts a seguito di malcontenti, fondano Infinity Ward per proseguire in autonomia alla realizzazione di un gioco nuovamente ambientato durante la Seconda guerra mondiale. A differenza di MoH, CoD alterna il ruolo del giocatore con tre diversi personaggi tramite cui si cerca di rendere al meglio il significato di guerra totale: il soldato Joe Martin (paracadutista americano della 101ª Divisione aviotrasportata), il sergente Jack Evans (paracadutista britannico della 6ª divisione aviotrasportata) e il soldato Alexei Ivanovich Voronin (giovane coscritto dell’Armata Rossa)29.
Il 2003 vede uscire in contemporanea ben 23 titoli ambientati nella Seconda guerra mondiale, ma si tratta ancora per la maggior parte di giochi strategici con l’unica eccezione di MoH: Rising Sun. Visto il grande successo riscontrato dal primo capitolo, nonostante il piano di progettazione originale preveda di passare a un’ambientazione contemporanea, anche Call of Duty 2 e 3, così come le relative espansioni e spin-off, mantengono il focus sugli anni 1940-1945. Il mutamento tematico viene provato nel 2007, con Call of Duty 4: Modern Warfare, ma la popolarità dei precedenti è tale da costringere a tornare sui propri passi per Call of Duty: World at War (2008), ampliando però il panorama di gioco con missioni nell’oceano Pacifico. Come già visto in altri casi, anche qui alcune sequenze sono mutuate da film di successo e, in particolare, la cutscene iniziale della campagna a Stalingrado riprende l’inizio di Enemy at the Gates (Annaud, 2001). Tra le novità vi è l’introduzione dello scenario del Pacifico come arena di guerra, non relegata a teatro di scontri aerei o navali30. Nel nuovo capitolo, CoD pone quindi l’accento sulle azioni dei marines per conquistare diverse isole strategiche come Guadalcanal, Peleliu o Iwo Jima. Hank Keirsey, tenente colonnello americano e consigliere storico31 di World at War, sintetizza la nuova linea narrativa: «Nobody knows how brutal and tough and gritty and demanding and environmentally challenging the fight in the Pacific theatre was»32. Non è un caso, infatti, che il giocatore inizi la sua avventura sull’isola di Makin il 17 agosto 1942 come prigioniero di guerra, impotente di fronte alla brutale esecuzione di alcuni compagni, prima di essere tratto in salvo.
4. Conclusioni
Partendo dal presupposto che titoli di questo tipo siano in primo luogo degli sparatutto di intrattenimento e solo secondariamente narrazioni storiche sulla Seconda guerra mondiale, non si può ignorare che essi rappresentino uno dei principali canali di informazione storica su quell’epoca, insieme a film e serie tv, per un numero consistente di adolescenti e giovani adulti e ciò apre a due ulteriori problematiche.
Da un lato le memorie dei veterani, dalla Prima guerra mondiale fino al Vietnam, rilevano con continuità un «piacere di uccidere»33. Ciò non provoca sconvolgimenti per quanto riguarda la parte nazista, già narrata nei termini di barbarie, sadismo e perversione. Tali questioni, tuttavia, creano problemi di coscienza nel momento in cui applicate anche alla fazione vincitrice34. In altre parole, l’idea che la guerra e le sue violenze possano essere anche divertimento per i soldati è un aspetto che difficilmente si coniuga con la narrazione più tradizionale di soldati-eroi che sacrificano la vita in nome della libertà e della democrazia.
Dall’altro lato, le dinamiche in termini di ambientazioni, protagonisti e antagonisti mostrano che gli sparatutto in prima persona, seppur prodotti per il mercato internazionale, presentano una storia prevalentemente occidentale. Lo sviluppo di sempre più giochi riferiti a guerre moderne mostrano un’importante differenza con il passato: mentre con le guerre storiche i “buoni” intervengono su molti fronti globali, il tema del terrorismo sposta l’attenzione all’interno dei propri confini e a una minaccia portata da agenti esterni alla sicurezza dell’Occidente. Si passa quindi dal giocare trame di cui si conoscono già tutti i dettagli della loro risoluzione ad un futuro prossimo potenziale, fittizio ma verosimile35. Non vi è alcun dubbio che il lungo conflitto aperto dalla Russia in Ucraina, insieme con le narrazioni consolidate sulla sua reputazione internazionale, avrà sempre più ripercussioni anche sulle scelte videoludiche, già in parte orientate in quella direzione. Si può quindi affermare che la scelta circa gli antagonisti avrà conseguenze sulla percezione del mondo da parte degli utenti fornendo ad oggi alcune tra le direttive socio-culturali più pervasive.
Note
1 Cfr. Lucia Ricciardelli, Visual Culture and the Crisis of History: American Documentary Practice in the Postmodern Era, Ph.D. dissertation, University of California, Santa Barbara, 2007.
2 Cfr. Agata Meneghelli, Time out: come i videogiochi distorcono il tempo, Padova, Libreriauniversitaria.it, 2013.
3 Cfr. Barry Atkins, La storia è un’assurdità: Civilization come esempio di barbarie storiografica, in Matteo Bittanti (a cura di), Civilization: Storie virtuali, fantasie reali, Milano, Videoludica, 2005, pp. 65-81.
4 Cfr. Alfie Bown, The Playstation Dreamworld, Hoboken, John Wiley and Sons Ltd, 2017.
5 Cfr. Jessie C. Herz, Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Minds, London, Abacus, 1997.
6 Si pensi a titoli come Battle of the Bulge o Versailles 1685. Cfr. Hamelin Associazione Culturale (a cura di), Videogiochi: un altro modo di raccontare, Bologna, Hamelin Associazione Culturale, 2020.
7 Cfr. Gonzalo Frasca, Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology, in Mark J.P. Wolf, Bernard Perron (eds.), The Video Game Theory Reader, New York, Routledge, 2003, pp. 221-235.
8 Cfr. Matteo Bittanti (a cura di), Reset: politica e videogiochi, Milano, Mimesis, 2023. Tra i videogiochi politicizzati che si discostano dal periodo bellico si trovano alcuni titoli su temi ancora dibattuti della storia statunitense come JFK Reloaded, Waco Resurrection o 9/11 Survivor.
9 Cfr. Tom Apperley, Gaming Rhythms: Play and Counterplay from the Situated to the Global, Amsterdam, Institute of Network Cultures, 2010.
10 Cfr. Brandon Valeriano, Philip Habel, Who Are the Enemies? The Visual Framing of Enemies in Digital Games, in “International Studies Review”, vol. 18, n. 3, 2016, pp. 462-486.
11 Cfr. Nick Robinson, Videogames, Persuasion, and the War on Terror: Escaping or Embedding the Military-Entertainment Complex?, in “Political Studies”, vol. 60, n. 3, 2012, pp. 504-522; Kenneth Mulligan, Philip Habel, The Implications of Fictional Media for Political Beliefs, in “American Politics Research”, vol. 41, n. 1, 2013, pp. 122-146.
12 Cfr. James P. Klein, Gary Goertz, Paul Diehl, The New Rivalry Dataset: Procedures and Patterns, in “Journal of Peace Research”, vol. 43, n. 3, 2006, pp. 331-348.
13 Si pensi ai titoli pubblicati dopo l’11 settembre 2001. Cfr. Vit Sisler, In Videogames You Shoot Arabs or Aliens – Interview with Radwan Kasmiy, in “Umelec International”, vol. 10, n. 1, 2006, pp. 77-81; Id., Digital Arabs: Representation in Video Games, in “European Journal of Cultural Studies”, vol. 11, n. 2, 2008, pp. 205-219; John Sides, Kimberly Gross, Stereotypes of Muslims and Support for the War on Terror, in “American Journal of Political Science”, vol. 75, n. 3, 2013, pp. 583-598.
14 Cfr. Frederick Gangnon, ‘Invading Your Hearts and Minds’: Call of Duty® and the (Re)riting of Militarism in U.S. Digital Games and Popular Culture, in “European Journal of American Studies”, vol. 5, n. 3, 2010; Niall Ferguson, How to Win a War, in “New York Magazine”, 15 ottobre 2006. https://nymag.com/news/features/22787/, ultima consultazione di tutti i link: 19 giugno 2025., ultima consultazione di tutti i link: 19 giugno 2025.
15 Il termine viene coniato da Tom Brokaw per indicare quella generazione che vede positivamente la partecipazione ad una “guerra giusta”. Cfr. Tom Brokaw, The Greatest Generation, New York, Random House, 1998.
16 Cfr. Johannes Breuer, Ruth Festl, Thorsten Quandt, In the Army Now. Narrative Elements and Realism in Military First Person Shooters, 2011, http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/11307.54018.pdf.
17 Cfr. Tanine Allison, The World War II Video Game, Adaptation, and Postmodern History, in “Literature/Film Quarterly”, vol. 38, n. 3, 2010, pp. 183-193.
18 Cfr. Laurie N. Taylor, Zach Whalen, Playing the Past: History and Nostalgia in Video Games, Nashville, Vanderbilt University Press, 2011.
19 Jeanine Basinger, The World War II Combat Film: Anatomy of a Genre, Middletown, Wesleyan UP, 2003.
20 Invece di affrontare zombie (es. Resident Evil), scontrarsi con specie aliene (es. Halo) o sopravvivere a demoni (es. Doom), il giocatore combatte i nazisti. Cfr. Mike Schmierbach, Content analysis of video games: Challenges and potential solutions, in “Communication Methods & Measures”, vol. 3, n. 3, 2009, pp. 147-172.
21 Cfr. Jerome de Groot, Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture, Oxon, Routledge, 2009.
22 Un fenomeno con ricadute anche sociali nel panorama statunitense è la cosiddetta fetishization of weaponry, ossia l’interesse dei giocatori per le armi di gioco e la loro letalità. Cfr. Ed Halter, From Sun Tzu toXbox: War and Video Games, New York, Thunder’s Mouth Press, 2006, p. 258.
23 Cfr. Debra Ramsay, Brutal Games: Call of Duty and the Cultural Narrative of World War II, in “Cinema Journal”, vol. 54, n. 2, 2015, pp. 94-113.
24 Cfr. Joel Penney, No Better Way to ‘Experience’ World War II, in Nina B. Huntemann, Matthew T. Payne (eds.), Joystick Soldiers: The Politics of Play in Military Video Games, New York, Routledge, 2010, pp. 191-205.
25 Joanna Bourke, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth Century Warfare, New York, Basic Books, 1999, p. XIII.
26 In uno studio condotto su più di 60 videogiochi, i dati mostrano che i nazisti spiccano con il 28.8%, seguiti a distanza dai russi (15.9%). Cfr. Johannes Breuer, Ruth Festl, Thorsten Quandt, In the Army Now. Narrative Elements and Realism in Military First Person Shooters, 2011, http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/11307.54018.pdf.
27 Scott Sharkey, Why WWII? A Look at Videogames and Wars of the 20th Century, 1UP, http://www.Iup.com/do/feature?cld=3175558.
28 Patrick Crogan, Gametime: History, Narrative, and Temporality in Combat Flight Simulator 2, in Mark J.P. Wolf, Bernard Perron (eds.), The Video Game Theory Reader, New York, Routledge, 2003, pp. 275-301, p. 282.
29 Tra le maggiori novità introdotte dalla dispersione narrativa su tre diversi scenari e altrettanti protagonisti vi è il venir meno dell’eroismo individuale a favore di una causa comune. Il giocatore non riesce infatti a potenziare l’equipaggiamento del suo avatar rendendolo invincibile, poiché costretto dalle dinamiche di gioco a spendere risorse su più avatar simultaneamente.
30 Una delle poche eccezioni è data da MoH: Rising Sun, nel quale tuttavia questa ambientazione è scelta come sottofondo di missioni di spionaggio più che di azioni militari vere e proprie.
31 Cfr. C. Richard King, David J. Leonard, Wargames as a New Frontier: Securing American Empire in Virtual Space, in Nina B. Huntemann, Matthew T. Payne (eds.), Joystick Soldiers: The Politics of Play in Military Video Games, New York, Routledge, 2010, pp. 91-105.
32 Kim Richards, Hank Military-Man, in “CVG Presents Call of Duty”, Computer and Video Games special issue, 2008, n. 4, pp. 50-55: 53.
33 Joanna Bourke, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth Century Warfare, New York, Basic Books, 1999.
34 Cfr. Glenn Gray, The Warriors, Lincoln, University of Nebraska Press, 1998.
35 Cfr. Josh Smicker, Future Combat, Combating Futures. Temporalities of War Video Games and the Performance of Proleptic Histories, in Huntemann, Payne (eds.), Joystick Soldiers, cit., pp. 106-121.