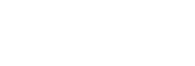In apertura: un momento della marcia dei quarantamila avvenuta a Torino il 14 ottobre 1980 (da Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org).
1. Premessa
Un contesto non accademico – la relazione introduttiva tenuta in occasione del direttivo regionale di Apiqa Cgil Emilia-Romagna1 – ha fornito l’occasione per riflettere su un tema cruciale nella storia dei movimenti politici e sociali in età contemporanea. Il punto di partenza è una data periodizzante, il 14 ottobre 1980, a Torino. Il problema della rappresentanza dei quadri entra con forza nel dibattito sindacale italiano e, più in generale, nel dibattito pubblico del nostro paese solo allora. Ci volle la «marcia dei quarantamila» organizzata da Luigi Arisio e dal Coordinamento dei capi e quadri Fiat: quel giorno impiegati e quadri dell’industria torinese insieme a commercianti, professionisti e altri cittadini del ceto medio scesero in piazza per esprimere il loro sostegno all’azienda contro le rivendicazioni operaie. Si era nel pieno della drammatica vertenza sindacale dei 35 giorni ai cancelli di Mirafiori contro le migliaia di licenziamenti annunciati da Fiat2.
Se è vero che le trasformazioni sociali ed economiche avviatesi tra anni Settanta e Ottanta del Novecento ebbero conseguenze rilevanti per il tema al centro di questo contributo, tuttavia la più ampia questione della rappresentanza politica e sociale dei ceti medi – di cui i quadri rappresentano una componente – è problema molto più risalente nel tempo e inizia a porsi nelle società europee tra fine del XIX e inizio del XX secolo. Storicamente, si tratta di un aspetto decisivo per lo sviluppo della democrazia rappresentativa e per il suo stato di salute. Questa è la cornice di lungo periodo nella quale si colloca la riflessione qui proposta.
2. Il nuovo protagonismo dei quadri e la crisi del lavoro operaio
L’emergere dei «quadri intermedi» in Italia viene fotografato con efficacia nel 1981 dalla relazione annuale del Censis, il centro studi diretto da Giuseppe De Rita. Vale la pena citare un passaggio di questo rapporto, che consente di definire l’oggetto dell’analisi:
Le persone che nelle aziende industriali o commerciali e più in generale nelle strutture di lavoro organizzate ricoprono posizioni di coordinamento e di responsabilità gerarchica o professionale, disponendo di margini più o meno ampi di autonomia ed esercitando poteri più o meno ampi di mediazione, sono ormai una porzione non trascurabile della forza lavoro e soprattutto sono in numero crescente3.
Il nuovo protagonismo dei quadri e la crisi del lavoro operaio erano una conseguenza dei profondi mutamenti economici in atto: per un verso, a livello macroeconomico, la perdita di rilevanza del settore industriale e la crescita dei servizi, dall’altro, a livello d’impresa, l’impatto della rivoluzione informatica e microelettronica. Stavano assumendo crescente valore strategico, nel ciclo produttivo complessivamente considerato, i segmenti della progettazione/ricerca, del marketing e degli studi di mercato.
L’analisi di questi aspetti venne approfondita dalla relazione di apertura tenuta nel 1987 da Rosario Trefiletti, responsabile dell’Ufficio quadri e tecnici della Cgil, al convegno nazionale dedicato alle alte professionalità nel sindacato, nell’impresa e nella società4. Si trattava del quarto appuntamento, tra convegni e seminari, dedicato ai quadri intermedi dalla Cgil nel giro di una manciata di anni, a conferma di una riflessione difficile, a tratti caotica, ma indubbiamente utile per impostare le linee di indirizzo di quella che doveva essere una nuova stagione del sindacato.
Nel convegno del 1987 le conclusioni vennero tracciate dal segretario confederale Fausto Vigevani5. Vale la pena ricordarlo perché lo stesso Vigevani due anni prima, nel 1985, aveva firmato l’introduzione a un utile librettino pubblicato da Ediesse dal titolo Tecnici, ricercatori, quadri e sindacato (un testo che conteneva tra gli altri interventi di Claudio Sabattini e Antonio Pizzinato). Ebbene, in quelle pagine introduttive, Vigevani non aveva fatto sconti alla sua organizzazione. La questione della rappresentanza dei quadri era ancora irrisolta e, riflettendo sui ritardi della Cgil e del sindacato, egli scriveva:
Che cosa impedisce di affrontare e conoscere il problema posto da questi lavoratori? C’è un retaggio antico che individuava nei quadri il braccio del padrone, c’è il timore che il baricentro del sindacato si sposti su queste figure abbandonando quelle che hanno fatto la storia e la forza del sindacalismo industriale e, in Italia, del sindacato tout-court. […] Eppure, cercare di capire i problemi di queste figure, da quelli retributivi a quelli ben più importanti delle loro funzioni, della loro autonomia, della loro professionalità, è ormai problema indilazionabile se il sindacato vuole recuperare rappresentatività, peso e ruolo nelle aziende e nel paese. […] Non si tratta di sostituire nuove figure ad altre. Si tratta di voler essere sindacato di tutti i lavoratori. Si tratta di abbandonare approcci e idee che non hanno basi reali nella realtà che cambia, ma solo supporti in obsolete visioni ideologistiche [sic] e strumentali6.
Sempre nel 1985, la Fiom del Lazio organizzò ad Ariccia un seminario dedicato a Le alte professionalità nell’impresa7. Nel corso dei lavori ci si tornò a interrogare sul significato della «marcia dei quarantamila», vissuta indubbiamente come un evento periodizzante, e Fausto Sabbatucci della Cgil nazionale proponeva questa risposta:
Cosa significava quella marcia? Anzitutto una cosa molto precisa, l’insoddisfazione di un certo ceto sociale per come stavano andando le cose e per come si comportava e si era comportato il sindacato negli anni precedenti. […] Infatti, un grosso rilievo nella strategia del sindacato avevano sia la scala mobile a punto unico, sia la contrattazione nazionale con aumenti salariali uguali per tutti. Questi due fatti uniti a un sistema fiscale fortemente progressivo avevano determinato una progressiva riduzione del reddito dei lavoratori più altamente professionalizzati, e certamente questa era una delle cause della crescente disaffezione di questi lavoratori nei confronti del sindacato8.
Per rinnovare le strategie rivendicative del sindacato era allora indispensabile mettere in atto le decisioni prese dal convegno nazionale della Cgil che si era svolto a Roma pochi mesi prima9 e cioè: 1) creare coordinamenti dei quadri a livello regionale e 2) affiancare ai consigli di fabbrica organismi rappresentativi dei quadri che avessero il potere di decidere sulle parti delle piattaforme e degli accordi che direttamente li riguardavano10. Si riprendeva qui un’intuizione di Bruno Trentin risalente ai primi anni Ottanta: la necessità di prevedere nei consigli una presenza di tecnici, quadri, ricercatori, progettisti «per fare in modo – secondo le parole dello stesso Trentin – che questa operazione di recupero di rappresentanza del sindacato coincida con il riconoscimento di prerogative decisionali»11.
Gli atti del seminario Fiom di Ariccia, a cui si faceva riferimento poco fa, vennero pubblicati l’anno successivo (nel 1986) in un volumetto delle edizioni Datanews. Da notare che quella pubblicazione era arricchita da una conversazione di Barbara Pettine della Fiom Lazio con Corrado Rossitto, presidente di Unionquadri, una delle più importanti associazioni autonome di quadri, fondata nel 197512. Unionquadri era nata in un’area politica vicina alla Democrazia cristiana e ai partiti di centro, la sua gestazione era avvenuta intorno alla rivista “Giovani quadri” che si pubblicava dal 1973, il primo numero della quale era stato presentato a Roma da Giulio Andreotti.
Il dialogo tra la funzionaria della Fiom e il presidente di Unionquadri partiva dalla legge 190 del 1985 che riconosceva, con forte ritardo rispetto ad altri paesi europei, la figura del quadro demandandone la precisa definizione alla contrattazione collettiva tra le parti. Ma i passaggi più interessanti di quel confronto erano altri. Rossitto, in particolare, ebbe buon gioco nel sottolineare la crisi dei grandi soggetti collettivi, e soprattutto dei sindacati, che si stava manifestando negli anni Ottanta. Una perdita di consensi da cui discendeva anche la crisi di quella che egli definiva «cultura della conflittualità» (nella quale rientrava lo strumento dello sciopero) e un ridimensionamento dell’importanza del contratto collettivo, rispetto al quale Rossitto auspicava che si andasse verso un «ampliamento delle modalità informali, talvolta personalizzate, della regolamentazione del rapporto di lavoro». Per favorire la mobilità di carriera, proseguiva Rossitto, andavano istituiti «contratti integrativi individuali» a partire da griglie concertate tra aziende e associazioni professionali. Del resto, insisteva il presidente di Unionquadri, in Germania già da tempo esisteva il «contratto interamente individuale per i quadri»13.
3. L’organizzazione dei quadri in Italia e in Europa tra declino del sindacato e transizione post-fordista
Indubbiamente, ormai da alcuni anni, Cgil, Cisl e Uil stavano perdendo iscritti e si cominciava a profilare un’esigenza, poi sempre più acuta, di recupero di rappresentanza (tema evocato tra i primi da Bruno Trentin, come si è visto). A questo proposito, ampliando lo sguardo sul mondo sindacale oltre i perimetri della Cgil, è opportuno dedicare attenzione alle osservazioni espresse sempre in quel periodo, i primi anni Ottanta, da Giorgio Benvenuto, segretario generale della Uil, che per spiegare la crisi di rappresentatività del sindacato usava un’immagine mitologica: «Il sindacato è come Icaro che nel suo volo verso il sole a un certo punto perde le ali e precipita. Ecco, il sindacato sta perdendo le ali del consenso: da una parte di quello dei giovani disoccupati, degli emarginati, dall’altra di quello dei tecnici, degli impiegati, dei quadri»14. C’era, in queste parole, la consapevolezza della crisi del sindacato, non ancora la piena coscienza di uno dei fattori che nei decenni successivi avrebbero minato maggiormente la rappresentatività del sindacato, ovvero la crescente precarietà del lavoro15.
Sull’esigenza di tener presente i mutamenti sociali e del lavoro legati alla transizione post-fordista insisteva in quegli anni con particolare forza la Cisl, forte della consapevolezza di aver rappresentato dal dopoguerra in avanti un elevato numero di quadri e di tecnici16 e per questo poco propensa – per certi versi meno della Cgil – ad assecondare la diffusione di associazioni autonome di quadri che, tra anni Settanta e Ottanta, si stavano moltiplicando nel paese. Si riteneva, infatti, che la proliferazione di associazioni settoriali e d’impresa che rivendicavano un ruolo autonomo dalle confederazioni sindacali nella rappresentanza e contrattazione per l’area quadri avrebbe finito per indebolire ulteriormente l’azione sindacale.
Nel 1984 la Cisl promuoveva la pubblicazione con le Edizioni Lavoro di uno studio comparato sull’organizzazione sindacale dei quadri intermedi in Italia e in Europa occidentale, affrontando le questioni relative a ruolo, status, retribuzioni, contratti17. Il quadro interpretativo relativo agli anni Ottanta, valido per tutte le economie avanzate a livello internazionale, era quello relativo alla fine della centralità operaia, al declino della grande industria fordista, alla riduzione delle adesioni e dei consensi al sindacato, all’aumento del tasso di terziarizzazione delle attività economiche e all’introduzione di nuove tecnologie (automazione, robotica, informatica con il conseguente superamento tecnologico del taylorismo). Veniva poi dedicata un’attenzione particolare al caso di studio della Terza Italia: lo sviluppo della piccola e media impresa e la sua diffusione sul territorio, come esempio di tessuto economico che riusciva a resistere alla deindustrializzazione18.
Ma ai fini del tema qui affrontato, la parte più interessante dello studio della Cisl era quella da cui emergeva il ritardo italiano per quanto riguardava la rappresentanza sociale dei quadri. Un movimento dei quadri aveva cominciato a prendere piede in alcuni paesi europei dopo la Seconda guerra mondiale, a partire dalla Francia, dove già a metà degli anni Quaranta i cadres avevano uno “status” giuridico riconosciuto e pertanto forme di rappresentanza distinte rispetto a operai e impiegati. Nell’ottobre 1944 a Parigi era sorta la Confédération générale des cadres, un’organizzazione sindacale che rappresentava solo i quadri. Negli anni successivi erano sorte organizzazioni di rappresentanza dei quadri legate alle centrali sindacali tradizionali, ma sempre dotate di specificità e autonomia19.
Nella Germania federale la prima organizzazione sindacale dei quadri era nata nel 1950 (Ula – Union der leitenden angestellten) e aveva ottenuto dal parlamento (Bundestag) il riconoscimento della categoria. Tra anni Cinquanta e Sessanta organizzazioni di rappresentanza dei quadri si erano poi diffuse in Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Lussemburgo.
In Italia qualcosa cominciò a muoversi solamente tra fine anni Sessanta e primi anni Settanta, quando in alcune grandi aziende (ad esempio, Montedison e Alfa Romeo) i quadri si resero conto che in altri paesi europei erano già operanti normative e riconoscimenti giuridici che valorizzavano le specificità delle funzioni dei loro colleghi. Tuttavia, è solo successivamente, e con particolare intensità dopo la chiusura della vertenza Fiat dell’ottobre 1980, che si assistette al manifestarsi, su scala sempre più vasta, di iniziative e movimenti diretti a organizzare la categoria dei quadri in tutti i settori.
È dunque il caso di chiedersi: storicamente come si spiega il ritardo italiano nella rappresentanza dei quadri? La spiegazione va ricercata in un più generale ritardo italiano nella rappresentanza politica e sociale dei ceti medi e nelle conseguenze che questo ritardo ha avuto nel corso del XX secolo.
4. Il problema della rappresentanza dei ceti medi: i ritardi nel contesto italiano
Sappiamo bene che i processi di modernizzazione avvenuti in Europa tra Otto e Novecento fecero emergere in tutti i paesi nuovi attori sociali. In primo luogo, lo sviluppo della classe operaia (lavoratori e lavoratrici manuali di fabbrica), che crebbe parallelamente alla diffusione del sistema manifatturiero e della fabbrica meccanizzata; in secondo luogo, la crescita della piccola e media borghesia dei tecnici e degli impiegati che trovarono lavoro sia nell’apparato produttivo, sia nei servizi (pubblici e privati), che nel commercio. Queste trasformazioni portarono alla crescita delle città, che erano il fulcro dello sviluppo industriale e commerciale, attraverso processi di migrazione interna dalle campagne ai centri urbani, e fecero sì che le società europee mostrassero strutture sociali via via più complesse e articolate.
Il problema che si pose in tutti i sistemi politici europei nei decenni a cavallo del 1900 fu dare rappresentanza a questi nuovi attori sociali: classe operaia e ceti medi. Non a caso la nascita dei partiti di massa avvenne in Europa proprio tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. La nascita dei partiti, cioè, si configurò come una risposta, sul terreno politico, da parte delle forze sociali investite dagli effetti della modernizzazione economica. In seconda istanza, i partiti si rivelarono, a loro volta, agenti di modernizzazione della politica e della vita sociale. Storicamente, la forma istituzionale che permette nei paesi europei il passaggio dal liberalismo alla democrazia è, infatti, il partito di massa20.
I moderni sistemi di rappresentanza, tra Otto e Novecento, si costruirono a partire dalla piena accettazione di uno schema a tre classi della società:
- I notabili: aristocrazia e alta borghesia (grandi proprietari terrieri, alti funzionari pubblici).
- I ceti medi: piccola e media borghesia (tecnici, impiegati, professionisti, commercianti, ecc.).
- Strati popolari urbani e rurali: operai e contadini.
Nel passaggio dal liberalismo notabilare di stampo ottocentesco alla democrazia dei partiti del XX secolo furono cruciali le modalità con le quali, in ciascun paese, classe operaia e ceti medi riuscirono a costruire nuove forme di rappresentanza politica e sociale.
In Italia, il Partito socialista italiano, nato nel 1892, si incaricò di rappresentare gli strati popolari urbani e rurali; in quegli stessi anni cominciavano a diffondersi le prime Camere del lavoro e nel 1906 nasceva la Confederazione generale del lavoro (Cgdl), prima forma di sindacato unitario, vicina agli ambienti socialisti.
Un’enorme lacuna nel sistema della rappresentanza si riscontrava invece in relazione ai ceti medi. All’interno della classe dirigente liberale di fine Ottocento non si formarono partiti ben definiti. La Destra storica, liberal-moderata, e la Sinistra storica, liberal-progressista, non si strutturarono in un partito conservatore e in un partito liberale, sul modello inglese, ma presero la via del «trasformismo», prassi tesa alla ricerca di maggioranze ampie e trasversali mediante accordi e concessioni a gruppi politici eterogenei. Scelta che si spiegava, almeno in parte, con le difficoltà che incontrava il consolidamento interno e internazionale del giovane Stato unitario, ma che ebbe come effetto quello di scoraggiare l’emergere di formazioni partitiche ben definite all’interno della classe dirigente liberale.
Se all’inizio del XX secolo in Francia nasceva il Parti radical (Partito radicale) come rappresentante dei ceti medi urbani progressisti, un’iniziativa analoga in Italia non riuscì mai ad attecchire in maniera significativa21.
A ciò si aggiungeva il problema relativo ai cattolici. All’inizio del XX secolo rimaneva ancora fuori dal quadro politico italiano il mondo cattolico. La Chiesa, come noto, aveva condannato il processo di unificazione. Ai cattolici venne, quindi, intimato di non partecipare alla vita politica nazionale e alle elezioni. Il papa sancì questa posizione nell’enciclica Non expedit (1874). Si dovette aspettare il 1919, nel pieno della crisi politica e sociale conseguente alla Prima guerra mondiale, per arrivare alla nascita di un partito politico cattolico, il Partito popolare, fondato da Luigi Sturzo, mentre in Germania un partito cattolico di centro esisteva dagli anni Settanta del secolo precedente.
Questo vuoto di rappresentanza politica nei confronti dei ceti medi italiani venne colmato – ma non all’interno di una cornice democratica bensì autoritaria – dal Partito nazionale fascista, che negli anni Venti e Trenta dedicò una particolare attenzione all’organizzazione e alla mobilitazione dei ceti medi22. I ceti medi, e più precisamente le categorie tecnico-specialistiche (architetti, ingegneri, ragionieri, geometri, agronomi), furono pienamente integrati nel progetto totalitario attraverso una mobilitazione che trovava espressione nelle forme molteplici dell’intervento pubblico. Molti gruppi professionali appartenenti al mondo dei ceti medi ebbero, ad esempio, un ruolo da protagonisti (un gradito ruolo da protagonisti) nelle opere del regime: lavori pubblici, bonifiche, ecc.
In quella fase storica, i ceti medi italiani, non diversamente da quelli di altri paesi europei, ottennero pensioni distinte per categoria e mutue nazionali. La differenza è che queste, alla fine degli anni Venti, non furono conquiste come nei paesi democratici, ma concessioni fatte da uno Stato autoritario. Ne discendeva, in ampi settori della società italiana, una carenza di alfabetizzazione democratica; caratteristica di lungo periodo che avrebbero pesato anche sulla storia dell’Italia repubblicana.
Il Partito nazionale fascista fu, dunque, il primo partito italiano a dare, pur tardivamente, una rappresentanza organica ai ceti medi, che furono pienamente coinvolti nel sistema corporativo. Una funzione di rappresentanza dei ceti medi che venne ereditata nel secondo dopoguerra dalla Democrazia cristiana e, in parte, dal sindacalismo cattolico.
In conclusione di questo breve contributo, si può osservare come la fiammata di interesse nei confronti del problema della rappresentanza dei quadri che caratterizza il mondo sindacale italiano, e in particolare la Cgil, negli anni Ottanta (e che sembra poi affievolirsi nei decenni successivi) sia certamente degna di nota almeno per due motivi: da una parte, perché portò il sindacato a riflettere sui motivi della perdita di rappresentatività nel contesto della società post-fordista e globalizzata, quando si aprirono un ventaglio di questioni che in buona parte sono ancora attuali23; dall’altra parte, perché la questione dei quadri suggerisce percorsi interpretativi di lungo periodo sulle modalità di rappresentanza politica e sociale dei ceti medi: tema vitale, come si è visto, nello sviluppo della democrazia rappresentativa e per la sua tenuta.
Note
1 Carlo De Maria, Quadri aziendali e sindacato: la rappresentanza dei ceti medi in una prospettiva storica, relazione introduttiva al seminario I quadri aziendali in una prospettiva storica, Bologna, 19 giugno 2025, promosso dal Comitato direttivo di Apiqa Cgil Emilia-Romagna. Apiqa è un’associazione sindacale affiliata alla Cgil che si occupa di quadri e alte professionalità con l’obiettivo di rafforzare la politica confederale specifica, partecipando alla definizione delle linee contrattuali e alle varie fasi della contrattazione.
2 Sul valore periodizzante della dura sconfitta del sindacato a Torino, si veda Pino Ferraris, Cittadinanza e welfare, in “Una città”, 2003, n. 116, secondo il quale il 1980 può essere preso come crinale simbolico della crisi di una certa militanza politica e sindacale novecentesca.
3 La relazione del Censis è citata in Massimo Bianchi, Lorenzo Scheggi, Un sindacato per i quadri, Milano, Editoriale del Corriere della sera, 1982, p. 10.
4 Alte professionalità, quadri e tecnici: nel sindacato, nell’impresa, nella società, Convegno Cgil nazionale, Roma, 8-9 maggio 1987, Roma, Ediesse, 1987, pp. 7-23.
5 Ivi, pp. 127-142.
6 Fausto Vigevani et al., Tecnici, ricercatori, quadri e sindacato, Roma, Ediesse, 1985, pp. 9-10.
7 Sulla Fiom negli ultimi decenni del Novecento, si veda Eloisa Betti, Per una storia politico-sindacale della Fiom tra anni Ottanta e Novanta: organizzazione del lavoro, ambiente e salute, questione femminile, in Fiom. Una storia di democrazia, contrattazione e conflitto, Roma, Futura, 2023, e nello stesso volume i contributi di Fabrizio Loreto e Francescopaolo Palaia.
8 Fausto Sabbatucci, Alcune riflessioni per rinnovare le strategie rivendicative del sindacato, in Le alte professionalità nell’impresa. Materiali per un dibattito su tecnici, ricercatori e quadri, Seminario della Fiom del Lazio, Ariccia, 16-18 ottobre 1985, Roma, Datanews, 1986, pp. 53-61, p. 53.
9 “Tecnici, ricercatori e quadri per rinnovare il sindacato e trasformare l’impresa”, Convegno nazionale Cgil, Roma, 18-19 giugno 1985. La relazione introduttiva di Bruno Roscani e Fausto Sabbatucci venne pubblicata in Vigevani et al., Tecnici, ricercatori, quadri e sindacato, cit., pp. 11-31.
10 Sabbatucci, Alcune riflessioni per rinnovare le strategie rivendicative del sindacato, cit., pp. 55-56.
11 Parole citate in Bianchi, Scheggi, Un sindacato per i quadri, cit., p. 41.
12 Le alte professionalità nell’impresa. Materiali per un dibattito su tecnici, ricercatori e quadri, cit., pp. 74-84.
13 Ivi, p. 74 e ss.
14 Parole citate in Bianchi, Scheggi, Un sindacato per i quadri, cit., pp. 38-39.
15 Per una messa a punto storiografica, Eloisa Betti, Precari e precarie. Una storia dell’Italia repubblicana, Roma, Carocci, 2019.
16 Mauro Carletti, Carlo Stelluti, Quadri intermedi e sindacato. L’organizzazione sindacale in Italia e all’estero, Roma, Edizioni Lavoro, 1984, pp. 78-79.
17 Carletti, Stelluti, Quadri intermedi e sindacato, cit.
18 Sul fenomeno della deindustrializzazione tra dimensione locale e contesto globale, si veda Eloisa Betti, Carlo De Maria (a cura di), Bologna metalmeccanica. Luoghi e memorie del lavoro tra deindustrializzazione, lotte sindacali e trasformazioni urbane, Bologna, Bologna University Press, in corso di stampa.
19 Sulla situazione europea, oltre a Carletti, Stelluti, Quadri intermedi e sindacato, cit., si veda anche Bianchi, Scheggi, Un sindacato per i quadri, cit.
20 Cfr. Piero Ignazi, Partito e democrazia. L’incerto percorso della legittimazione dei partiti, Bologna, Il Mulino, 2019, cap. III.
21 Cfr. Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto (a cura di), Storia d’Italia. Vol. 3. Liberalismo e democrazia, 1887-1914, Roma-Bari, Laterza, 1999.
22 Cfr. Mariuccia Salvati, Cittadini e governanti. La leadership nella storia dell’Italia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1997, cap. VI-VIII.
23 Cfr. Mimmo Carrieri, I sindacati. Tra le conquiste del passato e il futuro da costruire, Bologna, Il Mulino, 2012.