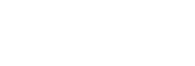In apertura: Tedoforo (unsplash.com).
1. Introduzione: le olimpiadi e il turismo
Nel febbraio del 2026 l’Italia ospiterà per la terza volta i Giochi olimpici invernali, sarà la quarta volta – comprendendo anche i giochi estivi di Roma 1960 – che la fiaccola olimpica giungerà nel nostro Paese. L’Italia sarà per due settimane sotto i riflettori mondiali, ma sarà importante anche quello che resterà alla fine dei giochi: un lascito da portare avanti nei prossimi decenni. I giochi olimpici degli ultimi anni hanno mostrato come le trasformazioni legate all’organizzazione dell’evento rappresentano uno degli aspetti più significativi dell’eredità che le olimpiadi lasciano all’area che ospita. Gli organizzatori si sono posti il problema proprio della legacy olimpica, ragionando soprattutto sulle possibilità di programmare gli sviluppi positivi che la località ospite potrà godere dopo lo spegnimento della fiaccola. Questo dibattito vede da tempo coinvolto anche il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) con le sue commissioni di studio. Nel novembre 2002 si è svolto a Losanna un simposio internazionale organizzato dal Museo Olimpico e dal Centro di studi olimpici di Barcellona; in quell’occasione si è insistito molto sulla duplice valenza del lascito olimpico, sia per le località ospiti, sia per lo stesso movimento olimpico. Edizioni di successo, come quella di Barcellona o Pechino possono dare delle spinte determinanti allo stesso movimento olimpico, così come eventuali insuccessi sono in grado di minarne la credibilità. Tanti sono i fattori che formano l’eredità olimpica: economici, infrastrutturali, turistici, questi ultimi valutabili sia in chiave di strutture ricettive che d’immagine. È emerso così come il concetto di legacy debba essere considerato già nel dossier della candidatura, così come si deve considerare l’eredità l’ompica con una prospettiva di lungo periodo con una serie di interventi in grado di portare avanti nel tempo gli iniziali risultati positivi1.
In tal senso il caso di Barcellona 1992 ha fatto scuola, la città catalana è riuscita infatti a cogliere l’occasione per realizzare un’impressionante trasformazione urbanistica che ha avuto un impatto economico sulla città con ottimi risultati economici, infrastrutturali e non ultimi sul turismo. Il successo di Barcellona va letto nell’ottica di una città che con la sua amministrazione ha iniziato a preparare il suo territorio con sei anni di anticipo dall’evento, canalizzando notevoli investimenti e soprattutto facendo un piano di interventi anche nei periodi successivi. Di fatto a partire dai giochi olimpici del 1992 Barcellona è diventata una delle mete più ambite dal turismo europeo e mondiale2.
Tali tendenze spiegano come siano cambiate le aspettative delle città ospitanti, si pensi in particolare ai giochi olimpici invernali che in passato erano organizzati esclusivamente da piccole, seppur famose, località sciistiche e oggi invece si svolgono in grandi città a volte lontane dalle piste da sci come Pechino e per l’appunto Milano. Le olimpiadi invernali di Torino (2006) e di Sochi (2014) hanno ridefinito il turismo urbano di queste due città impostando la propria attrattività anche per il futuro.
Con questo breve articolo abbiamo voluto così porre l’attenzione sui giochi olimpici organizzati dall’Italia negli anni del boom economico: “Cortina d’Ampezzo 1956” e “Roma 1960” per capire se lo stretto rapporto tra turismo e giochi olimpici è solo recente o può essere rinvenuto anche in eventi più lontani nel tempo. Si tratta di due avvenimenti che hanno segnato un’epoca nella storia del nostro paese e che si sono svolti proprio negli anni in cui l’economia italiana cresceva a ritmi mai conosciuti in precedenza, scrivendo cambiamenti fondamentali anche nel settore turistico nazionale. Senza la pretesa di esaustività si vogliono porre alcuni interrogativi. Nell’organizzazione dei giochi e nella presentazione delle candidature vi era già l’intenzione di sfruttare a livello turistico questi eventi che potevano costituire una vetrina internazionale unica? Si pose durante l’organizzazione la questione del rafforzamento delle strutture ricettive e infrastrutturali per i giorni delle gare? Infine si pensò a quello che sarebbe stato il dopo, e quindi la necessità di raccogliere i “frutti turistici” dei giochi e portarli avanti negli anni successivi?
2. Il turismo italiano nel secondo dopoguerra
Partiamo da un breve quadro del settore turistico italiano alla fine della Seconda guerra mondiale. Il turismo nel secondo dopoguerra contribuisce alla rinascita del paese, ciò è dovuto, non solo ovviamente al gran numero di risorse naturali e artistiche della penisola, ma anche ad una posizione predominante già conquistata nel periodo ante guerra. Fu soprattutto nel periodo a cavallo dei due conflitti mondiali che nel paese iniziò a maturare una maggiore consapevolezza che il turismo poteva svolgere un ruolo importante nell’economia nazionale. Nel 1919 viene fondato l’Ente nazionale delle industrie turistiche che rappresentò il primo intervento dello stato in materia. Diverse furono le iniziative avviate dall’ente per la modernizzazione del turismo nazionale, come la creazione di apposite scuole per il turismo. In generale in questi anni si posero le basi per la nascita del turismo di massa a vantaggio sia dei visitatori italiani che stranieri. Nel 1934 la Società delle nazioni realizzava una classifica di 31 paesi a forte vocazione turistica in base alle entrate economiche. L’Italia risultava al terzo posto dietro alla Francia e al Canada e davanti agli Stati Uniti3.
Tre furono i modelli che contribuirono maggiormente alla ricostruzione del turismo italiano dopo il 1945: il turismo balneare, il turismo montano e quello culturale. Dagli anni cinquanta in poi furono le località balneari italiane che divennero leader nel Mediterraneo superando alcuni principali competitori, che avevano bellissime risorse naturali ma erano decisamente più arretrate economicamente. In quegli anni paesi come la Spagna, la Grecia e la Jugoslavia, facevano certamente fatica a realizzare un livello minimo di infrastrutture e a presentarsi con un’offerta ricettiva diversificata in grado di soddisfare tutte le fasce di reddito. Anche la montagna italiana ha conosciuto negli anni cinquanta e sessanta una notevole crescita che ha permesso a molte località alpine di conservare le posizioni predominanti acquisite nel periodo tra le due guerre. La diffusione degli impianti di risalita rese alla portata di tutti l’attività sciistica, mentre si sviluppava anche se con numeri minori il turismo montano estivo. In questa fase gli investimenti si concentrarono soprattutto per la creazione di strutture ricettive alberghiere, mentre solo a partire dagli anni settanta si rafforzerà lo sviluppo delle seconde case. Con percentuali minori di crescita anche il turismo culturale, in particolare quello delle grandi città d’arte, ha partecipato alla ricostruzione del settore italiano4. Nel boom del turismo di massa Cortina e Roma costituiscono due notevoli esempi di località che si sviluppano intorno a due dei tre assi principali, il montano e il culturale.
3. I giochi di Cortina d’Ampezzo 1956
Nella primavera del 1949 si svolse a Roma la Sessione del Cio nella quale furono presentate le candidature ai giochi olimpici estivi e invernali del 1956, tra queste vi era anche Cortina d’Ampezzo per le olimpiadi invernali. L’organizzazione della sessione a Roma costituì un successo importante per il Coni, e in generale per tutta la diplomazia sportiva italiana, che in questo modo ritornava ad avere a livello internazionale una credibilità messa a dura prova dal conflitto terminato da pochi anni. L’evento inoltre doveva servire a lanciare la candidatura italiana ai giochi invernali e a favorire l’inizio dei lavori per la candidatura ai giochi estivi del 1960. La presentazione di Cortina era stata preparata con la massima attenzione, si pensi che nella sede delle audizioni, l’Hotel Excelsior, era stata allestita una mostra con i plastici delle Dolomiti e degli impianti per catturare la benevolenza dei delegati. La votazione si concluse con un largo successo per la località in provincia di Belluno, tanto che non servì neanche il ballottaggio. Per Cortina si trattava anche di una sorta di risarcimento in quanto non aveva potuto organizzare i giochi del 1944, assegnatigli nel 1939 e successivamente annullati a causa del conflitto5.
Avvenuta la designazione il Coni si assunse inizialmente la responsabilità dell’organizzazione, solo più avanti, nel 1953, i lavori dei giochi passarono nelle mani di un comitato organizzatore. Il finanziamento dei giochi è un altro aspetto che viene gestito principalmente dal Coni, comunque in stretta collaborazione con il comune di Cortina che fornisce i terreni per la costruzione dei nuovi impianti anche in concorso con l’Azienda autonoma di cura e soggiorno e dell’Associazione albergatori. Ad esempio nell’ampliamento dello Stadio Apollonio, impianto sussidiario al più grande palazzo del ghiaccio, utilizzato per gli allenamenti e alcune partite del torneo di hockey, il Coni concede all’Azienda autonoma di cura e soggiorno, proprietaria dell’impianto, un contributo di dieci milioni. Oltre agli impianti sportivi di grande interesse turistico vengono realizzati lavori riguardanti la costruzione di raccordi stradali e le vie di accesso alle piste da sci. Ad una complessiva spesa di 3.213.000.000 lire si registrò una spesa di 284 milioni circa (quasi il 9 per cento) per la cosiddetta organizzazione logistica riguardante le infrastrutture che sarebbero rimaste al comune6.
L’idea di costruire un villaggio olimpico permanente fu accantonata in breve tempo. Costruire un complesso edilizio per almeno 2000 atleti, e per altrettante persone “di contorno” come gli ufficiali di gara e i giornalisti, poneva il problema della sua utilizzazione futura. Anche gli albergatori non vedevano di buon occhio questa soluzione. Si preferì quindi seguire la strada di Saint Moritz (1948), alloggiando gli atleti in alberghi, piuttosto che quella di Oslo (1952) dove era stato costruito il villaggio per gli atleti. Furono intavolate trattative con l’Associazione albergatori cortinesi sui posti da riservare e sulle tariffe da praticare. Nel dicembre del 1953 gli albergatori si dichiararono disposti ad ospitare soprattutto i turisti mentre atleti e addetti ai lavori avrebbero dovuto andare nel territorio periferico della valle ampezzana e nella val Pusteria. Si arrivò però presto all’accordo che il 60 per cento dei posti letto sarebbe stato riservato agli atleti, il 20 agli accompagnatori e il restante 20 veniva riservato ai turisti. Venne istituito dal Comitato organizzatore un servizio alloggi che censì le possibilità ricettive. Tra Cortina, Pocol, Zuel e Tre Croci c’erano 42 alberghi e 10 pensioni, con un complesso di 3279 posti letto. Aumentando il numero di letti per camera si riuscì ad averne 4685. Alla fine 1415 atleti alloggiarono in 28 alberghi e ogni delegazione pagò i conti direttamente agli albergatori mentre il comitato organizzatore considerò come propri ospiti una serie di importanti personalità sportive e politiche. Un comitato interprovinciale creato per l’occasione censì anche i possibili posti letto per i turisti che non avrebbero trovato alloggio a Cortina. Per quanto riguarda la viabilità furono fatti lavori importanti da parte dell’Anas per circa quattro anni con una spesa di 1,9 miliardi, opere comunque necessarie al di là dei giochi, in quanto l’importanza del turismo sulle Dolomiti si faceva sempre più importante. I giochi resero più veloce il tutto con un grande ritorno turistico per Cortina e le località vicine nelle quali si arrivava quasi esclusivamente in automobile o in corriera. Più di due miliardi arrivarono dallo Stato per la messa a posto di strade provinciali e comunali, anche in questo caso con un buon risultato per il turismo degli anni successivi. Il potenziamento della linea Dobbiaco-Cortina, inizialmente previsto, fu invece evitato a causa della spesa troppo elevata7.
Esaminando i risultati in termini numerici lasciati dai giochi nel territorio di Cortina si può vedere come la ricettività alberghiera ne esca modificata sia in termini quantitativi che qualitativi. Uno studio storico sul turismo ampezzano evidenzia in quegli anni un aumento di circa l’11 per cento dei posti letto con un incremento di più del 23 per cento delle camere con bagno, un indicatore utilizzato nei primi decenni del dopoguerra per valutare la qualità dell’offerta ricettiva. Lo stesso studio valuta in deciso aumento l’andamento delle presenze negli anni a cavallo dei giochi del 1956. È certamente indubbio come le olimpiadi abbiano offerto un valido contributo all’immagine di Cortina nel mondo ma è altrettanto importante sottolineare come gli interventi in campo infrastrutturale, con la costruzione di strade e l’ampliamento delle piste abbiano fatto la loro parte. Seppur solo stimati, i dati sulle presenze – le notti effettive passate dai turisti nelle strutture alberghiere – a nostra disposizione mettono comunque in luce a cavallo del 1956 un aumento di circa 200.000 unità seguendo una tendenza alla crescita che raggiunge l’apice con l’inizio degli anni Settanta8.
4. I giochi di Roma 1960
Incoraggiati dall’assegnazione dei giochi di Cortina i rappresentanti dello sport italiano giudicarono il momento propizio per avanzare la candidatura della capitale italiana per i giochi estivi. Dopo qualche iniziale problema, le istituzioni sportive e politiche portarono avanti con decisione il progetto di Roma 1960 che avrebbe previsto una spesa molto importante riguardante la realizzazione degli impianti sportivi e di varie infrastrutture. Grazie ad un lavoro diplomatico intenso, ricostruito in un libro dallo storico Tito Forcellese, nel 1955 Roma ottenne il diritto di organizzare i giochi olimpici. Alla notizia dell’assegnazione dei giochi iniziarono le pressioni da parte di rappresentanti di vari enti, specialmente alberghieri e turistici per partecipare ai lavori della commissione organizzatrice9.
L’organizzazione dell’accoglienza dei molti visitatori che si prevedevano nella capitale fu portata avanti dall’Ente provinciale del turismo di Roma che si concentrò essenzialmente su due problematiche: trovare il numero di letti necessario in hotel e pensioni per soddisfare il bisogno delle migliaia di persone che avrebbero gravitato intorno all’evento, e aumentare le possibilità di accoglienza complementare a quella alberghiera. Nel maggio del 1958 l’ente provinciale creò l’Ufficio alloggi Olimpiadi con lo scopo di tenere i contatti con le organizzazioni internazionali per la prenotazione di camere e alloggi. Un po’ com’era accaduto a Cortina, anche a Roma enti locali e associazioni alberghiere si misero d’accordo sulle percentuali di posti letto da assegnare all’evento olimpico. Fu raggiunto un compromesso secondo il quale il 75 per cento della disponibilità alberghiera sarebbe rimasta al normale traffico turistico mentre il restante 25 sarebbe andato incontro alle esigenze di personalità e autorità dei paesi che avrebbero preso parte ai giochi. In questa divisione c’era da considerare sicuramente il fatto che Roma costituiva in sé un enorme bacino turistico e c’era da prevedere una sostanziosa presenza di viaggiatori estranea all’evento sportivo. L’ufficio alloggi controllava vari tipi di ospitalità: hotel, campeggi, istituti religiosi e stanze in case private. Facendo seguito ad un appello fatto dal sindaco che invitava i romani a rivitalizzare la loro reputazione in fatto di ospitalità, migliaia di privati cittadini misero a disposizione a pagamento parti dei loro appartamenti. Un decreto del prefetto del settembre 1959 autorizzava singole persone ad affittare stanze e interi appartamenti durante un periodo limitato che andava dal 1 agosto al 16 settembre, senza bisogno di avere una particolare licenza10.
Dal punto di vista degli impianti sportivi i giochi costituirono senz’altro un successo, più controversa fu l’eredità olimpica legata alle infrastrutture realizzate. Pur nella consapevolezza dell’importanza dell’evento gli amministratori romani non decisero di realizzare un nuovo piano regolatore ma si affidarono a modifiche dei precedenti, continuando in generale l’espansione della città verso il mare, finendo la costruzione del quartiere E42-Eur11.
Analizzando i dati statistici, raccolti in uno studio sulla capacità alberghiera della capitale nei primi anni del dopoguerra, risulta subito interessante notare l’aumento delle strutture alberghiere. Nel periodo 1945-1960 gli esercizi alberghieri romani crescono con un incremento di più del 50 per cento (56%, da 423 a 659 unità). È interessante notare lo scatto nel numero di esercizi tra il 1957 e il 1960, triennio nel quale le strutture sono aumentate del 21 per cento. Oltre al progressivo aumento dei flussi turistici, l’avvicinarsi delle Olimpiadi influisce fortemente con la decisione di creare nuove strutture ricettive adeguate all’evento e soprattutto al traino che la manifestazione avrà negli anni successivi12.
Il processo di crescita alberghiero a Roma continua fino a metà degli anni settanta, e si interrompe non a caso in anni di crisi anche del settore turistico nazionale. Non è semplice analizzare in pieno una città che anche nella sua offerta turistica risulta unica al mondo, è però indubbio che i giochi olimpici contribuirono ad esaltare le risorse turistiche di Roma e a valorizzarle maggiormente sul fronte internazionale13.
5. Conclusioni
Dopo questo breve “viaggio” nello sviluppo turistico delle località olimpiche italiane si può cercare di arrivare a rispondere agli interrogativi che ci eravamo inizialmente posti. Nell’organizzazione dei giochi e nella presentazione delle candidature era presente l’intenzione di valorizzare le sedi ospitanti? Le risposte sembrano essere positive. Per Cortina al momento della candidatura si insistette molto sulla bellezza delle vette dolomitiche degne di ospitare i giochi invernali così come era accaduto ad altre eccezionali località sciistiche internazionali come Chamonix, Sankt Moritz e Garmisch. Meno evidente appare il tema della valorizzazione delle bellezze romane al momento della candidatura, ciò però diventa quasi scontato se si pensa che alcune gare furono disputate in pieno centro storico e sullo sfondo di attrattive dall’altissimo valore culturale come la Basilica di Massenzio e le Terme di Caracalla. Si pensi alla maratona, corsa in notturna sulle strade della città e grazie alle immagini televisive diventata un vero e proprio spot pubblicitario per il turismo della capitale. Ancora più positiva è la risposta se si pensa all’interrogativo riguardante il rafforzamento delle strutture ricettive e infrastrutturali per i giorni delle gare. Sia a Cortina che a Roma le sinergie tra gli enti organizzatori, gli amministratori locali e le associazioni degli albergatori portarono a risultati molto positivi in fatto di ospitalità temporanea nei giorni delle gare.
Note
1 Miguel De Moragas, Christopher Kennett and Nuria Puig (eds.), The Legacy of the Olympic Games 1894-2000, Lausanne, International Olympic Commitee, 2003, pp. 31-42.
2 Ferran Brunet i Cid, The Economy of the Barcelona Olympic Games, in Gavin Poynter, Ian Macrury (eds.), Olympic Cities: 2012 and the remaking of London, Surrey, Ashgate, 2009, pp. 97-119.
3 Franco Paloscia, Storia del turismo nell’economia italiana, Roma, Petruzzi, 1994 e Patrizia Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 218-222.
4 Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti, cit., pp. 230-241.
5 Tito Forcellese, L’Italia e i giochi olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e diplomazia sportiva, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 185-191.
6 IOC library, VII Olympic Winter Games, Cortina d’Ampezzo, 1956: official report, pp. 91-118.
7 Ibid.
8 Si tratta di un saggio di Adriana Galvani, Il turismo a Cortina d’Ampezzo. Dalle origini agli anni ’90, Bologna, Lo Scarabeo editrice, 1992, sui dati vedi in particolare pp. 88-96.
9 Forcellese, L’Italia e i giochi olimpici, cit., pp. 191-234.
10 IOC library, The XVII Olympiad, Rome, 1960: official report, pp. 609-619.
11 Italo Insolera, Il “piano regolatore” delle Olimpiadi, in “Annale Irsifar 2011. Le Olimpiadi del ‘miracolo’ cinquant’anni dopo”, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 17-22.
12 Francesco Colzi, L’evoluzione della struttura ricettiva di Roma tra il 1945 e il 1960, in Angela Maria Girelli Bocci (a cura di), L’industria dell’ospitalità a Roma, Padova, Cedam, 2006, pp. 388. I dati sono a pp. 390-398.
13 Confronta Adriana Conti Puorger, Lidia Scarpelli, Evoluzione delle strutture alberghiere a Roma, in Girelli Bocci, L’industria dell’ospitalità a Roma, cit., pp. 413-436.