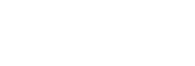In apertura: gli studenti di una classe del territorio di Monte Sole durante un laboratorio didattico nell’anno scolastico 2024-2025.
1. Introduzione
È l’estate del 2019 quando la Legge n. 92 del 20 agosto istituisce l’insegnamento trasversale di Educazione civica. La legislazione, dunque, interviene a strutturare con un impianto formale quell’intreccio – già praticato e forte nella scuola italiana – fra cittadinanza, storia, memoria e patrimonio culturale, contribuendo a valorizzare l’implementazione di buone pratiche didattiche su quelle macroaree. Nell’intenzione dei legislatori è chiara l’idea di sviluppare un approccio dichiaratamente libero da strettoie disciplinari, oltre che strettamente aderente alle finalità indicate all’Articolo 1: «contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri». Non entreremo qui, nell’annoso dibattito legato all’opportunità di modificare un assetto di questa portata con una legge ad hoc. Il tema è piuttosto quello di capire, guardando ai risultati che vi illustreremo a partire dal nostro osservatorio, se si possa dire che quanto accaduto dal 2019 in avanti abbia o meno stimolato riflessioni e azioni progettuali che le esigenze della normativa hanno contribuito a implementare, anche grazie allo stabilizzarsi di spazi di dialogo e progettualità (non va dimenticato che la Legge n. 92 prevede lo svolgimento di progetti sui temi dell’educazione civica per 33 ore all’anno, ciò che ha sicuramente una conseguenza sulla strutturazione di buone pratiche). Volendo continuare a storicizzare, data 2019 anche la firma della convenzione fra Istituto storico Parri – Bologna Metropolitana e Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto per le finalità della costruzione condivisa di un Piano dell’offerta formativa dedicato espressamente alle scuole del territorio appenninico attorno a Monte Sole. La prima offerta didattica a firma Parri/Comitato arriva proprio nel primo anno di sperimentazione della nuova legge. Poi, nella primavera del 2020, e ancora nel corso del 2021, una nuova governance al Parri sostiene l’azione istituzionale con forza, scegliendo di valorizzare una nuova generazione di collaboratori: ventenni e trentenni di formazione storica entrati in Istituto grazie a tirocini e stage universitari. Nasce e cresce un piccolo staff coeso nel quale l’esperienza di una tradizione didattica e metodologica di lunghissimo corso – che affonda le sue radici nel Laboratorio nazionale di didattica della storia (Landis) – si intreccia con una volontà innovativa e fresca che cerca nel continuo dialogo con i docenti la propria idea di competenza e professionalità. Contemporaneamente, nella legge di Bilancio del 2021, il Ministero della Cultura conferma uno stanziamento per i luoghi della Memoria della Resistenza e degli eccidi nazifascisti (Marzabotto, Fossoli, Museo dei Fratelli Cervi, Sant’Anna di Stazzema, Risiera di San Sabba). È in questo fermento di innovazione che le due istituzioni si avvicinano per collaborare a una didattica condivisa in una fase di grande slancio istituzionale destinato, tuttavia, a subire una battuta di arresto con l’arrivo del Covid-19 che arriva a fare da spartiacque. Non è questa la sede per ragionare di come la pandemia abbia modificato la scuola italiana e le sue pratiche – ci sono ampi studi che ne trattano, ma forse il tema è ancora lontano dall’essere analizzato nella sua profondità – anche e soprattutto oltre le emergenze del lock-down, e tuttavia chi vive e lavora in classe sa che esista una scuola pre e una scuola post pandemia. Le note di contesto abbondano, insomma, e sono rilevanti a sufficienza per definire e guardare a un processo strutturato intorno al lavoro coordinato del Parri Bologna e del Comitato onoranze, cui, nell’ultimo biennio, si è aggiunta la partnership della Scuola di Pace di Montesole.
2. Partire dai luoghi/Tornare ai luoghi
Che si possa – e anzi si debba – fare didattica nei luoghi e attraverso i luoghi è argomento di vasta letteratura1. Se questo è vero non ci sono dubbi sul fatto che il circondario di Montesole rappresenti un patrimonio ricchissimo per lo sviluppo di percorsi dedicati alla guerra, alla violenza perpetrata in tempo di guerra e, più in generale, all’ultima fase della Seconda guerra mondiale. In questo senso l’intero e vasto territorio del Parco di Monte Sole è un luogo di eccezionale ricchezza educativa e formativa, conosciuto su scala nazionale e frequentatissimo dalle scuole da decenni. Sembrerebbe difficile aggiungere qualcosa di nuovo a quanto già sedimentato nel tempo dalle molte istituzioni e associazioni operanti in quei luoghi; in realtà il progetto Parri Bologna/Comitato si pone fin da subito obiettivi differenti e pone la questione attorno al rapporto fra il luogo e le scuole che in quel luogo vivono e per le quali ragionare di memoria significa riflettere, anche, sulla propria identità. Da qui la scelta di dedicare e rivolgere il Piano dell’Offerta Formativa alle scuole – per lo più primarie e secondarie di primo grado – di Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, Riola, Vado e Vergato (offerta da poco estesa anche a Porretta Terme, Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere dove si trovano anche scuole secondarie di secondo grado).
Ma cosa significa lavorare specificamente per queste scuole e in queste scuole? Per noi ha significato raggiungere i territori attraverso la progettazione di un curricolo verticale unitario, pensato come un percorso sviluppato su otto anni: dalla prima classe della primaria fino alla terza della secondaria di primo grado. Entrare nelle aule per appalesare il ragionamento complessivo con gli studenti e le studentesse e senza uscire dall’aula: muoversi verso quel luogo o le classi di quel luogo come in un contesto specifico. Poche note di contesto aiutano a comprendere le caratteristiche cui è necessario fare riferimento per la progettazione di attività dedicate. Innanzitutto, si tratta di scuole situate in zona appenninica protagonista, da tempo, di uno spopolamento costante, mitigato, negli ultimi anni, da un flusso migratorio di cittadini per lo più extracomunitari, di solito impegnati nelle attività dell’economia locale. Questa caratteristica di zona periferica è in parte aggravata, dal punto di vista demografico, dalla presenza del trauma storico di riferimento: anche se la strage appare lontanissima da noi, dal punto di vista dei passaggi generazionali la ferita risulta ancora viva e presente, non solo simbolicamente. Alcune zone della strage sono state rase al suolo e mai più ricostruite, in altre la densità abitativa resta bassa, in misura maggiore che nella restante zona appenninica e per ragioni che si riferiscono alle ragioni storiche del trauma. Un’ulteriore difficoltà, strettamente legata al contesto scolastico, riguarda il personale docente: queste sedi in zona appenninica sono spesso interessate da un turnover significativo, alimentato da un flusso di docenti non residenti – che, quindi, ben difficilmente conoscono approfonditamente le vicende locali dei luoghi nei quali insegnano – e che accettano il primo incarico in sedi periferiche spesso nell’attesa di maturare gli anni necessari alla richiesta di trasferimento. Ultimo, ma non meno importante, è il tema della scarsità relativa delle offerte progettuali che raggiungono questi luoghi.
3. La scelta operativa: il curricolo verticale
Nella lunga gestazione dell’Offerta formativa Parri/Comitato, fatta di proficui confronti su temi e metodologie da proporre, una prima, e solida, convergenza è stata individuata nella comune volontà di proporre un curricolo verticale che, nella sua prima edizione, accompagnasse l’insegnamento dell’Educazione civica dal primo anno della scuola primaria al terzo della secondaria di primo grado. La proposta voleva rispondere ad una specifica esigenza: portare a valore le 33 ore di Educazione civica, non limitandole a generici schemi teorici di convivenza civile, attraverso una progettazione didattica specificamente rivolta a docenti e studenti che, rispettivamente, lavorano e frequentano scuole di un territorio che si trova a fare i conti con quella specifica tipologia di memoria. Per raggiungere tale obiettivo si è ritenuto di lavorare ad un progetto coerente strutturato su otto anni, nel quale l’attività del primo anno della primaria e quella del terzo della secondaria di primo grado stanno tra loro in una logica di continuità e in cui le attività dedicate ad un’annualità specifica sono connesse con la precedente e propedeutiche alla successiva2. Questo per superare la logica degli interventi a spot – rischio ricorrente nelle attività di due ore con esperti esterni – per approdare a una concordanza tematica in grado restituire, alla fine del ciclo formativo, un percorso strettamente contestuale con la storia e la memoria del luogo in cui si vive e si frequenta la quotidianità scolastica. Il tema dell’identità collettiva nei luoghi di un trauma si propone, quindi, di passare proprio attraverso la ricognizione del rapporto tra il contesto locale della scuola e l’educazione civica che si può portare a valore. Dopo il primo anno scolastico di sperimentazione, si è deciso di estendere il curricolo alla scuola secondaria di secondo grado e, grazie al contributo della Scuola di Pace, di tentare la sfida della scuola dell’infanzia.
Nel paragrafo successivo saranno riportate – seppur in maniera sintetica e schematica – le attività del curricolo verticale proposto. Sul piano tematico sarà semplice orientarsi nei nuclei concettuali indicati dalle nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (7 settembre 2024) – ovvero Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale – per cui nella descrizione ci soffermeremo maggiormente sulle metodologie proposte che, in nessun caso, si rifanno alla frontalità della lezione tradizionale ma cercano pratiche innovative e laboratoriali.
3.1. Scuola primaria
La scuola primaria, «più di altri ordini di scuole, interagisce in maniera strutturale con la comunità e il contesto in cui opera»3. Nel contesto di Montesole, che potrebbe apparire come luogo ideale nel concretizzare un percorso di educazione civica specifico come quello qui proposto, in realtà esistono alcune insidie non semplici da superare, come la rarità di memorie familiari condivise nelle classi (composte per lo più da bambine e bambini provenienti da famiglie emigrate da altri luoghi d’Italia o da contesti extraeuropei) o la scelta di realizzare incontri nelle classi e non nei luoghi della memoria concreta dei fatti. Come provare, con questi presupposti, a dare significato ad un percorso curricolare in un ciclo scolastico tanto delicato o complesso come la primaria? Sul piano tematico la scelta è quella di dare coerenza al curricolo, progettando percorsi didattici a partire da alcune parole chiave/concetti: diversità, condivisione, confronto, pace4, Costituzione. Per le classi prime si propone l’attività Un mondo di colori che, come da titolo, prevede l’utilizzo di uno strumento didattico particolarmente adatto a stimolare la creatività e l’apprendimento di bambini e bambine in quella fascia d’età. Nel caso specifico, l’utilizzo dei colori è finalizzato al coinvolgimento della classe sui temi della diversità e del pluralismo; l’obiettivo finale è la realizzazione, in forma collaborativa, di un cartellone che resta alla classe, anche per poter essere implementato durante la parte restante dell’anno. Destinata alle classi seconde è Il valore della condivisione, attività durante la quale viene sperimentata una metodologia ludica5 che favorisce il coinvolgimento nell’educazione alla gestione comune, nell’obiettivo di favorire la formazione di rapporti di fiducia reciproci e provare ad arginare la logica competitiva e individualista. L’Italia ripudia la guerra è, invece, il laboratorio artistico proposto alle classi terze: l’educazione alla cultura della pace viene stimolata attraverso piccole forme d’arte come il disegno che, valorizzato come atto collettivo e non individuale, si propone di favorire il confronto a discapito della potenziale violenza verbale scaturita dallo scontro. Ci si concentra, in particolare, sul ragionamento attorno al concetto/idea di conflitto, chiarendo la sofferenza portata dalla violenza che ne consegue, talvolta “eroicizzata” da alcuni videogiochi che bambini e bambine di quella fascia d’età iniziano ad approcciare. L’oggetto artistico da sviluppare è, appunto, il binomio guerra/pace. La storia dell’eccidio di Monte Sole è al centro della proposta indirizzata alle classi quarte, attraverso la discussione in classe dei contenuti elaborati dal saggio per ragazzi Stivali a Monte Sole (Giulia Casarini, Pendragon 2008). La storia narra di un incontro, mentre imperversa la Seconda guerra mondiale: la nascita di un’amicizia tra due animali molto diversi, una lupa e un asino, che attraverso un dialogo raccontano le tristi vicende che portarono a quel tragico evento. La discussione in classe vuole stimolare una riflessione condivisa sulla memoria e sul diritto alla non-guerra per costruire un futuro di pace. Destinata alle classi quinte è una delle attività che svolgiamo da molti anni: La Costituzione alle elementari. Dopo una veloce ricognizione delle date più importanti del Calendario civile italiano e un semplice lavoro di contestualizzazione del periodo storico di fondazione della Repubblica, i bambini e le bambine sono chiamati a leggere a voce alta i dodici principi fondamentali per l’analisi di alcune parole-chiave utilizzate per esprimere ed analizzare i concetti espressi nei singoli articoli e l’ideale che più chiaramente vi si esprime. Attraverso la discussione guidata a classe intera e la riflessione nei piccoli gruppi si mostrano alcune immagini fotografiche da abbinare a ciascun articolo e alle parole-chiave identificate per descriverlo. Con questi materiali si procede alla produzione di un cartellone che rimarrà alla classe.
3.2. Scuola secondaria di primo grado
Per la scuola secondaria di primo grado si è deciso di sperimentare nel primo biennio un percorso unico articolato su due proposte in continuità che riguardano il delicato tema della hate speech e della loro diffusione via social. Il ricorso al linguaggio d’odio6 è un tema quanto mai attuale ed è divenuto, negli ultimi anni, strettamente correlato all’ambiente dei social network, dove la comunicazione è priva di autocensure e mediazioni. Via social molte distanze fisiche risultano abbattute e le comunicazioni interpersonali si sono fatte più immediate ma, al tempo stesso, è aumentata la proliferazione di commenti sessisti, insulti razzisti e offese omofobe. A partire da questa riflessione si è deciso di proporre alle prime due classi un percorso in continuità nel biennio. La mia parte intollerante vuole rispondere alla necessità della messa a punto di strategie per il contrasto al linguaggio d’odio e si struttura in due fasi. Nel Percorso 1, destinato alle prime classi, gli studenti e le studentesse sono stimolati a ragionare di rumors, stereotipi7, pregiudizi8, discriminazione e di come possano ostacolare l’inclusione sociale. Nel Percorso 2, destinato alle classi seconde, attraverso l’uso di metodologie partecipative, si attivano percorsi di consapevolezza utili all’individuazione dei meccanismi dell’hate speech e al loro superamento9. Per le classi terze, infine, si propone un laboratorio che si articola in due incontri, di due ore ciascuno: Democrazia in Comune. La scelta tematica e metodologica, in questo caso, conferma il proposito di lavorare sull’educazione civica: ci si rivolge a studenti e studentesse che stanno studiando il Novecento come da programma, per ragionare con precisione degli avvenimenti dell’eccidio. Di seguito il laboratorio didattico-sperimentale ricostruisce una versione di quella storia grazie alla partecipazione attiva della classe. Attraverso un gioco di ruolo10, gli studenti e le studentesse, sono, di fatto, chiamati a interagire per comprendere i meccanismi della democrazia partecipata.
3.3. Scuola secondaria di secondo grado
Per la classe prima della secondaria di secondo grado si propone l’attività Di guerra e di genti che muove dalla lettura in aula di uno dei racconti dell’omonimo libro in una parallela contestualizzazione diacronica11. A riallacciare il discorso storico della Linea Gotica, come per la quarta della primaria, è un prodotto letterario. I racconti commentanti serviranno da stimolo per la consegna alla classe: immaginare un finale della vicenda. Nella parte finale dell’incontro, in un momento di restituzione condivisa la proposta verrà commentata. Alle classi che aderiscono all’iniziativa viene, inoltre, offerta l’opportunità di visitare l’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, che conserva documenti relativi alla strage di Monte Sole e alle successive commemorazioni dell’eccidio12. Il tema al centro della proposta didattica per le classi seconde è l’esclusione, trattata in prospettiva storica e nelle sue dinamiche attuali. Anche per questa attività – Discriminazione: che brutta storia – è prevista una fase creativa: se nel primo anno il linguaggio proposto è quello della scrittura, nel secondo la consegna è la realizzazione di un prodotto audiovisivo da sceneggiare, girare e montare nel corso dell’anno scolastico. Il tema proposto al terzo anno richiama i percorsi proposti per la prima e la seconda della secondaria di primo grado con il richiamo specifico alla media education. Il laboratorio interattivo sulle fake news ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici e utili a definire, riconoscere e decostruire le fake news13. L’attività di confutazione di notizie o affermazioni false (debunking) svolta in classe, è accompagnata da una riflessione sulla psicologia dei nuovi media utile ad inquadrare questi fenomeni e ad acquisire competenze strategiche per la costruzione di una cittadinanza digitale consapevole. Cooperare e competere è il laboratorio per le classi quarte: si tratta di due termini o, meglio, due attività che quotidianamente inducono alla strutturazione di relazioni con gli altri. In questo laboratorio, gli studenti e le studentesse sono chiamati a dividersi in squadre e a sperimentare le due opzioni in contesti differenti. Al termine dell’attività, l’obiettivo sperato è il raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei benefici e dei limiti della cooperazione e della competizione. Per le classi quinte, infine, l’attività Mafia, antimafia, legalità si propone di analizzare Cosa Nostra da due angolazioni: gli eventi storici e i processi di creazione dell’immaginario collettivo che ne sono corollario. La ricostruzione delle biografie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – realizzate con strumenti digitali che permettono di aprire approfondimenti con fonti di differente tipologia – aiuta a comprendere il contesto storico nel periodo compreso tra l’ascesa del clan dei Corleonesi al vertice di Cosa Nostra (1978-83) e le stragi del 23 maggio e 19 luglio 1992. Attraverso l’analisi di fonti multimediali (video, immagini e articoli di giornale) sarà possibile spostare lo sguardo su come i media contribuiscono a costruire un immaginario collettivo potentissimo, strettamente connesso alla narrazione delle biografie dei protagonisti di mafia e antimafia14.
3.4. Scuola dell’infanzia
A chiudere la presentazione dell’Offerta formativa, ma ad anticipare il curricolo verticale, è la proposta didattica rivolta alla scuola dell’infanzia e curata dalla Scuola di Pace. La proposta per questa fascia d’età affronta diverse possibili tematiche, tutte propedeutiche alla promozione di un lavoro di comunità e nelle comunità: le emozioni, la diversità, il benessere nel gruppo, i diritti dell’infanzia. La proposta educativa si articola in diversi incontri di 45 minuti circa (dai 3 ai 5 appuntamenti) e, quasi in una logica sartoriale, viene co-progettata con le insegnanti per quanto riguarda modalità, tempi e contenuti con l’obiettivo di costruire un percorso che sia armonico con il progetto educativo della scuola.
4. Il lavoro sull’Ottantesimo della Liberazione e gli spunti per le implementazioni tematiche dell’offerta
Per concludere questa rassegna di azioni messe in campo nel contesto della collaborazione fra Istituto Parri e Comitato onoranze si riportano i risultati di due esperienze recentissime, sviluppate in occasione dell’Ottantesimo anniversario della lotta resistenziale e della Liberazione. La riflessione sulla didattica istituzionale dei due enti, infatti, si rinnova annualmente attraverso la progettazione di pratiche didattiche e divulgative per la comprensione della storia di quanto accadde nei venti mesi che intercorrono dall’armistizio alla liberazione. Nel triennio 2023-25, in occasione delle celebrazioni per l’Ottantesimo della Liberazione, una riflessione di questo genere è risultata centrale e ha impegnato moltissimo del lavoro del Parri. Non si è trattato di agire per finalità puramente celebrative – e del resto, come Istituto dedicato alla Resistenza, si realizzano ogni anno percorsi didattici sul tema, apriamo la sede il 25 aprile accogliendo centinaia di persone nei nostri spazi e valorizziamo il patrimonio documentale, fotografico e audiovisivo che, in grande maggioranza, è costituito da materiali di quell’esperienza storica – ma, soprattutto nell’anno 2025, è stato fondamentale concentrarsi sull’anniversario specifico e la sua portata nelle politiche complessive della memoria. La ricaduta di queste nuove buone-pratiche avrà sicuramente un risultato nelle progettualità degli anni a venire e costituirà il sostrato delle scelte da portare avanti nella collaborazione con il Comitato. Per proporre una sintesi: nell’anno scolastico 2021-22 delle venticinque attività proposte nel Piano dell’Offerta Formativa due richiamavano al triennio 1943-4515; mentre nell’anno scolastico 2024-25 erano salite a dieci su trenta16. Tra queste la più interessante per l’argomento qui trattato è «Ho solo eseguito gli ordini»: stragi di guerra. Il metodo è quello, molto utilizzato a scuola, soprattutto nella trattazione della Resistenza, del recupero di storie esemplari per richiamare il contesto complessivo e ingaggiare l’attenzione. Di solito uno spazio rilevante è dedicato alle testimonianze dei sopravvissuti e alla ricostruzione delle biografie delle vittime, mentre con maggiore difficoltà si richiama il ricordo di chi si è macchiato di terribili misfatti17. Come indicato da Nadia Baiesi, la figura del perpetratore costituisce una grande sfida educativa. Già nel 2015 Simon Levis Sullam ammoniva che l’Italia fosse «passata dall’era del testimone che ha dato centralità all’esperienza e alla memoria delle vittime […] a quella che potremmo chiamare l’era del salvatore che celebra i soccorritori, senza passare da alcuna era del carnefice che ne esaminasse a fondo i misfatti, su cui è sceso, anzi, un colpevole oblio»18. L’attività proposta risponde a questa esigenza/sfida. Fonte d’ispirazione e di riferimento, oltre all’Atlante delle stragi nazifasciste curato dall’allora Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (oggi Istituto nazionale Ferruccio Parri) e dall’Anpi19, è il portale NS-Täter, con la direzione scientifica di Carlo Gentile e finanziato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania nell’ambito del Fondo per il futuro italo-tedesco20. Il portale nasce dalla raccolta di voci, immagini e testimonianze dei soldati tedeschi in Italia e in particolare dei täter (tradotto con perpetratori, autori) di quelle stragi: si tratta di diari di guerra, deposizioni processuali, interviste e inchieste giornalistiche, effettuate dall’immediato dopoguerra fino agli anni Duemila. L’obiettivo del lavoro di ricerca è di «contribuire allo sviluppo di una nuova cultura della memoria tra Italia e Germania, per poter ampliare le prospettive scientifiche ed educative»21. A partire dai contenuti e dalle fonti del portale è stata progettata un’azione didattica inserita nel nostro Piano dell’Offerta Formativa che ha avuto l’obiettivo di mettere a fuoco le figure dei täter concentrandosi su due casi-studio relativi a stragi poco note avvenute lungo la Linea Gotica: Monchio, Susano e Costrignano nel marzo 1944 (Emilia-Romagna) e Vinca nell’agosto 1944 (Toscana). L’utilizzo della documentazione presente sul portale ha consentito di approfondire le biografie dei responsabili per delineare scelte ed esperienze, disposizioni psicologiche e modelli di legittimazione delle loro azioni. L’attività, strutturata seguendo il modello operativo dei nostri percorsi didattici, nello specifico dello storytelling, si apre con un prologo (dedicato al contesto della Germania Ovest del dopoguerra) e si chiude con un epilogo (che ricostruisce i processi di Francoforte e di La Spezia). Dopo una fase di contestualizzazione storica dedicata all’Italia fascista, poi alla guerra e infine all’occupazione nazifascista, la dimensione del biografico si alterna con la ricostruzione del contesto delle stragi in Italia. Guidano la narrazione le biografie di Helmut Looß, che ebbe un ruolo significativo in diverse stragi di civili (da Sant’Anna di Stazzema a Monte Sole, fino a Valla e a Vinca)22 e di Kurt Christian von Loeben che, nella primavera del 1944 guidò i rastrellamenti di Monchio, Susano e Costrignano, poi di Cervarolo e Civago, del Monte Morello, di Vallucciole e dell’area del Monte Falterona e, infine, di Mommio23. Le due stragi oggetto d’indagine sono ricostruite nei dettagli operativi grazie all’utilizzo di carte e mappe dinamiche. Dall’attività didattica si è poi sviluppato un Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) realizzato con due classi terze del Liceo classico Marco Minghetti di Bologna. Le due classi avevano svolto un Viaggio della Memoria finanziato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, nella località greca di Kalavrita: teatro di una strage compiuta da parte della 117ª divisione Jäger il 13 dicembre 1943 e durante la quale in una sola giornata sono uccisi più di seicento civili. Il prodotto finale di restituzione è stato la realizzazione di una mostra – tenuta nella Sala Berti dell’Istituto nell’aprile 2025 – con l’utilizzo di manufatti prodotti durante il viaggio, accompagnati da testi di accompagnamento, redatti con la consulenza scientifica del personale dell’Istituto.
Un’altra esperienza davvero interessante è stata la realizzazione del portale A passo di Liberazione 1945-202524, curato dall’intera rete regionale degli istituti storici della Resistenza e realizzato grazie al finanziamento di Regione Emilia-Romagna e dell’Assemblea Legislativa Emilia-Romagna. Frutto di un lungo lavoro di ricerca e di scrittura, il portale si propone di ripercorrere e dare una visione d’insieme di quella che è stata la lunga liberazione del territorio regionale emiliano-romagnolo seguendo le tracce lasciate dal passaggio del fronte, rivivendo le azioni e le battaglie partigiane e attraversando i luoghi di manifestazioni sociali, di repressione e di scontri sui territori provinciali. Ricerca storica, documentazione e racconto tradotti in linguaggi adatti alla mappatura digitale forniscono un quadro semplice e preciso della fine della guerra in Emilia-Romagna. Il risultato è il frutto di una selezione degli accadimenti e dei protagonisti che hanno maggiormente inciso sul processo di Liberazione nell’intero territorio regionale e non solo dei capoluoghi. Visioni multiple rispetto alle ricostruzioni di carattere provinciale, capaci di proporre quadri storiografici e memoriali di natura tematica trasversali rispetto ai perimetri “amministrativi”. Per queste ragioni il portale si struttura in una mappa digitale della regione che dialoga con una linea del tempo, capace di abbracciare l’intera fase della liberazione regionale (da agosto 1944 a maggio 1945) e offrire una modalità di analisi degli eventi storici geografica, ma anche diacronica e sincronica. Ciò che emerge è un’immagine solo apparentemente statica navigabile attraverso la mappa regionale e la linea del tempo: la storia scorre nella visualizzazione digitale attraverso i mesi della fine della guerra e della liberazione dall’occupazione militare tedesca e da ciò che rimaneva del fascismo in divisa repubblicana. Scorrendo la timeline – che offre una cronologia puntuale, giorno per giorno – è possibile rintracciare sul territorio ciò che avvenne in un dato periodo nelle diverse province e interrogare la mappa utilizzando filtri territoriali e/o tematici per ricerche specifiche. L’utilizzo dei filtri territoriali è degno d’interesse: alle nove province che compongono la regione, si è scelto di dedicare un approfondimento geografico alla Linea Gotica (con anche una scheda dedicata all’eccidio di Monte Sole). Significativa dal punto di vista dell’approccio metodologico è la scelta dei filtri tematici: Battaglie e scontri sulla Linea Gotica; Offensive tedesche/fasciste; Presenza degli Alleati; Azioni e battaglie partigiane; Manifestazioni sociali e pubbliche; Repressione e luoghi di detenzione. Nella progettazione e nella realizzazione del portale ampio spazio è dedicato ai luoghi, alle stragi, alla ricostruzione storica di eventi che, a distanza di ottant’anni, impongono un ragionamento sulla memoria che è parte integrante della riflessione condotta nella progettazione Parri/Comitato.
5. Conclusioni
L’esperienza dell’Offerta formativa Parri/Comitato è stata premiata da buoni risultati. Prendendo in analisi il triennio 2023-2025, parliamo di 228 interventi in classe, con più di 5.000 studenti raggiunti. Nell’anno scolastico 2022-23 sono state realizzate 34 attività alla scuola primaria, 26 alla secondaria di primo grado e 13 alla secondaria di secondo grado (qui nel suo primo anno di sperimentazione). Nell’anno scolastico 2023-24, 40 attività per la scuola primaria, 20 per la secondaria di primo grado e 21 per la secondaria di secondo grado. Nell’anno scolastico 2024-25, infine, 38 alla primaria, 12 alla secondaria di secondo grado e 24 alla secondaria di secondo grado. Le richieste raggiunte – rispettivamente 73 per il primo anno scolastico preso in esame, 81 per il successivo e 74 per quello appena concluso – confermano un trend positivo che spinge le due istituzioni a confermare il proprio impegno, suggerendo anche l’idea di una possibile implementazione.
Note
1 Maria Laura Marescalchi, Didattica con i luoghi della memoria, in Francesco Monducci, Agnese Portincasa (a cura di), Insegnare storia nella scuola secondaria, Torino, UTET, 2023; Nadia Baiesi, Storia e memoria: percorsi educativi attraverso i luoghi, in Alessandra Chiappano, Fabio Minazzi (a cura di), Il presente ha un cuore antico. Atti del Seminario residenziale sulla didattica della Shoah (Bagnacavallo, 16-18 gennaio 2003), Milano, Thélema, 2005; Nadia Baiesi, Gian Domenico Cova, Educa il luogo, in Tristano Matta (a cura di), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Milano, Electa, 1996.
2 Per uno sguardo complessivo sul curricolo si veda Mario Castoldi, Curricolo per competenze: percorsi e strumenti, Roma, Carrocci, 2018 (I ed. 2013).
3 Elena Bergonzini, Il luogo di memoria come opportunità educativa, in Francesco Monducci, Agnese Portincasa, Insegnare storia alla scuola primaria. Il laboratorio storico e altre pratiche attive, Torino, UTET, 2022.
4 Sul tema la Scuola di Pace di Monte Sole svolge da anni un lavoro importante, soprattutto con le fasce d’età minori, ma non solo. Per approfondire si veda Nadia Baiesi, Monte Sole: un luogo contaminato per educare alla pace, in Alessandra Chiappano, Fabio Minazzi, Il paradigma nazista dell’annientamento: la shoah e gli altri stermini. Atti del quarto Seminario residenziale sulla didattica della shoah (Bagnacavallo, 13-15 gennaio 2005), Firenze, La Giuntina, 2006.
5 Per un approfondimento metodologico si veda Antonio Brusa, Giochi per imparare la storia. Percorsi per la scuola, Roma, Carocci, 2022 e Marco Tibaldini, Il gioco nella didattica della storia, in Monducci, Portincasa, Insegnare storia nella scuola primaria, cit.
6 Per una stimolante proposta d’analisi sul tema si veda Claudia Bianchi, Hate Speech. Il lato oscuro del linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2021.
7 Paola Villano, Psicologia sociale, Bologna, Il Mulino, 2016.
8 Rupert Brown, Psicologia sociale del pregiudizio, Bologna, Il Mulino, 2013 (ed. orig. Prejudice: Its Social Psychology, Chichester, Wiley, 2007).
9 Gianna Cappello, La media education a scuola. Un approccio olistico per la costruzione della cittadinanza digitale, in David Buckingham, Un manifesto per la media education, Milano, Mondadori Education, 2020.
10 Per una proposta relativa all’utilizzo del gioco di ruolo nella didattica si veda Igor Pizzirusso, Giocare (con) la storia d’Europa: costruire un gioco di ruolo in classe, in “Novecento.org”, n. 21, giugno 2024.
11 Andrea Marchi, Gabriele Rocchetti, Massimo Turchi, Di guerra e di genti. 100 racconti della Linea Gotica, Bologna, Pendragon, 2020.
12 https://www.martirimarzabotto.it/archivio/.
13 Giuseppe Riva, Fake news. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità, Bologna, Il Mulino, 2018.
14 Per una descrizione più approfondita dell’attività si veda Filippo Mattia Ferrara, Davide Sparano, 1992. Mafia e antimafia tra storia e media, in “Novecento.org”, n. 17, giugno 2022.
15 Una passeggiata storica sui luoghi della resistenza bolognese e uno storytelling sull’Operazione Radium.
16 A partire dall’anno scolastico 2024-25 abbiamo deciso di articolare la nostra offerta formativa in aree tematiche. Prima, e non solo in ordine cronologico, è 1945-2025/Non è archiviata. Ottant’anni dalla Liberazione. L’obiettivo è di offrire alle classi una storia della Resistenza, declinata in chiave nazionale e locale. Per la prima due storytelling dedicati all’8 settembre 1943 e al 25 aprile 1945, per la seconda una camminata storica nei luoghi della città e tre attività/laboratorio realizzate con le fonti del nostro archivio, per inquadrare i temi della lotta armata, della Resistenza civile e del ruolo delle donne. A completare la sezione tematica abbiamo pensato a una storia della Prima Repubblica letta in una sorta di “a ritroso”, come a parafrasare la frase di Italo Calvino: «Tutto è sempre cominciato già da prima». Nell’area Zone di interesse. La violenza fatta sistema (1935-1945) dedichiamo un percorso alle le stragi nazifasciste in Italia.
17 Nadia Baiesi, Alla ricerca di un carnefice, in “Novecento.org”, n. 6, luglio 2016.
18 Simon Levis Sullam, I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei 1943-1945, Milano, Feltrinelli, 2015.
19 https://www.straginazifasciste.it/.
20 https://www.ns-taeter-italien.org/it/.
21 Ibidem.
22 https://www.ns-taeter-italien.org/it/taeter/helmut-looss.
23 https://www.ns-taeter-italien.org/it/taeter/kurt-christian-von-loeben.