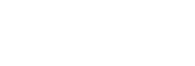In apertura: stabilimento dismesso Falck, Sesto San Giovanni (Foto di Giampietro Agostini, 2002. Milano, Raccolte grafiche e fotografiche del Castello Sforzesco. Civico archivio fotografico, fondo Ex Fabrica – Giampietro Agostini, Francesco Giusti, Tancredi Mangano, serie GA, inv. EF GA 30).
1. Milano e la deindustrializzazione
«[Gli operai] sembrano quattro gatti che vengono fuori da una piccola azienda. [In passato] si era abituati a vedere masse di operai che uscivano. Questo fa sentire proprio una grossa tristezza». Sono queste le parole di uno degli operai della Pirelli-Bicocca di Milano intervistati dal regista Silvio Soldini durante le riprese de La fabbrica sospesa. Sono queste le parole di chi ha vissuto la progressiva diminuzione della classe operaia, a partire dagli anni Settanta e che si pone, oggi, come uno dei sintomi della deindustrializzazione della città. Milano, con le sue fabbriche, i quartieri industriali e la classe operaia sembra essere oggi un lontano ricordo. Il capoluogo lombardo, durante il Novecento, ha vissuto un grande sviluppo industriale, con aziende quali la Pirelli, la Breda e l’Alfa Romeo, fino all’arrivo della deindustrializzazione, manifestatosi con la «contrazione dell’apporto dell’industria allo sviluppo e indebolimento del suo ruolo nell’ambito dell’economia nel suo complesso sia dal punto di vista dell’occupazione che del valore della produzione»1, con l’abbandono degli stabilimenti produttivi e con la frammentazione della classe operaia. Da città operaia, Milano è oggi una città post-fordista e terziaria. A partire dagli anni Settanta, a Milano e nella provincia si registra un calo degli addetti nell’industria manifatturiera, che, fra il 1971 e il 1981, calano dagli 821.082 ai 756.359, fino ai 405.482 addetti del 20112. A partire dalla metà degli anni Settanta, le grandi imprese lombarde subiscono trasformazioni produttive, con l’introduzione di macchinari labour saving, funzionali all’aumento della produttività attraverso una contrazione della forza lavoro; delocalizzazioni, con il trasferimento o nelle zone marginali della regione o all’estero di alcune fasi della produzione; modificano le mansioni, accorpando in uno stesso lavoratore più attività differenti, con la conseguente diminuzione della quota di addetti.
Negli anni Ottanta incominciano a verificarsi profonde crisi che colpiscono, tra le tante, la Pirelli, l’Innocenti e la Falck, che chiudono i loro reparti produttivi, licenziano parti consistenti della manodopera e delocalizzano attività all’estero. Una conseguenza della chiusura delle aziende è la comparsa, sul territorio milanese, degli scheletri delle fabbriche abbandonate, soprattutto nelle zone dell’Asse del Sempione e del Nord di Milano3. Nel 1988 la porzione delle aree industriali dismesse nel circondario comunale di Milano è di 4,6 milioni di metri quadrati; nel 2002 la cifra raggiunge i 7 milioni4.
Il progressivo declino dell’occupazione manifatturiera e dei grandi stabilimenti industriali incide anche sui quartieri in cui sorgevano le fabbriche, incentivando progetti di riqualificazione e di sviluppo di attività terziarie. Ne è esempio il quartiere Bicocca, che a partire dagli anni Novanta, diventa il simbolo della Milano post-industriale. Al posto dei capannoni della Pirelli, sorgono oggi stabilimenti che non producono più beni materiali ma immateriali, come ricerche, idee e innovazioni. Qui, infatti, si trova l’Università degli Studi di Milano Bicocca, che segna il passaggio da un quartiere incentrato sulla fabbrica ad uno che gira attorno all’economia della conoscenza. La vecchia classe operaia che viveva quotidianamente gli spazi della produzione e del quartiere viene sostituita da una diversa componente sociale, gli studenti. Secondo Luca Rimoldi, antropologo che ha condotto una ricerca sugli ex operai della Bicocca, all’interno del quartiere «si assiste al lineare passaggio fabbrica/università che implica, tra le altre cose, una sostituzione degli abitanti del quartiere (da operai a studenti)»5. L’espressione di Giorgio Bigatti, «dalla fabbrica delle cose alla fabbrica delle idee»6, racconta efficacemente questo processo.
La Bicocca, pur mostrando la sua nuova vocazione terziaria con aziende multinazionali come ING, il teatro Arcimboldi e il centro artistico HangarBicocca, non cancella nello spazio la sua storia industriale. Le tracce del passato industriale, che si pongono oggi come una testimonianza simbolica della storia del lavoro del Novecento, si riscontrano nella toponomastica, come viale Piero e Alberto Pirelli, viale dell’Innovazione e via Breda e nell’ambiente urbano con la Torre Sarca e la torre di raffreddamento della Pirelli, circondata da vetrate che la custodiscono come in una teca museale7.

Fig. 1. Pirelli Headquarters, Bicocca. Vista notturna della facciata ovest (Archivio fotografico Gregotti Associati, foto di Donato Di Bello).
Milano perde le sue fabbriche, ma, parallelamente, l’hinterland e le zone periferiche della regione vedono, a partire dagli anni Ottanta, il permanere della presenza industriale8. Lo storico Giuseppe Berta accenna ad una nuova geografia:
Lo scorcio finale del Novecento assiste dunque ad una trasformazione che introduce un rivolgimento nella configurazione e nella geografia della struttura industriale […]. Cambia a tal punto l’insediamento dell’industria nella società che sembra si sia comunicata una scossa di terremoto alle basi storiche dell’industrializzazione9.
Così, di fronte alla deindustrializzazione dei centri cittadini come Milano e Torino, si assiste alla industrializzazione di altre, con stabilimenti mutati: più snelli, di minor dimensione e a maggior composizione organica del capitale. In relazione alla scomparsa della produzione, da un lato, e alla sua nuova presenza, dall’altro, Berta sostiene:
Il paradosso apparente dell’Italia di fine secolo sta nell’essere una nazione che patisce sia di un eccesso di industria che del suo contrario. O meglio, è un paese che conserva un comparto manifatturiero diffuso, ma con un numero decrescente di imprese di grandi dimensioni. […] Lo scenario di crisi è tuttavia contraddetto da altre tendenze che impediscono quella caduta verticale dell’impresa che in effetti non si è verificata. La prima di esse è l’ascesa […] dell’impresa di medie dimensioni, che forma ormai una sorta di nuova ossatura […] del Nord Ovest. […] La determinante del loro sviluppo è identificata nell’aumento dell’intensità di capitale con la conseguente introduzione di innovazioni di processo10.
Si tratta, per Berta, di una metamorfosi:
Un’evoluzione che non si saprebbe definire con un termine diverso da quello di metamorfosi: un processo che, da un lato, sommerge il paesaggio industriale del Novecento […], per lasciare affiorare, dall’altro, una nuova architettura economica, contrassegnata dalla condizione progressivamente centrale dell’universo delle medie imprese. […] Siamo davanti a una metamorfosi economica e produttiva e non a una mera perdita o scomparsa delle componenti maggiori del sistema industriale11.
2. Una fonte audiovisiva: La fabbrica sospesa
È proprio nel quartiere Bicocca, nello stabilimento Pirelli-Bicocca, che il regista Silvio Soldini gira le scene per il suo documentario, La fabbrica sospesa, una pellicola commissionata dall’azienda Pirelli al regista e ultimata nel 198712. In essa sono raccolte le interviste svolte da Soldini a chi ha lavorato nello stabilimento appena prima della sua chiusura, avvenuta a metà degli anni Ottanta. Questa fonte si pone come un interessante racconto della deindustrializzazione, che, oltre a riportare la vera voce dei protagonisti, attraverso l’immagine, resa possibile dallo strumento della cinepresa, ne mostra anche i visi, i corpi e le espressioni. La fabbrica sospesa è uno degli esempi che testimoniano il rapporto fra la produzione audiovisiva o cinematografica e l’industria, insieme, ad esempio, a Tutto era Fiat di Mimmo Calopresti (1999) o La classe operaia va in paradiso di Elio Petri (1971)13. Questo documentario, però, rappresenta un caso particolare in quanto commissionato dalla Pirelli stessa per testimoniare, anche dal punto di vista estetico, lo sviluppo tecnologico dell’azienda, ma dal quale emerge un percepibile sentimento di disgregazione della stessa, soprattutto dal punto di vista politico e sociale.

Fig. 2. Operai fuori dallo stabilimento, da La fabbrica sospesa, 06:32.
La storia dello stabilimento viene letta attraverso i sentimenti dei lavoratori, dal senso di fratellanza fra gli operai, fino all’amarezza di fronte alla chiusura dello stabilimento.
Gli operai, sorridendo, ricordano cos’era per loro la fabbrica, percepita come una famiglia. Uno di loro, con orgoglio, racconta la fabbrica in termini di collettività, di lotta e della sensazione di sentirsi parte di un’entità più grande:
Per me la Bicocca, è stato proprio, anche in prima persona, dato che ero coinvolto anche politicamente, una questione di vita; conoscere le lotte, il movimento operaio. Eravamo 12.000 lavoratori qui dentro. Era un centro di vita. […]. E poi c’è anche questo legame che lega noi operai. C’è questa grande cosa all’interno dei grandi stabilimenti che lega un operaio verso un altro. Diventa uno dei punti di vita, dato che passi la maggior parte delle ore in fabbrica.
Nei ricordi, la fabbrica veniva vissuta non solo come un luogo di lavoro, ma come un’esperienza di vita, capace di creare un legame forte fra i lavoratori, avvalorato spesso dalle lotte condivise. Spiega così un altro operaio: «il sentimento è questo: sicuramente dove ci si è vissuti, almeno io che, per quanto mi riguarda, sono 26 anni che sono qua dentro, sono passate parecchie cose. Prima il ’68, poi gli anni che hanno succeduto. C’è stata una serie di condizioni che, secondo me, hanno dato un qualcosa, soprattutto una esperienza. Se si vuole un legame».
A far sentire i lavoratori parte attiva della fabbrica era anche la produzione. Gli operai, attraverso le loro conoscenze e le loro capacità, si sentivano i diretti fautori del prodotto, nato dalle loro mani. Questi lavoratori conoscevano ogni meccanismo delle macchine e del processo produttivo. Viene ricordata, con fierezza, la soddisfazione di fronte al buon funzionamento degli pneumatici nelle gare motociclistiche:
Si aspettava il giorno della gara [in cui vengono utilizzati pneumatici Pirelli], per vedere, perché si era un po’ partecipi di questo, perché ognuno avrebbe potuto dire “beh in quel frangente lì anche io sono servito a prepararlo”. E c’era un attaccamento enorme alla gara. Si era molto entusiasti.
Un tema centrale nelle parole dei lavoratori è anche la mobilità. Ad essa è connessa la tendenza, a partire dagli anni Settanta, a delocalizzare gli stabilimenti industriali nei paesi con un costo della manodopera minore. Sono molti i lavoratori ad essere delocalizzati in Iran, India e nell’est Europa. Racconta un operaio:
Ho incominciato a lavorare come manutentore, riparazione, pronto intervento. Poi sono passato nella preventiva, dove si fa la revisione delle macchine, si mettono a nuovo le macchine. Dopo ho cominciato ad andare in giro per la Pirelli. Ho incominciato con la Tunisia. Poi sono stato in Russia, in India, in Bulgaria in Russia. […] Io ero un semplice operaio ma la Pirelli preferisce mandar giù operai esperti al posto di ingegneri.
Chi giungeva in questi paesi, oltre a portare avanti la produzione, aveva il compito di formare la forza lavoro locale, dopo di che, tornava in Italia. Il compito principale era quello di delocalizzare conoscenze e capacità:
L’Iraq, poi l’Iran, dopo di che sono stato, ultimamente, in Tunisia. Prevedo di andare in Cina. Il nostro lavoro lì è [il seguente]: seguiamo un momentino quello che è il discorso dell’impianto, della costruzione vera e propria dell’impianto, poi le fasi di messa a punto e di collaudo. Dopo di che diamo un minimo di formazione al personale locale e, se tutto va bene, ce ne torniamo a casa.
Oltre alla già intrapresa ristrutturazione produttiva, nel 1985 la Pirelli decide di delocalizzare il comparto produttivo dello stabilimento, mantenendo attivi quelli della direzione, progettazione e ricerca. Lo stabilimento Pirelli-Bicocca, infatti, perde la sua caratteristica di produzione, come riporta un impiegato: «Adesso la Bicocca, come centro produttivo, è diminuito, perché la Pirelli sta decentrando gli stabilimenti. Però rimane ancora il centro mondiale della ricerca, anche se gruppi di ricerca sono nati sia in Brasile che in Germania». Negli anni Ottanta, come spiega un rappresentante dell’azienda, incominciano le prime riorganizzazioni produttive, con la formazione del personale verso nuovi settori come la meccatronica:
Abbiamo iniziato un’esperienza rivolta già agli ultimi giovani che sono usciti dall’Istituto Piero Pirelli. Li abbiamo assunti in Pirelli in Bicocca e li stiamo preparando nel campo della meccatronica. Durante le ore di lavoro vengono staccati e da Bicocca raggiungono l’Istituto Piero Pirelli, per potersi perfezionare nel campo della manutenzione polivalente.
Se l’azienda vede positivamente lo sviluppo di nuovi comparti e la trasformazione delle fasi produttive, per gli operai il confronto con il passato e soprattutto con il lavoro manuale è costante, come spiega un operaio visibilmente sconfortato dai cambiamenti avvenuti: «una volta si lavorava manualmente. Non è adesso che ci sono i mezzi e i carrelli».
Sembra, infatti, che il lavoro manuale degli operai non sia più necessario e che, come si vede in svariate riprese del documentario, si sostanzi solo nel guidare carrelli o nel premere bottoni. I lavoratori percepiscono di essere stati sostituiti ora dalle macchine ora dalla ricerca e dall’innovazione. Racconta un operaio, il cui viso manifesta la sua sensazione di delusione e tradimento: «Bicocca dovrebbe essere questo [ricerca]: ma questo è le tecnologie, le ricerche, sono i palazzi. Ma gli uomini?». Giuseppe Berta parla di una fabbrica che si è
impoverita di uomini e donne, si è arricchita di macchine, fino al punto di far coltivare per un poco l’illusione di una unmanned factory, un ambiente di lavoro regolato per intero dalle tecnologie, assoggettato al controllo dei dispositivi automatici così da relegare il contributo umano in un semplice ruolo accessorio. Segnali controversi e contraddittori, ma che stingono la presenza operaia fino al limite di farla concepire come residuale, come una sorta di sacca sociale che si spoglia progressivamente, oltre che della sua identità collettiva, della sua forma unitaria e definita, convertendosi in una mera riserva di lavoro a cui nel futuro si potrà attingere sempre di meno14.
Con lo smantellamento della fabbrica e con la riconversione da impianto produttivo a polo di ricerca, si pone fine ad una quotidianità fatta da migliaia di operai che si sentivano parte di un corpo collettivo. Dalle loro parole traspare anche un sentimento di tristezza e di solitudine di fronte alla scomparsa della componente operaia, sostituita dai ricercatori:
Fino a dieci anni fa c’erano masse di operai e impiegati che entravano e che uscivano. Certo che questo viene a mancare. Ognuno di noi quando si guarda in giro, soprattutto alle 5, quando si esce, e sembrano quattro gatti che vengono fuori da una piccola azienda, quando [in passato] si era abituati a vedere masse di operai che uscivano. Questo fa sentire proprio una grossa tristezza. Viene un qualcosa dentro di noi che adesso io non riesco a spiegare. […] Il futuro sarà ancora di 10 o 12 mila, come era la grande fabbrica, ma saranno tutti ricercatori. In questo vuoto tra ricerca e nuovo sviluppo c’è questa caduta.

Fig. 3. Operai che vanno via dallo stabilimento, da La fabbrica sospesa, 44:18.
La dismissione definitiva dello stabilimento della Pirelli-Bicocca viene mostrata attraverso immagini che ritraggono edifici vuoti, ricoperti d’edera, in cui la presenza operaia sembra non esserci più. Si vedono finestre rotte, macchinari fermi, in una condizione di totale abbandono. Si sente solo il silenzio, contrapposto al rumore della produzione. Le immagini immortalano un tempo fermo e vuoto. Nell’ultima scena si vedono due operai, vestiti di bianco, che se ne vanno di spalle.
Questo documentario ha come filo conduttore le vicende umane che si sono susseguite all’interno delle mura industriali, come riporta Soldini in un’intervista allo scrittore Andrea Kerbaker:
Visto che il filo conduttore del discorso non sarà costituito dagli edifici in quanto tali ma dalle presenze umane che sono esistite tra questi muri, ho cominciato con delle interviste: ho incontrato una trentina di persone che hanno lavorato o ancora lavorano in Bicocca e sceglierò sette/otto tra le testimonianze più significative15.
Il documentario viene girato e montato nel momento di declino dello stabilimento della Pirelli-Bicocca. Nel 1985 l’azienda firma un accordo con il Comune di Milano per trasformare l’area dove sorge la ex fabbrica in un polo tecnologico. Come riporta Giorgio Bigatti, per i vertici aziendali non significa dismissione, ma sviluppo e adattamento ai tempi nuovi, in una città come Milano in costante cambiamento:
La dismissione della Bicocca non intendeva essere la messa in liquidazione di questa storia, ma il suo adattamento ai tempi nuovi. In questo senso, secondo la direzione aziendale, non era semplicemente una profittevole operazione immobiliare ma incarnava una visione di sviluppo16.

Fig. 4. Stabilimento ormai abbandonato, da La fabbrica sospesa, 08:59.
Il caso della Bicocca e della riconversione del quartiere da industriale a terziario viene considerato una delle prime esperienze in Italia di recupero delle aree industriali dismesse, come riporta Ornella Castiglione:
A inaugurare la stagione urbana post-industriale di Milano è stato il progetto della trasformazione dell’ex-area Pirelli denominato «Bicocca» a firma dello studio di Vittorio Gregotti, considerato la prima esperienza in Italia sia per le dimensioni di vasta scala che per il tema del recupero delle aree dismesse. Il nucleo centrale della questione riguarda la nuova forma che Milano deve darsi, a partire dagli anni ’80, attraverso una trasformazione che è al contempo trasfigurazione, come avverrà in altre città del Nord – Torino e Genova in primis –, sedi di importanti insediamenti produttivi sorti tra la fine dell’800 e i primi decenni del ’90017.
Questo stesso quartiere, però, non rinnega né cancella il suo passato, rimanendo, come sostiene Ornella Castiglione, in uno spazio «sospeso tra il passato e il futuro»18, in cui il passato industriale è ancora presente. Lo si ritrova nello spazio, negli scheletri delle fabbriche abbandonate, nei nomi delle vie, nelle cartoline, ma lo si ritrova soprattutto nelle memorie di chi quella realtà ha vissuto e che vive oggi una città diversa e in cui la centralità e il potere operaio hanno perso il proprio spazio, economico, sociale e politico.
Note
1 Gabriella Corona, Volti e risvolti della deindustrializzazione. Alcuni interrogativi sulla contemporaneità, in “Meridiana”, 2016, n. 85, p. 9.
2 Istat, 5° Censimento Generale dell’industria e del commercio. Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali. Milano (1971) – Addetti per unità locali per categoria posizionale, sesso e per ramo, p. 49; Istat, 6° Censimento Generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato. Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali. Milano (1981) – Addetti alle unità locali per categoria posizionale, sesso e per ramo, p. 46; Comune di Milano, I dati del Censimento 2011 a Milano – Condizione occupazionale, 2011, p. 100.
3 Elisa Bianchi, Maristella Bergaglio, Il riuso delle aree dismesse: la valorizzazione della mezzaluna meridionale di Milano, in “Acme”, vol. LVII, n. 1, 2004, p. 225.
4 Censis, XXXVI rapporto annuale sulla situazione sociale del paese, 2002, p. 97.
5 Luca Rimoldi, Lavorare alla Pirelli-Bicocca. Antropologia delle memorie operaie, Bologna, Archetipo, 2017, p. 150.
6 Giorgio Bigatti, Crisi e rigenerazione urbana nella Milano contemporanea, in “Comparative studies in modernism”, 2020, n. 17, Torino, Università di Torino – Centro studi Arti della modernità, p. 219.
7 Ornella Castiglione, Il caso Pirelli-Bicocca. La fabbrica (dismessa) tra realtà e immagine, in “L’avventura”, 2020, n. 1, p. 32.
8 Giorgio Bigatti, Milano città plurale, in “il Mulino”, 2016, n. 2, p. 303.
9 Giuseppe Berta, L’Italia delle fabbriche. La parabola dell’industrialismo nel Novecento, Bologna, Il Mulino, 2009 (prima ed. 2001), p. 249.
10 Ivi, pp. 255-256.
11 Ivi, p. 258.
12 Silvio Soldini, La fabbrica sospesa, 1987, https://www.fondazionepirelli.org/archivio-storico/audiovisivi/detail/IT-PIRELLI-AV0001-000090/la-fabbrica-sospesa.html, ultima consultazione di tutti i link: 14 novembre 2024.
13 Cfr. Castiglione, Il caso Pirelli-Bicocca, cit.
14 Berta, L’Italia delle fabbriche, cit., p. 262.
15 “La fabbrica sospesa”: a colloquio con Silvio Soldini, https://www.fondazionepirelli.org/it/iniziative/la-fabbrica-sospesa-a-colloquio-con-silvio-soldini/.
16 Giorgio Bigatti, Giampaolo Nuvolati, Raccontare un quartiere. Luoghi, volti e memorie della Bicocca, Milano, Scalpendi, 2018, p. 28.
17 Castiglione, Il caso Pirelli-Bicocca, cit., p. 30.
18 Ivi, p. 39.