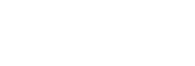In apertura: manifesto Festa nazionale Unità Ambiente, Ferrara 1983.
1. Premessa
Nel maggio 2024, a Bologna, partendo da Piazza dell’Unità nel cuore dello storico quartiere operaio della Bolognina, una quarantina di associazioni ambientaliste hanno manifestato contro le politiche della Regione Emilia-Romagna e per ricordare le vittime e gli sfollati dell’alluvione della primavera 2023, puntando l’indice soprattutto verso il consumo di suolo e, più in generale, verso il «paradigma di sviluppo dell’Emilia-Romagna caratterizzato dalla cementificazione»1.
Negli stessi giorni, sui maggiori quotidiani nazionali e internazionali, usciva la notizia relativa alle condizioni critiche della rete acquifera in Gran Bretagna, così inquinata da mettere a serio repentaglio la salute dei cittadini. La Gran Bretagna è diventata una fogna a cielo aperto, titolava il “Corriere della Sera”2. Il problema riguardava sia fiumi e laghi che acquedotti; si rimarcava come alla popolazione fosse consigliato di bollire l’acqua del rubinetto prima di usarla per scopi alimentari. La questione è diventata immediatamente politica, con dure prese di posizione soprattutto da parte laburista, dal momento che fornitura e reti idriche in Inghilterra furono privatizzate negli anni Ottanta all’epoca di Margaret Thatcher, e spesso, proprio per questo, «mettono il profitto davanti alla sicurezza»3.
Suggestivo, in sede di analisi storica, il riferimento alla Gran Bretagna, perché è il paese dove, tra Sette e Ottocento, con la Rivoluzione industriale, è nato il problema dell’inquinamento. In queste pagine, parleremo soprattutto di storia, ma la nostra, indubbiamente, è una riflessione “tra passato e presente”, come confermano le circostanze appena ricordate. Del resto, occupandoci di storia ambientale, troviamo conferma del filo rosso che lega spesso le domande che rivolgiamo al passato, cioè l’interesse verso particolari aspetti della storia, ai problemi e alle urgenze del presente.
La storia dell’ambiente è disciplina relativamente giovane. Si è fatta strada negli studi storici tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, quando è diventato più stretto il rapporto tra politica e ambiente4. Le prime opere storiografiche, in Italia come in tutta Europa, risalgono agli anni Novanta, alcune ricerche pionieristiche al decennio precedente, mentre negli Stati Uniti il maggiore consolidamento di questo filone di studi rimanda a un’esperienza non anteriore, comunque, agli anni Settanta5.
Una disciplina giovane, si diceva, tanto che, ad oggi, non disponiamo ancora di un’analisi sufficientemente esaustiva di come i partiti e le principali culture politiche italiane si siano confrontate con la questione ambientale6. Questo è vero a livello nazionale e, ancora di più, a livello regionale. Ci si muove, quindi, in un campo di studi che è ancora in parte da dissodare, benché non manchino contributi importanti. Certamente non manca la consapevolezza, come ha osservato Stefano Cavazza, che la storia politica non possa trascurare il tema dell’ambiente dal momento che esso è «diventato un rilevante tema di conflitto, conflitto che si esercita tra comunità locali, gruppi di interesse e classe politica e all’interno del sistema dei partiti e delle stesse formazioni politiche e tra soggetti diversi»7.
2. La “questione ambientale” prima dell’ambientalismo politico
Se è vero che l’ambientalismo politico prende le mosse, in Italia e in Europa, con il Sessantotto e con gli anni Settanta, è altrettanto vero che il dibattito pubblico sulla questione ambientale ha origini più risalenti. Storicamente, esso si afferma nel XIX secolo e questo accade in parallelo, si noti, all’emergere della cosiddetta “questione sociale”. Il tema dell’inquinamento, infatti, entra nel dibattito nella stessa fase storica – quella segnata dal primo sviluppo del capitalismo industriale, dalla crescita delle città e dall’impiego sempre più cospicuo di energia da fonti fossili (il carbone, in primis) – nella quale riformatori di diverso orientamento politico si cominciavano a confrontare sulle difficili condizioni di vita e sullo sfruttamento lavorativo di ampi settori popolari.
Gli scrittori sono tra i primi a denunciare i problemi ambientali delle grandi città industriali. Charles Dickens, nel 1853, apre il romanzo Bleak House descrivendo una Londra oscura, spettrale e affumicata, mentre nel successivo Uncommercial Traveller (1875) porterà una specifica attenzione sull’inquinamento dei quartieri più poveri. Non meno potente sarà la descrizione del sistema fognario parigino ne I miserabili (1862) di Victor Hugo8. L’intensità di questi problemi variava da paese a paese a seconda del diverso grado di sviluppo dei processi di industrializzazione, che a partire dalla Gran Bretagna, culla della rivoluzione industriale, si erano diffusi dapprima nell’Europa centro-settentrionale e solamente più tardi nell’Europa meridionale e in Italia9.
Il fatto che questione sociale e questione ambientale nascano insieme è, si badi bene, un aspetto solitamente trascurato dagli studi. E ci sarebbe da chiedersi perché. La spiegazione che è possibile dare riguarda il fatto che gli attori sociali, le forze sociali, che si fecero carico di questi due ordini di problemi furono per lungo tempo diversi: il movimento operaio e socialista concentrò le sue energie e le sue battaglie sulla questione sociale, mentre a occuparsi della questione ambientale, tra Otto e Novecento, fu per lo più un associazionismo di stampo borghese e liberaldemocratico. Tanto che, negli ambienti del Partito comunista italiano, ancora nel secondo dopoguerra, la sensibilità ecologica era spesso tacciata come un’attitudine borghese, qualcosa di superfluo e non decisivo.
In effetti, da un punto di vista culturale, il movimento di protezione della natura che si sviluppa tra fine Ottocento e inizio Novecento (la storiografia parla di «proto-ambientalismo») aveva essenzialmente due caratteristiche. Era un movimento patriottico – nella convinzione che la costruzione e il consolidamento di una nazione passasse anche attraverso la formazione di una comune consapevolezza delle sue bellezze naturali e della necessità della loro conservazione10 – e si legava alla valorizzazione degli aspetti turistici e sportivi: due realtà ancora oggi esistenti, il Touring club italiano e il Club alpino italiano, nascono proprio tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Ventesimo secolo, in questo alveo. Protezione delle bellezze naturali del proprio paese e la loro valorizzazione attraverso il turismo e lo sport rappresentano aspetti di grande rilievo, oggi ancora più di ieri, ma non costituivano in quel frangente storico una priorità per il nascente movimento operaio e socialista.
Il proto-ambientalismo italiano, come ha notato Gabriella Corona, si muoveva anche sotto lo stimolo di precedenti esempi europei e di relazioni internazionali sempre più fitte11. In Gran Bretagna, fin dal 1865, era stata istituita la Commons, Open Spaces and Footpaths Preservation Society; in Francia nel 1901 la Société pour la protection des paysages e in Germania nel 1904 l’Heimatschutzbund. Nel 1913 a Berna si tenne una conferenza mondiale sulla protezione della natura che si impegnò a promuovere una vasta attività di informazione per contrastare la distruzione delle specie vegetali e animali più colpite dai commerci internazionali. Proprio nel 1913 furono fondate in Italia la Lega per la protezione dei monumenti naturali e il Comitato nazionale per la difesa del paesaggio e dei monumenti, che concorrevano a dare voce alle diverse anime del movimento protezionista italiano12.
3. Ambiente e politica
Tra il proto-ambientalismo otto-novecentesco e l’ambientalismo politico del secondo Novecento c’è un periodo di passaggio che corrisponde alla ricostruzione e alla crescita economica post-bellica. Negli anni Cinquanta e Sessanta, la tradizione protezionista primo-novecentesca si rinnova e si rifonda. Nel 1961 nasce in Svizzera il World Wildlife Fund (WWF), il Fondo mondiale per la natura, a cui seguono negli anni successivi le varie sezioni nazionali. In Italia il rilancio dell’associazionismo naturalista e culturale è sorretto, oltre che dal consolidarsi di realtà ormai storiche come Tci e Cai, soprattutto dalla nascita, nel 1955, di “Italia nostra”, che nel contesto del miracolo economico contribuisce a segnalare in seno all’opinione pubblica «l’aggravarsi delle condizioni del patrimonio ambientale, il moltiplicarsi delle questioni su cui intervenire, le crescenti implicazioni politiche di quelle stesse questioni»13. L’emergere dell’ambientalismo politico si precisa tra anni Sessanta e Settanta, quando, sotto la pressione della mobilitazione studentesca l’ambientalismo assume una connotazione sociale e politica sempre più radicale.
“Ambientalismo politico”: che cosa si intende con questo termine? E cosa lo distingue dalle forme precedenti di conservazione e tutela? Il termine stesso ci suggerisce che il rapporto tra questione ambientale e dibattito politico si infittisce: ambiente e politica si intersecano sempre di più.
Un notevole contributo in questo senso venne dal movimento transnazionale del Sessantotto, che espresse l’esigenza di cercare un’alternativa radicale rispetto a quelle che venivano percepite come storture della modernità: era necessario mettere in discussione un paradigma di progresso incentrato sul dominio tecnologico e sulla corsa agli armamenti e invece impegnarsi nell’affermazione di una nuova coscienza ecologica per il futuro del pianeta14. Contestualmente, venne affermandosi nel dibattito pubblico l’idea che, in un’età di prosperità come quella che aveva fatto seguito alla ricostruzione post-bellica, i governi non dovessero garantire solamente il benessere materiale, ma anche migliorare la «qualità della vita», con questo intendendo la felicità personale, il rapporto con l’ambiente, la piena realizzazione culturale di sé. Esigenze post-materiali che salgono alla ribalta, appunto, con il Sessantotto e nel decennio successivo15. Fu in questo contesto che si affermò il superamento del tradizionale «conservazionismo» di derivazione ottocentesca e primo novecentesca, cioè la conservazione e la tutela delle bellezze naturali, in favore del «nuovo ambientalismo», l’ambientalismo politico del tardo Novecento, concentrato soprattutto sul fattore umano: gli uomini e le donne e le loro scelte all’interno dell’ecosistema16.
L’ecologia politica, dunque, metteva al centro l’importanza delle «azioni sociali» e la progettazione di una nuova organizzazione sociale tesa ad armonizzarsi con l’ambiente attraverso l’impiego controllato delle risorse e la limitazione dell’inquinamento17.
Negli anni Settanta la preoccupazione per l’ambiente comincia a diffondersi a livello nazionale e locale e questo avviene, sotto diversi punti di vista, in stretta connessione con dinamiche globali. Mentre si mobilitava la «prima generazione globale», quella del Sessantotto, per riprendere la definizione di Hannah Arendt18, proprio nel 1968 prendeva le mosse, in seno alle Nazioni Unite, il progetto di una conferenza sull’ambiente umano che si occupasse dell’impatto che crescita, urbanizzazione e industrializzazione stavano producendo: «si trattava di studiare le ripercussioni politiche, sociali ed economiche del degrado ambientale e di pensare a una strategia globale per affrontarle»19. Quel summit si sarebbe svolto a Stoccolma nel 1972 e, insieme alla pubblicazione, lo stesso anno, dello studio del Club of Rome sui limiti dello sviluppo20, alimentò il dibattito internazionale sulla problematica compatibilità tra ecologia e crescita.
Accanto a quello tra Est e Ovest, si affacciava, intanto, un nuovo confronto globale. Il riferimento è al difficile dialogo tra Nord e Sud del mondo sul rapporto fra ambiente e sviluppo, eredità del processo di decolonizzazione e frutto di diverse priorità socio-economiche: le esigenze di crescita del Terzo Mondo, i paesi africani e asiatici di recente indipendenza che cercavano di porsi sulla via dello sviluppo, e le preoccupazioni per inquinamento e sfruttamento incontrollato delle risorse tipiche dei paesi ricchi del Nord, in realtà responsabili principali, fino a quel momento, del degrado ambientale21.
4. Culture politiche a confronto all’interno della sinistra
In Italia e in Europa, l’ambientalismo politico non nasceva nell’alveo della sinistra tradizionale, quella dei partiti di massa e dei grandi sindacati, per i quali il bisogno di occupazione, di sviluppo industriale e di progresso economico per le masse lavoratrici fu a lungo la priorità rispetto alla sensibilità ambientale. Questo era ancora più vero in un contesto come quello italiano, dove il moderno sviluppo industriale arrivò tardi rispetto ad altri paesi europei. Nel nostro paese, è appena il caso di ricordarlo, il numero degli occupati nell’industria supera quelli del settore primario solamente negli anni del boom, tra anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, mentre in Germania questo sorpasso era avvenuto già alla fine dell’Ottocento e in Inghilterra ancora prima. Per un popolo che usciva prostrato dalla Seconda guerra mondiale, in un paese ancora prevalentemente agricolo, il passaggio all’età dei consumi di massa, della tumultuosa crescita industriale del “miracolo”, era sentito come il biglietto di ingresso nella modernità.
Del resto, storicamente, i processi di industrializzazione, urbanizzazione, produzione di massa, allargamento dei consumi avevano rappresentato, in tutta Europa, il contesto socio-economico nel quale movimento operaio, partiti socialisti e poi comunisti, sindacati si erano sviluppati tra la fine dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento. Si comprende bene come la questione ambientale – che implicava una problematizzazione se non una critica di questi processi di sviluppo e modernizzazione – non rappresentasse uno dei temi più frequentati dalla sinistra otto-novecentesca, soprattutto quella di ascendenza marxista, che riconosceva una forte centralità alla fabbrica e alla classe operaia.
Diverso il discorso per le correnti libertarie, sicuramente minoritarie, ma che ebbero un ruolo all’interno del movimento del Sessantotto e le cui posizioni – anticentraliste, antiburocratiche, assembleari, favorevoli alla partecipazione di tutti ai processi decisionali, critiche verso il meccanismo della delega e verso i partiti tradizionali – sono rintracciabili alle origini dell’ambientalismo politico negli anni Settanta e, più tardi, nei partiti verdi degli anni Ottanta22.
Nelle posizioni libertarie, rispetto a quelle della sinistra marxista, è da sempre presente una critica più accentuata verso il modello di sviluppo fondato sul dominio tecnologico dell’uomo sull’ambiente. Si potrebbe risalire alla metà del XIX secolo con Henry David Thoreau, principale ispiratore dei movimenti libertari e di disobbedienza civile negli Stati Uniti23, che nel 1854 pubblicò il racconto Walden, o la vita nei boschi24 in cui descriveva i due anni trascorsi in una capanna sulle sponde del lago Walden, nei pressi di Concord nel Massachusetts, alla ricerca di una personale riconciliazione con la natura e come atto di protesta verso una società da lui ritenuta dominata dall’utilitarismo, dalla ricerca del profitto e da una tecnologia industriale in rapida espansione. Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo Walden è stato considerato un testo fondativo della cultura ambientalista, non solo statunitense25.
Solamente negli anni Settanta, socialisti e comunisti cominciarono a misurarsi con la questione ambientale, sia perché incalzati dal variegato mondo dell’associazionismo verde e del fronte ambientalista, dove si cominciava a dare un taglio propriamente politico al problema ecologico26, sia perché la realtà dei territori cominciava a presentare, in maniera inderogabile, i conti da pagare allo sviluppo economico.
Abbiamo visto come l’ambientalismo politico richiamasse simultaneamente due aspetti: una dimensione individuale, relativa alla trasformazione degli stili di vita, e una dimensione più propriamente politico-istituzionale, relativa alla necessità di integrare ambiente ed economia nei processi decisionali. Ma, tradotto in altre parole, in termini più vicini alla cultura politica della sinistra socialista e comunista, che cosa significa integrare ambiente ed economia nei processi decisionali? Rispondere non è difficile: significa programmazione, cioè programmare l’intervento pubblico ai diversi livelli territoriali. Emerge, cioè, come fattore decisivo per affrontare la questione ambientale l’importanza della programmazione, meglio se decentrata e non burocratica (dunque vicina ai territori) e democratica, cioè attenta alla partecipazione e alla condivisione con le comunità locali. Il riferimento che si va precisando – e veniamo al caso di studio qui considerato – è a quel modello di governo locale che i comunisti emiliano-romagnoli misero a punto, alla guida degli enti locali e poi della regione, tra anni Sessanta e Settanta e che divenne la chiave di volta anche per affrontare i temi e i problemi ambientali27.
È su questo terreno, della «programmazione democratica», che si realizza il contributo originale del Pci in Emilia-Romagna, alla guida delle amministrazioni locali e soprattutto dell’ente Regione, interprete principale della programmazione. Il Pci emiliano-romagnolo degli anni Settanta non aveva ancora una cultura ambientalista consolidata, ma aveva uno strumento efficace per affrontare la questione ambientale, quello della programmazione territoriale e decentrata.
5. La nascita dell’ente Regione e gli anni Settanta. Il caso dell’Emilia-Romagna
Le regioni a statuto ordinario, istituite nel 1970, si trovano immediatamente a fronteggiare le conseguenze dei meccanismi di sviluppo innescatisi negli anni Cinquanta e Sessanta: squilibri relativi all’assetto del territorio, carenza di servizi, necessità di mettere ordine a trasformazioni sociali ed economiche che erano state tumultuose e disordinate28.
Il contesto economico dell’Emilia-Romagna, in particolare, era quello di una regione, storicamente rurale, che aveva vissuto un processo di industrializzazione, tardivo ma poi pervasivo e duraturo. Ancora nel 1961, in pieno boom, la forza-lavoro attiva nell’industria manifatturiera era in Emilia-Romagna il 27,6 per cento, a fronte del 44,4 della Lombardia. Il processo di allargamento dell’occupazione industriale in Emilia-Romagna continuò poi più alacremente che altrove fino a portare la regione nel 1981 pressappoco ai medesimi livelli della Lombardia29.
Negli anni Settanta, dunque, era in atto in Emilia-Romagna un formidabile processo di sviluppo, che portava con sé molteplici problemi ambientali. Vediamo velocemente i principali.
La forte urbanizzazione e la crescita dei consumi proponevano in termini decisamente nuovi per qualità e quantità il problema dei rifiuti urbani. Al quale si affiancava quello dei rifiuti industriali che, in molti casi, le imprese cercavano di aggirare non facendosi carico del loro smaltimento. Il caso più grave, in regione, fu quello dei fanghi ceramici, sversati nei fiumi o seppelliti nelle fondamenta degli stabilimenti. Eclatante fu poi il manifestarsi dei primi casi di inquinamento dell’aria da polveri. Polveri di piombo, ad esempio. Furono trovate tracce di piombo nel sangue dei bambini di alcune scuole del distretto di Sassuolo: uno dei primi casi di contrapposizione fra lavoro e ambiente che impegnò il sindacato e il Partito comunista del comprensorio Sassuolo-Scandiano. Lo sviluppo, oltre a inquinare, consumava territorio: la cementificazione, come sappiamo bene, aumenta l’impermeabilità dei suoli, mette in crisi assetti idraulici e territoriali. Cominciava ad aumentare la frequenza di eventi alluvionali e franosi, che minavano la sicurezza delle comunità. Per i territori di Ravenna e del litorale adriatico, infine, si evidenziò il fenomeno della subsidenza. La crescita esponenziale dei consumi di acqua dovuti all’elevarsi del tenore di vita delle popolazioni, all’affermarsi del turismo di massa, alla crescita industriale e a una agricoltura sempre più specializzata ed idro-esigente portavano a eccessivi emungimenti dalle falde acquifere a cui il fenomeno è attribuito30.
Sul versante della salute del mare, nell’agosto 1977 venne varata la motonave Dafne, battello oceanografico della regione per il monitoraggio del Mar Adriatico; la situazione dell’Adriatico sarebbe diventata una vera e propria emergenza nel decennio successivo.
La questione ambientale, insomma, si poneva in termini sempre più estesi e pregnanti a livello amministrativo e di governo del territorio. Una risposta politico-istituzionale arrivò nel 1977 con la nascita dell’Assessorato regionale all’Ambiente. Si noti che, a livello di governo centrale, non esisteva ancora un ministero dell’Ambiente, che verrà introdotto solamente nel 1986 (nel 1973 era nato il Ministero dei beni culturali e ambientali, che però non aveva competenze in materia ecologica ed era volto soprattutto alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e accanto a essi di quelli ambientali, ma senza occuparsi di politiche ambientali).
Questo Assessorato non era presente né nella prima Giunta regionale (1970-1976), presieduta da Guido Fanti, né nella seconda Giunta (1976-1977), guidata da Sergio Cavina. Solo nella terza Giunta, eletta il 7 giugno 1977, sempre guidata da Cavina, venne introdotto l’Assessorato all’Ambiente e Difesa del suolo. In precedenza, le competenze relative all’ambiente erano state di pertinenza dell’Assessorato alla Sanità, mentre la “difesa del suolo” era stata accorpata al turismo (Assessorato al Turismo e Difesa del suolo, che nel 1977 diventa Assessorato al Turismo e Commercio).
Contestualmente, nacquero gli assessorati provinciali all’Ecologia. Le Province – anche per il ruolo di ente intermedio nell’attuazione della programmazione regionale – divennero importanti presidi per lo sviluppo delle politiche per l’ambiente nei singoli territori. Nel corso degli anni Settanta, tra l’altro, l’Emilia-Romagna fu battistrada a livello nazionale per quanto riguarda la riflessione e la sperimentazione dei comprensori, un nuovo livello intermedio di governo del territorio che avrebbe dovuto sostituire le province. I comprensori erano più piccoli delle province, avevano dunque una maggiore omogeneità territoriale e socio-economica, che avrebbe consentito una programmazione più efficace. La breve stagione dei comprensori tramontò all’inizio degli anni Ottanta, quando, a livello nazionale, si scelse di proseguire – si potrebbe dire per inerzia – con le province che erano un’entità amministrativa storica presente fin dall’Unità d’Italia. Una personalità importante del Partito comunista emiliano-romagnolo, assessore regionale all’ambiente nel periodo 1987-1990, il modenese Giuseppe Gavioli continuò a riflettere anche successivamente sul valore dei comprensori considerandoli un’occasione mancata per migliorare la programmazione regionale31.
La prassi della programmazione portò il Pci emiliano-romagnolo, alla guida della regione e degli enti locali, a muoversi più tempestivamente che altrove. Ma anche all’interno del partito nazionale le posizioni stavano evolvendo, pur più lentamente e non in maniera uniforme. Nel 1970 con un articolo su “Rinascita” era Giovanni Berlinguer a cominciare a ragionare di ecologia e politica. L’anno successivo, in un convegno promosso dall’Istituto Gramsci di Roma e tenutosi presso la scuola di partito di Frattocchie, Uomo, natura, società. Ecologia e rapporti sociali, lo stesso Giovanni Berlinguer rilevava il ritardo del movimento operaio internazionale sui temi ambientali e sottolineava che l’ecologia doveva contribuire a plasmare una nuova dimensione della politica32. L’inquinamento e i danni ambientali cominciarono a essere letti come effetto delle modalità capitaliste di appropriazione delle risorse e di produzione di beni. L’altro aspetto fondamentale sottolineato dal Pci, fin dai primi anni Settanta, come emerge dai dibattiti parlamentari, risiedeva nella centralità che doveva rivestire il coinvolgimento del sistema delle autonomie (regioni, province, comuni) nella realizzazione delle politiche ambientali. Una dimensione, quella locale/regionale, dove del resto il Pci aveva un ben più ampio margine di manovra, come mostra il caso dell’Emilia-Romagna.
A livello di riflessione teorica e politica una rilevante novità è contenuta nella proposta dell’austerità avanzata dal segretario Enrico Berlinguer nel 1977. La proposta del segretario aveva molto a che fare con l’ambientalismo nella misura in cui promuoveva un modello di sviluppo che criticava l’aumento illimitato dei consumi e lo sperpero delle risorse; una proposta che si inseriva nel contesto della crisi economica degli anni Settanta, inaugurata nel 1973 dalla crisi petrolifera, e nell’orizzonte dei processi di decolonizzazione che ponevano, soprattutto in tema di disuguaglianze, nuove sfide nei rapporti tra Nord e Sud del mondo33.
Vale la pena ripercorrere con più attenzione quel frangente. In un convegno di intellettuali che si tenne al teatro Eliseo di Roma il 15 gennaio 1977 il segretario del Partito comunista Enrico Berlinguer legge il discorso Austerità occasione per trasformare l’Italia e annuncia la redazione di una «proposta di progetto a medio termine» (entrambi i testi pubblicati subito da Editori Riuniti, Roma). Al centro della proposta l’idea di superare la società dello spreco in direzione di un modello di sviluppo più razionale, socialmente equo e rispettoso dell’ambiente. La riflessione berlingueriana sull’austerità mirava a una riforma del consumismo che fosse possibile realizzare in sinergia con il mondo cattolico, collocandosi dunque nel solco del compromesso storico e nel contesto dei governi di solidarietà nazionale. Attaccata da destra e da sinistra, perché vista come una limitazione moralistica alla libera espressione dei bisogni soggettivi34, la proposta berlingueriana non attecchì nel dibattito pubblico, ma costituì un rarissimo tentativo da parte dei grandi partiti di massa italiani di farsi organicamente carico della problematica ambientale35.
6. Tra XX e XXI secolo: inizio di un percorso di ricerca36
Con gli anni Ottanta si aprì una fase decisiva nella storia dell’ambiente dal punto di vista sia della consapevolezza dell’opinione pubblica e della sua ricaduta sul piano politico, con la nascita e lo sviluppo dei partiti verdi in Italia e in Europa37, sia dal punto di vista istituzionale con il consolidamento della questione ambientale nell’orientare le scelte di governo della regione38.
Salì alla ribalta il tema del nucleare civile. Un movimento antinucleare si era sviluppato in Italia fin dalla seconda metà degli anni Settanta mobilitando settori della nuova sinistra e dell’associazionismo ambientalista, ma l’evento che segnò indubbiamente una cesura fu la catastrofe di Chernobyl dell’aprile 1986: l’esplosione di un reattore della centrale nucleare in Ucraina (allora all’interno dell’Unione sovietica) e la formazione di una nube radioattiva che toccò territori anche molto lontani, Italia compresa. L’allarme mobilitò l’opinione pubblica, portando al referendum del novembre 1987 e alla dismissione delle centrali nucleari italiane, tra le quali quella di Caorso nel piacentino.
Nel 1993 la Presidenza della Regione Emilia-Romagna venne assunta da Pier Luigi Bersani, la cui azione di governo regionale si caratterizzò per la scelta di istituire un inedito “Assessorato alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente”, affidato a Renato Cocchi. Una scelta che indicava, in termini simbolici – ma anche come proposito e impegno programmatico – l’obiettivo “strategico” di unificare le dimensioni economica, sociale, territoriale e ambientale dell’azione di governo39.
Quasi contemporaneamente, però, si assistette al declino della cultura della programmazione. La fine del Partito comunista nel 1991 prelude a un profondo cambiamento nella cultura politica della sinistra italiana. Si “ammorbidì”, per così dire, la critica al neoliberismo e alle dinamiche della globalizzazione. Tra anni Novanta e Duemila, i paradigmi del libero mercato cominciarono a limitare lo spazio dell’intervento pubblico e l’efficacia delle politiche ambientali.
Negli ultimi decenni, il passo indietro dello Stato e degli enti locali dalla regolamentazione economica e sociale ha inciso negativamente sulla capacità di governo del territorio, anche nei contesti locali e regionali governati dalla sinistra. Il consumo di suolo rappresenta oggi un problema acuto in Emilia-Romagna40. Di fronte a tale scenario, l’analisi storica suggerirebbe un cambio di rotta. Essa ha mostrato, infatti, come questione sociale e questione ambientale nascano insieme e siano, da sempre, strettamente intrecciate. Devono essere, dunque, affrontate insieme e per sperare di fronteggiarle efficacemente serve la cultura della programmazione e dell’intervento pubblico, che non significa necessariamente centralismo e burocrazia, ma come insegna l’esperienza dell’Emilia-Romagna, in alcune sue fasi, può tradursi in protagonismo delle autonomie: regione ed enti locali.
Note
1 “Corriere della Sera”, Bologna, 11 maggio 2024, dove si cita il comunicato stampa di lancio della manifestazione.
2 Nell’edizione on line: “Corriere.it”, 18 maggio 2024.
3 Ibid.
4 Cfr. Franco Cazzola, Ambiente, territorio, catastrofi, in “Il mestiere di storico”, 2010, n. 2, pp. 55-61.
5 Lo ricordavano Stefania Barca e Simone Neri Serneri nel forum curato da Stefano Cavazza, Storia politica e storia dell’ambiente in Italia, in “Ricerche di storia politica”, 2018, n. 1, pp. 63-73: pp. 65-66. Cfr., anche, Roberta Biasillo, Giacomo Bonan, Storia ambientale e storia d’Italia: specificità e percorsi comuni, in “Italia contemporanea”, 2021, n. 297, pp. 67-75, p. 70.
6 Lo ha notato opportunamente Chiara Zampieri, Ambiente e sostenibilità nelle culture politiche italiane degli anni Settanta, in “Mondo contemporaneo”, 2022, n. 2-3, pp. 215-239, p. 218. In precedenza, si veda anche Paolo Pelizzari, Sviluppo e ambiente nel dibattito della sinistra, in “Italia contemporanea”, 2007, n. 247, pp. 253-269, p. 253.
7 Stefano Cavazza, Politica e ambiente in prospettiva storica: considerazioni introduttive, in “Ricerche di storia politica”, 2018, n. 1, pp. 3-17, p. 4.
8 Preziosa la cronologia interdisciplinare sulla questione ambientale messa a punto da Luigi Piccioni, La cronologia di “Altronovecento” dell’ambiente e dell’ambientalismo, 1853-2000, con la collaborazione di Giorgio Nebbia e Pier Paolo Poggio, Brescia, Fondazione Luigi Micheletti, 2017 (“I quaderni di Altronovecento”, n. 7), p. 13.
9 Cfr. Cfr. Gabriella Corona, Breve storia dell’ambiente in Italia, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 50 e ss.
10 Si veda, soprattutto, Luigi Piccioni, Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia, 1880-1934, Camerino, Università degli Studi, 1999.
11 Corona, Breve storia dell’ambiente in Italia, cit., p. 57.
12 Cfr. ivi, pp. 57-58.
13 Simone Neri Serneri, Culture e politiche del movimento ambientalista, in Fiamma Lussana, Giacomo Marramao (a cura di), L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta. II. Culture, nuovi soggetti, identità, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 367-399, p. 369.
14 Si leggano, a questo proposito, le pagine di Agostino Giovagnoli, Storia e globalizzazione, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 57-63 (par. “Il 1968: la prima generazione globale”), dove si fa riferimento all’interpretazione sul Sessantotto di Hannah Arendt, Sulla violenza (1969), Parma, Guanda, 1996.
15 Sugli effetti silenziosi e sotterranei del Sessantotto nel determinare diverse priorità “esistenziali” e sulla loro ricaduta in ambito politico-partitico, si veda Piero Ignazi, Partito e democrazia. L’incerto percorso di legittimazione dei partiti, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 197-206. Cfr., anche, Michele Citoni, Catia Papa, Sinistra ed ecologia in Italia, 1968-1974, Brescia, Fondazione Luigi Micheletti, 2017 (“I quaderni di Altronovecento”, n. 8), p. 8 e ss.; Catia Papa, Alle origini dell’ecologia politica in Italia. Il diritto alla salute e all’ambiente nel movimento studentesco, in Lussana, Marramao (a cura di), L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta. II. Culture, nuovi soggetti, identità, cit., pp. 401-431, p. 402 e ss.
16 Cfr. Zampieri, Ambiente e sostenibilità nelle culture politiche italiane degli anni Settanta, cit., pp. 216-217.
17 Cfr. Federico Paolini, Breve storia dell’ambiente nel Novecento, Roma, Carocci, 2009, p. 88.
18 Come ha osservato Arendt (Sulla violenza, cit., p. 16), quella del Sessantotto è stata «la prima generazione cresciuta all’ombra dell’arma atomica», un’arma che sottoponeva il mondo intero a una minaccia di autodistruzione e che, in questo senso, globalizzava il destino dell’umanità. Un nuovo tipo di soggetto politico e sociale si mobilitò quell’anno contro un problema che investiva tutto il mondo – la logica miope di progresso imperniata sulla forza militare e su un dominio tecnologico sempre più schiacciante, che accomunava entrambi i blocchi della Guerra fredda – e cercò di pensare in modo nuovo il problema del futuro del pianeta. La percezione di una rottura dell’equilibrio tra l’uomo e il suo ambiente fece nascere allora, a livello transnazionale, una coscienza ecologica che si sarebbe radicata e rafforzata nel decennio successivo nei singoli paesi. In sede storiografica, si veda Giovagnoli, Storia e globalizzazione, cit., p. 58 e ss.
19 Sara Lorenzini, Ecologia a parole? L’Italia, l’ambientalismo globale e il rapporto ambiente-sviluppo intorno alla conferenza di Stoccolma, in “Contemporanea”, 2016, n. 6, pp. 395-418, p. 398.
20 Associazione scientifica internazionale nata e consolidatasi tra anni Sessanta e Settanta, https://www.clubofrome.org.
21 Cfr. Lorenzini, Ecologia a parole?, cit., pp. 395-397, 408-409, 414-415.
22 Cfr. Ignazi, Partito e democrazia. L’incerto percorso di legittimazione dei partiti, cit., pp. 206-211.
23 Si veda il bel profilo a lui dedicato da Mario Ricciardi in Enciclopedia del pensiero politico, diretta da Roberto Esposito e Carlo Galli, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 720. Negli ultimi decenni i suoi testi hanno ricevuto attenzione in Italia soprattutto grazie alle Edizioni dell’Asino promosse da Goffredo Fofi: si veda, ad esempio, Ribellarsi è giusto. Teoria e pratica della disobbedienza civile: un’antologia, Roma, Edizioni dell’Asino, 2008.
24 Henry David Thoreau, Walden; or, Life in the Woods (1854, Boston, Ticknor and Fields), tradotto per la prima volta in italiano nel 1920.
25 Cfr. Paolini, Breve storia dell’ambiente nel Novecento, cit., p. 36; Piccioni, La cronologia di “Altronovecento” dell’ambiente e dell’ambientalismo, cit., p. 13.
26 Simona Colarizi, nell’ambito di un confronto a più voci coordinato da Stefano Cavazza, ha teso ad accentuare questo aspetto politico scrivendo come, negli anni Settanta, siano «proprio i movimenti ambientalisti a imporre al mondo politico il tema dell’ecologia che fino a quel momento non era iscritto nell’agenda dei partiti». Cfr. Cavazza (a cura di), Storia politica e storia dell’ambiente in Italia, cit., p. 68.
27 Cfr. Carlo De Maria (a cura di), Storia del PCI in Emilia-Romagna: welfare, lavoro, cultura, autonomie (1945-1991), Bologna, Bologna University Press, 2022; Id., (a cura di), Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale, Bologna, Bradypus, 2014.
28 Id., La questione regionale tra anni Settanta e Ottanta dalla prospettiva dell’Emilia-Romagna. Lineamenti di un dibattito comparato, in Mirco Carrattieri, Carlo De Maria (a cura di), La crisi dei partiti in Emilia-Romagna negli anni ’70/’80, dossier monografico di “E-Review. Rivista degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna in rete”, 2013, n. 1, www.e-review.it.
29 Vera Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, a cura di Roberto Finzi, Torino, Einaudi, 1997, pp. 127-161, p. 131.
30 Giacimento bibliografico importante per indagare questi fenomeni è la Biblioteca dell’Ambiente, Regione Emilia-Romagna: https://www.assemblea.emr.it/biblioteca/approfondire/raccolte-specialistiche/biblioteca-dellambiente.
31 Carlo De Maria, Questione regionale e “modello emiliano” tra anni Settanta e Ottanta: fasi e interpretazioni, in Greta Benatti (a cura di), Giuseppe Gavioli e il riformismo emiliano, Bologna, Editrice Socialmente, 2018, pp. 59-66.
32 Cfr. Grazia Pagnotta, Il rapporto con la cultura ecologista e con gli ambientalisti, in Silvio Pons (a cura di), Il comunismo italiano nella storia del Novecento, Roma, Viella, 2021, pp. 539-554, p. 539 e ss.
33 Corona, Breve storia dell’ambiente in Italia, cit., p. 84.
34 Cfr. Citoni, Papa, Sinistra ed ecologia in Italia, cit., p. 37.
35 Piccioni, La cronologia di “Altronovecento” dell’ambiente e dell’ambientalismo, cit., p. 72.
36 Questo contributo si colloca nell’ambito del progetto di ricerca La sinistra e la questione ambientale tra passato e presente, promosso da Fondazione Duemila e Centro studi e ricerche Renato Zangheri di Bologna, nell’ambito del quale si è tenuto nel maggio 2024 un primo workshop: https://www.centrostudizangheri.it/2024/05/12/workshop-ll-pci-e-la-questione-ambientale-il-caso-dellemilia-romagna/.
37 Sulla storia della Federazione dei Verdi tra contesto nazionale ed europeo, si veda Giorgio Grimaldi, I Verdi italiani tra politica nazionale e proiezione europea, Bologna, Il Mulino, 2020.
38 A livello regionale, dove per gran parte del decennio fu assessore all’Ambiente Giuseppe Chicchi (1980-1987), due sono le questioni principali e più significative in materia ambientale: 1) la centrale nucleare di Caorso (Piacenza) e la questione del nucleare civile; 2) le fioriture algali in Adriatico e la questione della salute del mare.
39 Questa visione di unitarietà fra sviluppo e ambiente e la centralità della programmazione regionale per la tutela ambientale trovano espressione in un documento elaborato dalla Giunta nel 1997: La regione globale. L’Emilia-Romagna nell’Europa del Duemila, dove si ragiona sugli scenari e le opzioni strategiche al volgere del secolo, individuando la questione ambientale come sfida cruciale sia a livello di politica interna sia a livello di relazioni internazionali. Cfr. Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale, Scenari e opzioni strategiche per l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale: La regione globale. L’Emilia-Romagna nell’Europa del Duemila; documento presentato da Renato Cocchi, Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente. Cocchi fu assessore all’ambiente nel periodo 1993-1999.
40 Come conferma il rapporto nazionale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) su dati 2023: “Corriere della Sera”, Bologna, 4 dicembre 2024, 5 dicembre 2024.