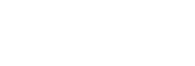In apertura: ritratto di Raffaele Bendandi (da https://www.osservatoriobendandi.it/).
L’undici di maggio del 2011 a Roma ci sarebbe stata una quantità anomala di assenze dai posti di lavoro. Il motivo? Si era diffusa nei giorni e nelle settimane precedenti la più classica delle leggende metropolitane, secondo la quale quel giorno fatidico si sarebbe verificato nella capitale un terribile terremoto1. In questa diceria, per darle più forza, si fece in particolare il nome di uno scienziato, il faentino Raffaele Bendandi, della cui vita ci vogliamo occupare qui. In un articolo del “Sole 24 ore”, pubblicato il giorno del mancato terremoto, Bendandi viene definito così: «bizzarro sismologo autodidatta in basco e cravattino»2.
Si tratta di una descrizione non molto generosa e che banalizza inevitabilmente l’immagine di Bendandi, la cui lunga esistenza, tutta consacrata alla scienza, merita di essere approfondita. Oggi esiste fra l’altro a Faenza una associazione culturale, “La Bendandiana”3 che si occupa di tenere viva la memoria del lavoro di Bendandi, custodendo il suo vasto archivio e gestendo la sua casa-museo4.
Ma chi era dunque Raffaele Bendandi? Si tratta senza dubbio di uno scienziato fuori dell’ordinario, che ha coltivato, contro tutto e contro tutti potremmo dire, isolato e povero, la propria passione, dedicandole ogni energia5. Uno «scienziato proletario»6, dallo stile “francescano”, attratto fin da giovane dai misteri dei fenomeni naturali più eclatanti e terribili, come, appunto, i terremoti.
Bendandi visse del tutto in disparte rispetto al mondo scientifico “ufficiale”, ma alla ricerca (ricerca folle, avrebbe potuto dire qualcuno nei secoli passati) di una spiegazione semplice e complessiva dei fenomeni dell’universo. Non che non si rendesse conto di tutte le grandi difficoltà legate a un tale progetto, anzi a una tale “vocazione”, ma la sua ambizione era più forte di ogni scrupolo: spiegare i misteri del cielo e della terra, capire in che modo le forze cosmiche possano influenzare la nostra vita, fino a sconvolgerla. Bendandi doveva essere un uomo non facile, molto orgoglioso del proprio lavoro, solitario eppure con un ineliminabile desiderio di ottenere finalmente riconoscimento.
Era nato nel 1893 a Faenza da una famiglia povera (il padre era un bracciante, la madre una tessitrice); studiò alle scuole elementari, poi iniziò subito a fare l’apprendista nella bottega di un orologiaio. Nel 1906 cominciò invece a frequentare la scuola comunale di disegno come avviamento a un lavoro artigianale. Bendandi divenne intarsiatore ed ebanista e per tutta la vita avrebbe costruito giocattoli, candelabri, cornici e altri oggetti. Nel 1908, in occasione del devastante terremoto di Messina, Bendandi incominciò a interessarsi ai fenomeni sismici e fin dall’anno successivo nella sua bottega comparve la scritta «Stazione sismologica Bendandi»7. Come era stata possibile una tale trasformazione? Studiando da solo matematica e trigonometria, imparando il francese, comprando, con grandi sacrifici, giornali, riviste e libri – sarebbe arrivato a mettere insieme una biblioteca di parecchie migliaia di volumi –, Bendandi riuscì ad allestire, nel sotterraneo di casa sua, un vero e proprio osservatorio geofisico. Usando come modello delle fotografie, e riprendendo le lezioni di padre Guido Alfani, direttore dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze, riuscì in qualche mese a costruire in economia un primo sismografo rudimentale. Nel corso degli anni, sempre per mantenersi, Bendandi mise in vendita altri sismografi e altri strumenti di rilevazione da lui prodotti (con la sigla “RABEN”), arrivando a venderli anche all’estero.
Bendandi rimase scapolo e si dedicò integralmente agli studi. Ma quale era la sua intuizione, l’idea che gli diede una certa (seppur controversa) celebrità? Studiando le forze attrattive fra i pianeti, giunse a costruire una vera e propria teoria sismogenica. Sempre basandosi su calcoli e mai su osservazioni dirette, Bendandi annunciò in più occasioni la scoperta di nuovi pianeti (scoperta mai verificata): nel 1928, ad esempio, comunicò l’esistenza di quattro pianeti ultranettuniani (che chiamò, in accordo coi tempi, Roma, Italia, Rex e Dux), mentre nel 1959 disse di averne trovato un altro (che chiamò stavolta Faenza), fra Mercurio e il Sole (anche quest’ultimo mai individuato da nessuno).
Nel 1931 Bendandi depositò presso l’Accademia Pontificia delle Scienze e presso l’Accademia dei Lincei una busta – aperta solo dopo la sua morte – in cui forniva la spiegazione dei cicli solari. Su questo argomento pubblicò – sempre a sue spese – il primo volume di Un principio fondamentale dell’universo8. In estrema sintesi, Bendandi sosteneva che anche il sole fosse soggetto a una attività ciclica (le cosiddette «crisi solari», con una periodicità di undici anni) che si sarebbe manifestata attraverso le macchie solari. Questa teoria e, più in generale, l’idea per la quale sarebbe possibile individuare un legame fra tutte le parti dell’universo, servì a Bendandi per cercare di spiegare l’origine dei terremoti. Anche qui semplificando molto, possiamo dire che, come la luna influenza le maree, allo stesso modo la forza attrattiva esercitata dai pianeti – e soprattutto durante i loro allineamenti – agirebbe sulla crosta terrestre, determinando appunto i terremoti. Così leggiamo in un suo manoscritto del 1935, Come giunsi alla scoperta:
Tutti i movimenti sismici – in qualunque parte del globo si manifestino – hanno un’origine comune.
La causa determinante di questi perturbamenti tellurici risiede unicamente in un turbamento delle condizioni di equilibrio del nostro pianeta prodotto dalle variabili attrazioni delle diverse masse planetarie componenti il sistema solare.
All’azione perturbativa dei vari membri del nostro sistema, non va disgiunta quella del nostro satellite, la quale, ora sommandosi e ora elidendosi, determina l’istante assoluto del fenomeno sismico. […] I terremoti tutti, al pari delle eruzioni vulcaniche – specie quelle esplosive –, per quanto si presentino del tutto irregolari, sono nondimeno fenomeni regolati da leggi esatte e precise, che rientrano… nel complesso problema delle perturbazioni, ben noto agli astronomi per le innumerevoli difficoltà che presenta9.
Bendandi cercava una spiegazione semplice, basandosi sulle informazioni a disposizione sui terremoti del passato. L’Osservatorio gli serviva per ottenere nuove conferme alla propria idea, idea che si radicò a tale punto in lui nel corso dei decenni tanto che lo stesso scienziato faentino finì per estenderla ad altri fenomeni, anche sociali e sanitari. Attraverso le «crisi solari» si poteva spiegare anche l’aumento dei casi di follia, di criminalità e persino le morti improvvise: «Su una pagina del “Corriere della Sera”, compaiono le sue precise annotazioni sui necrologi, per individuare i casi di morti improvvise (assai diffuse in quella data), da correlarsi, secondo il suo pensiero, alla sequenza dei fenomeni di influenzamento solare»10.
D’altra parte, Bendandi non voleva soltanto spiegare i terremoti, voleva arrivare a prevederli. Questa presunta capacità – anche se egli stesso riconosceva che difettava in precisione, riuscendo a prevedere il momento, ma non il luogo esatto delle scosse – gli portò già negli anni Venti una notevole celebrità e non pochi riconoscimenti. Nel 1920 egli fu ammesso nella Società sismologica italiana, ma il primo, vero momento di gloria ci fu indubbiamente nel 1924, quando, agli inizi dell’anno, un giornalista del “Corriere della Sera”, Otello Cavara, pubblicò sul giornale un suggestivo ritratto di Bendandi come di Colui che prevede i terremoti11. A sostegno della veridicità della sua teoria, influì non poco il fatto che il 20 dicembre 1923 Bendandi aveva depositato presso un notaio una doppia previsione, che si era (in parte) verificata: «La prima [manifestazione tellurica ci sarà], il 21 dicembre, cioè domani stesso, di origine americana (centro d’America); la seconda invece più importante come intensità il 2 gennaio con probabile epicentro nella Penisola Balcanica o tutt’al più nell’Egeo»12. Nel ritratto fatto da Cavara, Bendandi è raffigurato come un autodidatta isolato e la cui teoria ancora zoppicava un po’ e che egli non voleva ancora diffondere. Ciò nonostante, la fama di Bendandi crebbe e non soltanto in Italia. Nel 1926 arrivò a Faenza per conoscerlo persino il reggente e futuro imperatore del Giappone, Hirohito. Durante il periodo fascista, il nostro sismologo conobbe forse il suo vero periodo di gloria, pur non senza qualche inconveniente. Nel 1927 Mussolini lo fece nominare cavaliere ma, allo stesso tempo, il regime chiese a Bendandi il silenzio, per non creare inopinatamente il panico. Nel 1928, poi, il Ministero dell’Interno proibì alla stampa di occuparsi di lui. Bendandi si concentrò allora sui suoi contatti all’estero, riuscendo ad ottenere un incarico come collaboratore fisso da una agenzia di stampa americana, la United Press International.
Se Bendandi era apprezzato dai giornalisti e dai politici, lo era molto meno dai suoi “colleghi” scienziati. Proprio la sua popolarità, infatti, lo fece separare completamente dall’accademia. Egli scelse allora – come spesso avveniva in casi simili al suo – di contrapporsi alla scienza ufficiale, che d’altra parte lo liquidava con derisione, definendolo ad esempio come «Il Barbanera dei terremoti». Al di là di questo boicottaggio, la “carriera” di sismologo dilettante di Bendandi proseguì senza scossoni anche nel secondo dopoguerra. Arrivarono altri riconoscimenti (il presidente Gronchi gli conferì nel 1956 l’Ordine al merito della Repubblica), ma soprattutto fu la stampa (giornali, radio, televisione) a ricordarsi di lui a ogni nuovo terremoto. Così, in una recente ricerca pubblicata sulla rivista “Quaderni di geofisica”, dedicata ai fenomeni sismici in Italia nel secondo Novecento, troviamo spesso citato nei vari resoconti giornalistici il nome di Bendandi e del suo Osservatorio. E sempre Bendandi riproponeva la sua teoria sulla correlazione fra sismicità e «crisi solari», riaffermando anche l’esattezza delle proprie previsioni. Si potevano leggere frequentemente passi come questo: «Il sismologo faentino Raffaele Bendandi, subito interrogato dai giornalisti, ha diramato il seguente comunicato…»13. Fra l’altro, dalla metà degli anni Cinquanta, Bendandi ebbe un riconoscimento economico dall’amministrazione municipale di Faenza a sostegno dei suoi studi e, nel 1967, lo stesso Osservatorio fu ceduto al Comune, per tutelarne l’esistenza futura. Bendandi sarebbe vissuto ancora dodici anni, morendo nel 1979 e continuando fino all’ultimo a lavorare.
Pochi anni dopo la sua morte, nel 1983, sorse la già citata associazione “La Bendandiana”, che tuttora si occupa di valorizzare l’eredità di Bendandi e di divulgare le conoscenze scientifiche, specie in ambito geofisico. Studiando le carte lasciate da Bendandi, furono recuperate decine e decine di previsioni su ipotetici, futuri terremoti (ma non su quello mai avvenuto a Roma nel 2011, come fu sottolineato anche allora).
In conclusione, con Bendandi ci troviamo di fronte a una storia sicuramente avvincente e per certi versi misteriosa, forse più per la sua personalità che per le sue scoperte. Come sottolineò Cavara nel 1924, Bendandi mostrava, parlando del proprio lavoro, «un tono ispirato, quasi mistico, da credente. Anche nell’esteriorità fa pensare a un soggetto da vita claustrale: timido, misantropo, invaso però da ardore»14. Bendandi era spinto da una passione senza dubbio fuori del comune e se fosse vissuto qualche secolo prima, sarebbe stato probabilmente un magnifico alchimista, alla ricerca dei segreti della natura e del potere che verrebbe dal conoscerli.
Bendandi passò la vita nel suo sotterraneo-sacrario, da cui faceva uscire i bollettini con le proprie previsioni. Da allora, egli continua ad affascinare, tanto da essersi trasformato in una specie di Nostradamus romagnolo, che, fra l’altro, riuscì a datare anche la fine del mondo (che per fortuna sarà solo il 6 aprile 2521, quando avverrà un cataclisma come quello che fece scomparire Atlantide).
Note
1 Cfr. ad esempio Mauro Munafò, Roma, 11 maggio: la super bufala, in “L’Espresso”, 4 aprile 2011.
2 Chiara Beghelli, Il terremoto a Roma? Ovviamente una bufala. Eppure per l’Aduc il 20% dei romani è rimasto a casa, in “Il Sole 24 ore”, 11 maggio 2011.
3 Cfr. www.osservatoriobendandi.it.
4 Cfr. Paola Pescarelli Lagorio, Casa Museo Raffaele Bendandi di Faenza, Ravenna, Longo, 2014.
5 Cfr. Paola Pescarelli Lagorio, Alteo Dolcini, L’uomo dei terremoti. Raffaele Bendandi, Faenza, EDIT, 1992.
6 Cfr. Geminiello Alvi, Eccentrici, Milano, Adelphi, 2015, pp. 80-83.
7 Pierluigi Moressa, Fra maree e terremoti. La storia di Raffaele Bendandi, sismologo moderno, Forlì, Foschi Editore, 2012, p. 27.
8 Cfr. Raffaele Bendandi, Un principio fondamentale dell’universo. Volume 1: il sole, sua attività, genesi del ciclo undecennale, Faenza, Osservatorio Bendandi, 1931. Il secondo volume dell’opera sarebbe stato stampato solo nel 2006.
9 Moressa, Fra maree e terremoti, cit., pp. 74-75.
10 Ivi, p. 104.
11 Otello Cavara, Colui che prevede i terremoti, in “Corriere della Sera”, 4 gennaio 1924.
12 Bendandi prevede i terremoti, in “Il Nuovo Piccolo”, 6 gennaio 1924, n. 1.
13 Materiali per un catalogo dei terremoti italiani. Sismicità minore del Novecento: alcuni casi tra gli anni 1949-1971, in “Quaderni di geofisica”, 2022, n. 181, p. 144.
14 Cavara, Colui che prevede i terremoti, cit.