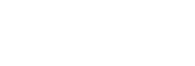In apertura: pubblicità del 1951 del trattore operaio R60 “La vacca di ferro” (https://www.officinemeccanichereggiane.it/2025/04/29/la-vaca-ad-fer-il-trattore-operaio-r60/).
Il 2 marzo 2020, giorno di apertura degli archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XII, segna una data importante negli studi storici sulla Chiesa; con la decisione di Papa Franceso è stata infatti resa disponibile una documentazione di eccezionale valore e grande ampiezza di tematiche1, una estrema varietà di documenti, talvolta tenuti insieme da un tenue filo2.
Non vi è dubbio che fin da subito l’attenzione, in particolare quella dei media, si sia appuntata sull’operato di Pacelli durante la guerra e sul suo atteggiamento di fronte alla Shoah, una questione storiografica – com’è noto – ormai antica3. Può risultare scontato ma sia concesso a chi scrive segnalare quanto siano invece molteplici le domande alle quali gli storici sono chiamati a rispondere circa questo, primo, Global Pontificate; fortunatamente la strada appare sempre più tracciata, con rilevanti risultati4 e alcune piste innovative e sorprendenti5.
In questa sede, senza pretesa di esaustività, si cercherà di offrire un ulteriore tassello indagando una serie di fascicoli che ben mettono in risalto l’interesse della Santa Sede e di Pio XII stesso nei confronti dell’occupazione delle Officine meccaniche italiane (Omi) di Reggio Emilia, le celebri “Reggiane”, un «affare triste», come si leggerà di seguito.
1. «Si resterà in fabbrica sin tanto che vi sarà un sol chiodo da costruire»
Al termine del secondo conflitto mondiale, la produzione meccanica in Italia è in sostanza ferma per mancanza di materie prime e combustibili e per la caotica situazione generale. Una volta riattivati i rifornimenti le aziende iniziano un lento e laborioso processo di riconversione che, in generale, grazie al riutilizzo dei macchinari già installati, non si rivelerà particolarmente difficoltoso. Il 19 maggio 1945 Antonio Alessio, direttore generale delle Omi scrive a Luigi Gasparotto, ministro dell’Aviazione del governo Bonomi, dopo un loro incontro a Roma. Il futuro delle Omi – il cui rilevantissimo contributo offerto, prima e durante la guerra, al potenziamento dell’aeronautica era stato innegabile – prospettato da Alessio è roseo, anche grazie alla «illuminata e vigile attenzione» di Gasparotto, che saprà «trovare il necessario equilibrio tra le esigenze di carattere amministrativo, e burocratico, e quelle a sfondo politico e sociale». Nonostante il suo ottimismo, il caos sta per abbattersi su quello che era stato il maggiore complesso industriale emiliano-romagnolo. Se per il settore meccanico italiano gli anni fra 1945 e 1951 saranno all’insegna della ripresa e del rilancio, per le Reggiane, al contrario, vedranno un continuo e inarrestabile declino, per un complesso concatenarsi di motivazioni6.
Il 1950 si aprirà con un pesante passivo di oltre 515 milioni di lire; ai primi di ottobre vengono spedite 2000 lettere di licenziamento che, in sostanza, dimezzerebbero il personale complessivo. Dopo manifestazioni di protesta e comizi nelle piazze cittadine, nella notte fra il 5 e il 6 la direzione decide la sospensione a «tempo indeterminato» dell’attività cessando, di conseguenza, ogni retribuzione. «Quello che si pensava già da tempo – scrive un giovane protagonista nel proprio diario di quei mesi di lotta – è avvenuto». «Si resterà in fabbrica», tuona la Camera del lavoro, «sin tanto che vi sarà un sol chiodo da costruire». Inizia quella che con i suoi 368 giorni sarà la più lunga occupazione della storia industriale d’Italia, conclusasi l’8 ottobre 1951. Solo «la fame» avrà la meglio sugli occupanti, ricorda uno di loro. «Col senno di poi», afferma un altro, «posso dire che fra noi ci sono stati degli eroi»7.
L’11 maggio 1951, sette mesi dopo la serrata, giunge in Segreteria di Stato vaticana (Sds) una lettera; è indirizzata al Santo Padre, a scriverla è Vera Maestri:
Da 7 mesi, da 7 lunghi mesi le Officine Reggiane hanno chiuso i battenti e la vertenza si prolungherà all’infinito se non sarà la mano divina che affratella gli uomini ad intervenire […] Quanti incontri, quanti comizi, quante parole, tutto sarà vano se non si chiede lavoro in nome di Gesù […] Non sono i disagi famigliari in cui vivo che mi spingono a Lei, è la figlia, l’umile figlia, la povera sposa di un operaio delle Reggiane che chiede preghiere […] Perché nelle famiglie non si imprechi più, perché nelle vie non si vedano più manifesti che rispecchiano un grande odio, una grande miseria. Lo so, se Dio permette questo ha i suoi grandi fini […] Sono 5.000 padri di famiglia che da 7 mesi attendono il pane per i figli, sono 5.000 famiglie che languiscono da mesi senza un aiuto […] A Voi rivolgo l’invocazione, gli Uomini Grandi sentiranno maggiormente la parola del Padre ed anche su questa massa di operai ridotti in 7 mesi in poveri mendicanti risollevi l’animo loro e ritorni il sorriso sui deschi vuoti delle famiglie, sorrida un po’ di luce ai bimbi, alle migliaia di bimbi che da mesi attendono invano dal padre il cibo che li nutra, la serenità della casa, l’armonia della famiglia8.
Fra le immaginiamo innumerevoli lettere che giungono quotidianamente in Città del Vaticano, questa sembra suscitare una particolare attenzione; il sostituto alla Sds, mons. Giovanni Battista Montini, la sottopone al pontefice il 19 maggio dopodiché vi annota a margine un imperativo: «Studiare!»9. Il 20 agosto il futuro Paolo VI scrive a Guido Rossi Leoni che per l’Istituto mobiliare italiano sta curando l’ormai inevitabile fallimento dell’azienda: «Caro Commendatore, so che Ella si occupa delle “Reggiane”. È affare triste. Nulla si può fare per una soddisfacente soluzione?». «Qui», continua, «sebbene del tutto estranei alla questione, se ne osserva il lato umano e spirituale, e si vorrebbe che la carità cristiana vi compiesse qualche prodigio di bontà e di novità»10. La risposta giunge in Vaticano il 26 agosto ed è alquanto sorprendente: «Giustamente», scrive Rossi Leoni, «lei dice che si tratta di un “triste affare”. È veramente triste sotto tutti gli aspetti e lo diventa ogni giorno di più»; «la causa prima di questo disastro deve imputarsi a coloro che, oltre ad avere male amministrato, hanno approfittato della loro posizione per auto attribuirsi degli stipendi che potrebbero benissimo chiamarsi dei furti qualificati. A voce le dirò meglio»11.
2. «Vicino a una polveriera»
Le carte d’archivio non ci permettono di sapere se effettivamente si tenne un incontro fra i due. Sappiamo però che il 5 ottobre, a tre giorni dal termine dell’occupazione, anche mons. Angelo Dell’Acqua scrive a Montini: sulla questione “Reggiane” «un interessamento della Santa Sede non potrebbe non avere buone ripercussioni negli ambienti “operai” non soltanto nella rossa Emilia ma di tutta Italia»12. Il giorno successivo a margine della missiva vi è un appunto a matita: «affrettarsi se si ritiene di fare qualcosa»13.
L’8 ottobre 1951, guidati da Giuseppe di Vittorio e con alla testa tre trattori R60, gli operai escono in corteo dallo stabilimento, decretando la fine dell’occupazione. In piazza della Vittoria, nel centro della città, dal balcone del Teatro comunale il leader della Cgil parla a una grande folla14. Una «parata politica», scrive polemicamente “L’Avvenire d’Italia” a Bologna, che «tenta di coprire una disastrosa battaglia sindacale»15.
Quello stesso 8 ottobre mons. Fernando Baldelli, presidente della Pontificia commissione di assistenza, compila un preoccupato resoconto per Dell’Acqua. A Reggio Emilia, scrive
il P.C.I. arriva dappertutto, sfrutta questa situazione con successo, […] Prefettura, Questura, Magistratura deboli, paurose a non dire altro, fanno figure inqualificabili. […] Dilaga una immoralità sfruttatrice e senza remora […] La massima disgrazia delle “Reggiane” è stata ed è il fatto che l’on. Walter Sacchetti, segretario della Camera del Lavoro, attraverso la Commissione interna comunista, si è sempre servito degli operai come massa di manovra in perpetua agitazione, illusa di irraggiungibili vittorie […] Non è possibile fare previsioni. “Tutto è tranquillo a Reggio” dirà il Prefetto a Scelba […] la tranquillità di Reggio è quella che c’è vicino a un moribondo, o vicino a una polveriera16.
«Le informazioni fornite da mons. Baldelli – scrive Dell’Acqua a Montini il 10 ottobre – sono senza dubbio gravi e preoccupanti»; «si sta vedendo se e come intervenire»17. Due giorni dopo Dell’Acqua ha un colloquio con Pio XII. Non conosciamo il contenuto del dialogo, l’esito invece si: Pacelli dispone uno stanziamento immediato di otto milioni di lire per le famiglie degli operai in difficoltà; «tale somma dovrà essere inviata senza alcun indugio» alle Acli e all’Azione cattolica di Reggio Emilia, incaricate di curarne la distribuzione18.
Il 20 ottobre Dell’Acqua scrive anche a Francesco Borgongini Duca, nunzio apostolico in Italia: «nel suo prossimo colloquio con l’on. De Gasperi, non potrebbe parlargli anche delle “Reggiane”?»19. L’incontro fra il nunzio e il presidente del Consiglio si tiene il 24 ottobre a Palazzo Chigi. Anche in questo caso non ne conosciamo il contenuto se non che Borgongini Duca ha esposto «l’urgenza» di intervenire «attraverso qualche ente di beneficenza», aggiungendo che «il S. Padre ha dato otto milioni, ma non bastano; e sua Santità non può fare altro»20.
Le carte conservate presso gli archivi vaticani riguardanti questi mesi finali della vita delle Omi ci restituiscono un’ultima missiva, inviata il 1° febbraio 1952 a Montini dal segretario provinciale della Democrazia cristiana di Reggio Emilia Corrado Corghi. Sono passati quattro mesi dalla fine dell’occupazione e Corghi segnala la «grave situazione delle Reggiane che stanno tanto a cuore al Santo Padre»; «purtroppo», continua, «non è ancora possibile la riapertura», «occorrerebbe entro la prossima settimana un decreto-legge specifico», «ho tentato unitamente all’on. Dossetti varie strade e tutt’oggi senza effetto. Per questo osiamo rivolgerci a Vostra eccellenza con viva speranza». La nota del futuro Paolo VI a bordo pagina recita: «Fare ciò che si può, dare se occorre»21.
3. Un terreno ancora da esplorare
A nemmeno un mese dalla lettera di Corghi sopraggiunge la catastrofe, la liquidazione coatta amministrativa e la nascita delle Nuove Reggiane il 28 febbraio 1952; vi troveranno occupazione solo 274 operai e 131 impiegati a fronte delle oltre 11000 unità del 1942. Walter Sacchetti, parlamentare del Pci ed ex segretario della locale Camera del lavoro, parla a quel punto di accordi «non mantenuti» e di dipendenti «costretti a ingiusti e assurdi declassamenti, costretti a inumano sfruttamento, privati della libertà sindacale». Non è l’unica impresa meccanica emiliana, cresciuta oltre misura grazie alla produzione bellica, a licenziare gran parte della forza-lavoro. Alla Ducati di Bologna, ad esempio, che era arrivata a 7000 addetti, nel 1954 ne resteranno solo 1300; anche qui, come in tutta la regione, il processo di ristrutturazione finisce per soddisfare esigenze propriamente politiche, di smantellamento cioè delle più combattive concentrazioni operaie. L’impianto della Magneti Marelli di Carpi, che aveva raggiunto i 1200 dipendenti nel 1944, ne mantenne dopo la guerra meno di 1/3; analoghe, con conseguenze cruente, le vicende delle Orsi di Modena22.
Scrivere su ciò che accadde nel secondo dopoguerra all’interno e “intorno” alle Reggiane – chiuse definitivamente nel 2010 dopo diverse traversie – è impresa complessa ancora oggi. Non hanno rappresentato, infatti, solo un’azienda, la tecnica, il luogo della promozione sociale, della speranza e della lotta politica. Sono state molto di più e di diverso, protagoniste del vissuto di una comunità che di ciò si sente ancora partecipe e, in qualche modo, erede. Attraverso quei cancelli sono entrati migliaia di giovani; con il lavoro hanno mutato la loro storia personale e quella collettiva, trasformando una provincia contadina flagellata dalla miseria in un ricco territorio di artigiani e piccole industrie. Che si studi «l’epica della classe operaia secondo i canoni del “realismo socialista”»23, che al cinema proiettino un film del maestro dell’animazione Miyazaki24 o che si sia semplicemente appassionati di fumetti25, le Reggiane hanno popolato, popolano e, possiamo supporre, popoleranno ancora a lungo un immaginario che travalica i confini dell’Emilia.
Note
1 Per una problematizzazione cfr. Daniele Menozzi, L’apertura degli archivi di Pio XII. Vecchie polemiche e nuove prospettive di ricerca, in “Riforma e movimenti religiosi”, giugno 2023, n. 13, pp. 135-152.
2 Giovanni Coco (a cura di), Le “carte” di Pio XII oltre il mito. Eugenio Pacelli nelle sue carte personali. Cenni storici e Inventario, Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, 2023, p. X.
3 Una recente panoramica, completa di bibliografia, è in Alessandro Santagata, Paolo Zanini, Pio XII e la Shoah. Nuovi studi a confronto, in “Italia contemporanea”, aprile 2024, n. 304, pp. 113-117.
4 Limitandoci ai risultati più recenti, si leggano ad esempio i saggi raccolti in Simon Unger-Alvi, Nina Valbousquet (eds.), The Global Pontificate of Pius XII. War and Genocide, Reconstruction and Change (1939-1958), New York-Oxford, Berghahn, 2024 e in Massimiliano Valente (ed.), A Vatican Atlantic Alliance. Pius XII and the Role of US Papal Diplomats in the Cold War, Roma, Viella, 2024. Di grande rilevanza scientifica è il progetto OCCIDENTES. Horizons and Projects of Civilization in the Church of Pius XII che vede coinvolte quattro università (Università Cattolica del Sacro Cuore, Pontificia Università Gregoriana, Universidad de Navarra e Universidade Católica Portuguesa).
5 Dario Edoardo Viganò (a cura di), Papi e media. Redazione e ricezione dei documenti di Pio XI e Pio XII su cinema, radio e tv, Bologna, Il Mulino, 2023. In questo settore si segnala il progetto di ricerca di interesse nazionale Italian Cinema in light of new sources from the Vatican Archives of the Pontificate of Pio XII (1939-1958) che vede coinvolte Università di Milano, Università telematica internazionale UniNettuno di Roma e Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
6 Andrea Montanari, Ricostruzione, restituzione. Il secondo dopoguerra alle Officine Meccaniche Italiane nelle nuove fonti d’archivio (1945-1951), in “Passato e Presente”, maggio-agosto 2025, n. 125, pp. 112-126: 113. A questo saggio mi permetto di rinviare per una bibliografia complessiva che qui si omette per motivi di spazio.
7 Ivi, pp. 124-125.
8 Lettera manoscritta di Vera Maestri a Pio XII, 11 maggio 1951, in Archivio apostolico varicano (d’ora in poi Aav), Segreteria di Stato (d’ora in poi Sds), anno 1950-sgg., titolo Enti commerciali e profani, posizione 300.
9 Appunto manoscritto di Giovanni Battista Montini, 19 maggio 1951, ivi.
10 Lettera dattiloscritta di Giovanni Battista Montini a Guido Rossi Leoni, 20 agosto 1951, ivi.
11 Lettera dattiloscritta di Guido Rossi Leoni a Giovanni Battista Montini, 26 agosto 1951, ivi.
12 Lettera dattiloscritta di Angelo Dell’Acqua a Giovanni Battista Montini, 5 ottobre 1951, ivi.
13 Appunto manoscritto, 6 ottobre 1951, ivi.
14 Tutta la cittadinanza festeggia i 5000 lavoratori delle Reggiane, in “l’Unità”, 9 ottobre 1951, p. 5.
15 Il caso “Reggiane”, in “L’Avvenire d’Italia”, 9 ottobre 1951, p. 1.
16 Lettera dattiloscritta di Fernando Baldelli ad Angelo Dell’Acqua, 8 ottobre 1951, in Archivio storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali (d’ora in poi Asrs), Affari ecclesiastici straordinari (d’ora in poi Aeess), Pio XII, parte II, serie Italia, posizione 1536.
17 Appunto manoscritto di Angelo Dell’Acqua per Giovanni Battista Montini, 10 ottobre 1951, ivi.
18 Appunto dattiloscritto di Angelo Dell’Acqua, 12 ottobre 1951, in Aav, Sds, anno 1950-sgg., tit. Enti profani e commerciali, posiz. 300.
19 Lettera dattiloscritta di Angelo Dell’Acqua a Francesco Borgongini Duca, 20 ottobre 1951, in Asrs, Aeess, Pio XII, parte II, serie Italia, posizione 1536.
20 Lettera dattiloscritta di Francesco Borgongini Duca ad Angelo Dell’Acqua, 26 ottobre 1951, in ivi.
21 Lettera dattiloscritta di Corrado Corghi a Giovanni Battista Montini, 1° febbraio 1952, in Aav, Sds, anno 1950-sgg., tit. Enti profani e commerciali, posiz. 300. Corghi ha definito quello per le “Reggiane” il suo «impegno più assillante»; cfr. Corrado Corghi, Guardare alto e lontano. La mia Democrazia cristiana, Reggio Emilia, Consulta, p. 212.
22 Montanari, Ricostruzione, restituzione, cit., p. 114. Un aspetto caratterizzante il periodo della ricostruzione e gli anni Cinquanta in Emilia-Romagna è, non a caso, la repressione che colpisce, tanto nelle fabbriche quanto nelle campagne, lavoratori e lavoratrici; su questo e per una bibliografia si legga Eloisa Betti, Lavoro e classe operaia nell’«Emilia rossa». Snodi, dibattiti, attori nella politica del Pci emiliano-romagnolo, in Carlo De Maria (a cura di), Storia del PCI in Emilia-Romagna. Welfare, lavoro, cultura, autonomie (1945-1991), Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 331-407.
23 Marco Fincardi, C’era una volta il mondo nuovo. La metafora sovietica nello sviluppo emiliano, Roma, Carocci, 2007, p. 192.
24 Il disegnatore e regista giapponese nel suo Si alza il vento del 2013 riserva un ruolo centrale alla figura del conte Caproni; cfr. “Gazzetta di Reggio”, https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2014/09/27/news/le-reggiane-protagoniste-nel-capolavoro-di-miyazaki-1.10008328 (ultima consultazione: 23 luglio 2025).
25 Una graphic novel intitolata Le Reggiane. L’avventura di una fabbrica italiana è stata presentata nel 2016 al Lucca Comics; cfr. “Officine Meccaniche Reggiane”, https://www.officinemeccanichereggiane.it/2016/11/03/le-reggiane-lavventura-di-una-fabbrica-italiana/ (ultima consultazione: 23 luglio 2025).