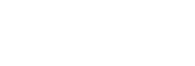In apertura: spazi dell’Altra Babele in piazza VIII Agosto, Settimana europea della mobilità, 22 settembre 2024 (Foto di Greta Magazzini).
La storia della ciclabilità riguarda molti temi cari alle più recenti linee di ricerca. Oggi si può anzi parlare di mobilità, in cui la bici gioca un ruolo integrato con le altre modalità di trasporto grazie ai suoi caratteri specifici. Fin dalla fine dell’Ottocento, lo sviluppo di massa della bici moderna ha influito sulla vita quotidiana, dallo sport al trasporto utilitario e perfino in guerra, sia negli eserciti regolari che nelle unità partigiane durante l’occupazione tedesca1. La crescita economica italiana ha favorito lo sviluppo della meccanica leggera e oggi la filiera della bicicletta rimane un settore significativo, tendente all’export, composto di piccole imprese e legato a doppio filo col cicloturismo2, che talvolta ha anche una funzione didattica e commemorativa3. In sintesi, la bicicletta è cifra della modernità e ha una sua storia specifica in Italia che replica anche gli ampi divari tra Nord e Sud4.
Tenendo a mente ciò, la ciclabilità si lega a più settori di ricerca storica. L’uso della bici ha un forte carattere locale e di iniziativa personale: sono gli enti locali a gestire le infrastrutture; cittadini e cittadine scelgono di muoversi in bici, fino a riunirsi in associazioni e a promuovere questa modalità di trasporto. Così la ciclabilità diventa un elemento della cultura politica, delle pratiche locali e della storia di interi movimenti; è parte del paesaggio urbano e periferico, e influenza il modo di vivere del territorio anche secondo le possibilità economiche, per residenti, lavoratori, turisti e chiunque altro vi abiti. La bici è quindi un oggetto con una sua storia tecnica ed economica, ma è anche un nodo di alcune forme di attivismo e di politiche comuni, un simbolo e un metro di paragone con realtà diverse. In questo senso la bici può essere oggetto di studi interessanti per comprendere un altro modo in cui le società abitano gli spazi e comunicano valori muovendosi sul territorio.
1. I tratti specifici di Bologna
Il caso bolognese non è il primo né il più esemplare, ma rimane significativo per mostrare i processi della ciclabilità in una città che cresce, col suo contesto specifico di attivismi e di progettualità diverse. Il contesto locale non può che interagire con una più ampia prospettiva, data l’aspirazione globale dell’ambientalismo e l’uso crescente di nuovi media. Infatti, il sostegno alla ciclabilità, le conseguenti opposizioni e l’implementazione di politiche pro-bici sono studiate in altri paesi, mentre gli stessi enti a favore della ciclabilità pubblicano ricerche proprie5. La mobilità sostenibile – di cui la ciclabilità fa parte – è oggi materia di amministrazione locale quanto delle istituzioni europee, che cercano di produrre un quadro comune per favorire i movimenti in bici oltre i confini urbani, con una prospettiva ambientale e socioeconomica6.
L’infrastruttura bolognese è abbastanza recente: Andrea Mazzetti ricorda che fino alla fine degli anni Ottanta c’era solo la ciclabile di via Zamboni, a cui seguirono le radiali est e ovest7. Non esistono ancora serie complete sulla rete ciclabile, la spesa dedicata e l’uso della bici, ma ci si augura che presto saranno pubblicate. A livello nazionale, i dati Istat 2013 mostrano un uso ridotto della bici per studenti (2,4%) e occupati (3,8%), concentrato al Nord e solo in lieve crescita rispetto agli anni precedenti8. Era anche assente l’attenzione specifica per la mobilità sostenibile, per la quale esiste un tag specifico solo per tre studi dal 2021. Un report sul 2017 segnala dati simili, 4,3% e 2,7%, su 30 milioni di spostamenti e precisa che la bici è preferita nei comuni con oltre 50.000 abitanti9, segnalando che l’urbanizzazione ne favorisce l’uso. I recenti report Ambiente urbano riportano la crescita delle ciclabili e del bike sharing, mentre l’Annuario statistico 2024 mostra una decrescita a livello nazionale (3,1% e 2,7%), evidenziando una stagnazione di lungo periodo nonostante il cambio di paradigma10. Il nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile prevede una quota bici di 14% entro il 2030, ma forse appare irrealistico con i fondi previsti (158 milioni)11. La mobilità sostenibile è un argomento politico importante, ma è necessario anche verificare la portata concreta di questo impegno, sia nella quantità di risorse che nella qualità progettuale.
Per dare una misura della rete attiva sulla ciclabilità, possiamo considerare una singola fonte a stampa. Nel 2011, il Comune di Bologna pubblicò un dépliant, BiciBO2, in cui si possono riscontrare alcuni elementi significativi della progettualità ciclabile12. In primo luogo, la sovrapposizione di più fonti di finanziamento, per cui la mobilità sostenibile giova di finanziamenti europei (progetto Civitas Mimosa) e di una concorrenza di Stato («4,36 milioni» dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), Regione («1,62 milioni») e Comune, per un totale dichiarato di 7,64 previsti negli anni successivi. All’interno dello stesso documento troviamo il punto della situazione su diverse attività: C’entro in bici, la flotta di 184 bici per il bike sharing a cui Bologna aderiva dal 2005 con altri comuni; nuove ciclabili e parcheggi; il servizio di marchiatura al prezzo calmierato di €5; la realizzazione della segnaletica ciclabile per i 14 itinerari della città, di cui 12 urbani; le attività delle associazioni. Si rintraccia quindi un forte legame tra comune ed enti come L’Altra Babele, Terzo Millennio, Amici di Piazza Grande e Fare mondi, per una collaborazione volta a promuovere la ciclabilità e a contrastare il mercato di bici rubate. Con la partecipazione del quartiere San Vitale, di Rfi e dell’università, l’iniziativa sCATENAti! si proponeva di recuperare le bici abbandonate e usate per rivenderle. Oltre alle riparazioni, è menzionata l’asta peculiare che dal 2005 al 2023 è stata promossa dall’Altra Babele per coinvolgere un pubblico ampio nel mercato della bici usata. In un piccolo dépliant troviamo quindi la sintesi della ciclabilità, che da modalità di turismo viene poi considerata anche mezzo di promozione sociale e di coinvolgimento della cittadinanza in un progetto di ampio respiro. La funzione pubblicitaria del dépliant non inficia questo dato, conferma comunque i tratti di una lunga cooperazione tra diverse entità sia locali che sovranazionali.
Nel contesto nazionale e regionale Bologna non risulta tra gli esempi più virtuosi – come Ferrara, Bolzano e Treviso13 – ma rimane significativa per i legami tra ricerca, politica e attivismo. Da un lato si può evidenziare la lunga collaborazione tra l’Università e il Comune, con il lavoro decennale del professore Federico Rupi e del gruppo Trasporti del DICAM14. Invece, in politica troviamo figure come Simona Larghetti, eletta alle regionali 2024, che fanno anche da ponte con l’associazionismo e integrano la ciclabilità nei programmi quanto nel linguaggio politico («C’è chi parla, io pedalo»)15. L’aumento di risorse e attenzione, purché graduale, può essere anche attribuito a questo specifico attivismo su più fronti.
2. La ciclabilità come ambito di conflitto politico
Sempre nello stile comunicativo troviamo un elemento parziale di martirio che muove sul piano europeo, come nel caso dell’omicidio dell’attivista parigino Paul Varry16, quanto su quello locale, come il cordoglio pubblico per l’incidente di Antonio Cavallaro17. La morte e la violenza non sono elementi nuovi della ciclabilità, si ritrovano anche nell’opposizione: la bici diventa bersaglio e simbolo di un conflitto per gli spazi urbani, in cui una parte evidenzia le proprie difficoltà contro la pericolosità del mezzo avversario. Un articolo di Noi donne criticava le difficoltà di usare la bici nel 1950, a cui si aggiungevano ostacoli dovuti al genere. Dalla parte dell’opposizione, l’autrice citava un vecchio articolo del “Corriere della Sera” che invitava a sparare sui ciclisti, mentre nel 1935 una breve colonna del quotidiano inveiva contro l’indisciplina dei pericolosi ciclisti18. Data la conflittualità del tema, non sorprende quindi il linguaggio usato da Vittorio Feltri contro i ciclisti e le reazioni anche legali delle associazioni19.
Il tema della bici risulta quindi interessante per la storiografia, per il modo di vivere il territorio e l’applicazione di politiche o forme di attivismo che vanno oltre l’uso sportivo. In questo caso, l’impegno di una parte della cittadinanza forse non ha pari rispetto ad altri trasporti. L’Automobile club d’Italia (Aci) e l’Associazione trasporti (Asstra, mezzi pubblici) ricoprono una funzione di tutela e divulgazione come le associazioni ciclistiche, tuttavia appaiono più istituzionali e verticali. Nel caso ciclistico esiste un attivismo diffuso, plurale e interconnesso, con dei chiari riferimenti transnazionali e translocali, che ottiene riconoscimento anche nei processi produttivi, come mostrato dal Protocollo d’intesa Rfi-Fiab del 2015. Inoltre, troviamo una costruzione di una memoria collettiva sui traguardi raggiunti e a cui aspirare, come nel libro La pista giusta curato da Andrea Mazzetti.
Per queste peculiarità si possono individuare più cause. Una può essere la prospettiva ampia dell’ambientalismo, ma forse è più significativa la percezione di essere ancora una categoria vulnerabile in Italia, che deve conquistare uno spazio stabile nel territorio e nei bilanci pubblici. Non è un tema che genera livelli alti di violenza, ma rimane un elemento di tensione tra modi diversi di vivere il territorio e nel rapporto tra centri e periferie. Vale quindi la pena indagare come questo fronte si lega ad altri movimenti, alle peculiarità locali e a uno spazio europeo sempre più integrato.
Note
1 John Norris, The Military History of the Bicycle: The Forgotten War Machine, Barnsley, Pen and Sword Military, 2021, pp. 10-24, 145; Eleonora Belloni, Quando si andava in velocipede. Storia della mobilità ciclistica in Italia (1870-1955), Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 82-83; I “ciclisti rossi” costituiti in Federazione politica. Un’adunata di mille ciclisti a Imola, in “Corriere della Sera”, 18 agosto 1913, p. 2.
2 Così riportava Confartigianato in uno studio promosso per il Giro d’Italia nel 2023: STUDI – Bicicletta: +10,1% produzione e +1,4% imprese. Il focus sulla filiera della bici – Confartigianato Imprese, https://www.confartigianato.it/2023/05/studi-bicicletta-101-produzione-e-14-imprese-il-focus-sulla-filiera-della-bici/ [data di consultazione di tutti i link 25 gennaio 2025]; GIORNATA MONDIALE BICICLETTA – Italia prima in Ue per export bici: 1,7 mln. In bike economy 61,5% imprese artigiane – Confartigianato Imprese, https://www.confartigianato.it/2024/06/giornata-mondiale-bicicletta-italia-prima-in-ue-per-export-bici-17-mln-in-filiera-il-615-delle-imprese-e-artigiana/. Tra 2001 e 2011, i censimenti Istat segnalavano 2109 e 2773 imprese nella fabbricazione di mezzi di trasporto diversi da autoveicoli e rimorchi, contro le 3233 censite da Confartigianato per l’intera filiera della bici: Istat, Annuario statistico italiano 2013, Roma, Istat, 2013, p. 673.
3 Francesco Monducci, La linea gotica nei lavori didattici degli Istituti della rete Insmli, in “Novecento.org”, 2016, n. 6. Per esempio, la “staffetta della memoria” ha attraversato la Linea gotica per cinque edizioni dal 2011: Staffetta della Memoria – Cammino Linea Gotica, https://www.camminolineagotica.it/staffetta-della-memoria/.
4 Eleonora Belloni, Bicicletta e storia d’Italia (1870-1945). La modernizzazione su due ruote, in “Novecento.org”, 2021, n. 16; Alberto Fiorillo, L’A Bi Ci. 2° Rapporto Legambici sull’economia della bici in Italia, Roma, Legambiente, 2018.
5 Colin Ferster, Karen Laberee, Trisalyn Nelson, Calvin Thipgen, Michael Simeone, Meghan Winters, From advocacy to acceptance: Social media discussions of protected bike lane installations, in “Urban studies”, 2021, vol. 58/5, pp. 941-958; Elizabeth D. Wilhoit, Lorrain G. Kisselburgh, Collective action without organization: the material constitution of bike commuters as collective, in “Organization studies”, 2015, vol. 36/5, pp. 573-592. In diversi stati, enti autonomi monitorano la ciclabilità delle città, ma anche tra paesi europei: FUB, Baromètre des villes cyclables 2021 – Palmarès et résultats, Francia, FUB, 2022; La rete ciclabile nazionale Bicitalia, https://www.bicitalia.org/it/bicitalia/la-rete-ciclabile-nazionale-bicitalia; EuroVelo, https://en.eurovelo.com/.
6 Dichiarazione Europea sulla mobilità ciclistica, 3 aprile 2024; Libro Verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, 25 settembre 2007; Laura Casonato, Verso un nuovo paradigma della mobilità ciclistica nell’UE?, Trento, European Region Tyrol – South Tyrol – Trentino, 2019, https://www.europaregion.info/fileadmin/downloads/Bruessel/Jugend/Trento/Verso_un_nuovo_paradigma_della_mobilitA_ciclistica_nellaEUR_TM_UE_Laura_Casonato.pdf.
7 Andrea Mazzetti (a cura di), La pista giusta. Cronache e testimonianze della ciclabilità bolognese, Siena, Edizioni Luì, 2023, pp. 91.
8 Istat, Annuario statistico italiano 2013, cit., pp. 500-501.
9 Istat, Spostamenti quotidiani e nuove forme di mobilità, in “Statistiche report”, 29 novembre 2018.
10 Istat, Annuario statistico italiano 2024, Roma, Istat, 2024, p. 758.
11 PUMS, https://pumsbologna.it/Home.
12 BiciBo2. Bologna, voglia di bici. Le piste ciclabili di ieri, di oggi, di domani. Edizione 2010-2011, Bologna, Comune di Bologna, 2010.
13 Osservatorio 50 città, https://www.osservatorio50città.it/.
14 Ali Enes Dingil, Federico Rupi, Joerg Schweizer, The role of culture in urban travel patterns. Quantitative analyses of urban areas base on hofstede’s culture dimensions, in “Social sciences”, 2019, n. 8, pp. 1-12; Federico Rupi, Mariza Freo, Maria Nadia Postorino, Joerg Schweizer, Analysis of gender-specific bicycle route choices using revealed preference surveys based on GPS traces, in “Transport policy”, 2023, vol. 133, pp. 1-14.
15 Simona Larghetti, https://simonalarghetti.it/.
16 Anne Hidalgo, Uccide un ciclista con un SUV: la risposta di Parigi è esemplare, in “BIKEITALIA”, 17 ottobre 2024.
17 Luca Muleo, Incidente a Bologna, ciclista di 64 anni muore investito da un camion dei rifiuti di Hera, in “Corriere di Bologna”, 28 novembre 2024.
18 La circolazione urbana e i ciclisti indisciplinati, in “Corriere della Sera”, 26 settembre 1935, p. 4. Margherita Ricci, “Scandalo! Le donne vanno in bicicletta…”, in “Noi Donne”, 1950, n. 43, p. 7: l’articolo citato non si ritrova nell’archivio digitale del Corriere.
19 Simone Cesati, «I ciclisti mi piacciono solo se investiti». Feltri, polemiche e querele, in “Avvenire”, 26 settembre 2024.