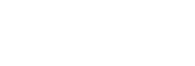In apertura: testimoni partecipanti al progetto “Le vittime italiane del nazionalsocialismo” dell’Università di Padova. ©Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Un progetto per le scuole e la cittadinanza (https://memoriavittimenazismofascismo.it/).
1. Introduzione
Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della conclusione della Seconda guerra mondiale, evento spartiacque nella storia del Novecento, dalle cui macerie nacque poco più tardi la Repubblica italiana. La fine del conflitto in Italia ha significato non solo il termine della lotta contro l’occupante tedesco, ma anche della guerra civile1 che ha spaccato il Paese tra il 1943 e il 1945, vedendo schierati da un lato i fascisti repubblichini, dall’altro la Resistenza.
Questa frattura all’interno della società italiana ha avuto – con effetti ravvisabili ancora oggi – importanti conseguenze sulla formazione di memorie individuali e collettive diversificate rispetto al periodo fascista e bellico, una vera memoria frantumata cui hanno concorso vinti e vincitori, la società civile, i partigiani e i repubblichini, i combattenti reduci, le vittime delle stragi e delle deportazioni nazifasciste2. Le diverse narrazioni e memorie sul conflitto hanno fortemente influenzato il discorso pubblico e privato in Italia, in cui l’elemento dominante che a lungo è emerso è stato la figura del “cattivo tedesco” opposta a quella del “bravo italiano”3, anche a causa della mancanza di procedimenti penali contro i criminali di guerra italiani4, il cui ruolo di aggressori viene sottolineato con più attenzione solo a partire dagli anni Novanta.
L’interesse e l’importanza attribuita all’esperienza del secondo conflitto mondiale, con l’immediato riconoscimento del valore della memoria di chi ha vissuto direttamente quegli eventi, ha portato sin dalla fine degli anni Quaranta alla raccolta di testimonianze scritte, principalmente di partigiani, poi in larga parte confluite in pubblicazioni celebrative del movimento resistenziale. Più avanti, invece, molte di queste testimonianze, col tempo allargate anche ad altre tipologie di testimoni, sono state raccolte da ricercatori e ricercatrici, quindi registrate, prima in forma audio e successivamente audiovisiva, dando vita a importanti collezioni/archivi orali, nei quali la memoria privata e individuale si intreccia con quella pubblica e collettiva.
In questo articolo si intende approfondire la creazione di due archivi orali sulla Seconda guerra mondiale, illustrandone le modalità con le quali sono venuti a formarsi, i tipi di materiali raccolti, le tipologie di testimoni presenti, le modalità di lavoro adottate per la loro fruizione da parte del pubblico e i principali temi che da essi emergono. Non secondariamente, lo scritto vuole far conoscere ad un pubblico più ampio l’esistenza di preziose fonti orali accessibili online.
2. Il progetto “Le vittime italiane del nazionalsocialismo”
Tra il 2019 e il 2020 il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, all’interno del progetto “Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Conoscere, ricordare, diffondere” – su finanziamento della Repubblica federale tedesca, attraverso il Fondo italo-tedesco per il futuro, stanziato per la realizzazione di una politica di riconciliazione e per lo sviluppo di una comune cultura del ricordo fra Italia e Germania – ha promosso un’ampia campagna di interviste che ha interessato oltre cento italiani e italiane superstiti della violenza nazifascista perpetrata nel periodo dell’occupazione del Paese (1943-1945). Il gruppo di lavoro, formato da sette ricercatori5 con il coordinamento scientifico del prof. Filippo Focardi, ha interpretato in modo estensivo la parola vittima, intendendo per essa chiunque abbia subito la violenza nazifascista nell’arco cronologico considerato, dai perseguitati (razziali o politici) ai deportati (per razza, orientamento politico o per servire l’industria bellica nazista), dagli Internati militari italiani (Imi) ai superstiti di stragi, finanche i lavoratori coatti in Italia e alcuni partigiani arrestati o deportati. Fanno eccezione una categoria di testimone, le “seconde generazioni”, talvolta prese in esame perché particolarmente influenzate dall’esperienza vissuta dal proprio familiare, il che ci consente inoltre di riflettere sulle dinamiche di trasmissione della memoria. In sintesi, attraverso il supporto di numerose associazioni, sono state raccolte le interviste dalle seguenti tipologie di vittime: ebrei perseguitati e deportati, deportati politici, lavoratori coatti in Italia e nel Reich, superstiti civili di stragi, prigionieri militari, internati civili e militari, partigiani e seconde generazioni.
Le interviste sono state realizzate a partire da una griglia di domande comuni a tutti gli intervistati, ma che allo stesso tempo lasciasse ampio spazio al racconto del testimone, con l’obiettivo di far emergere la sua soggettività e la specificità dell’esperienza vissuta. Queste riguardano le proprie origini familiari e la vita durante il ventennio fascista, lo scoppio della guerra e l’impegno bellico italiano, la caduta del fascismo (25 luglio 1943) e l’armistizio (8 settembre 1943), l’occupazione tedesca del suolo italiano (1943-1945) e le violenze subite (arresti, deportazioni, sfollamenti, rastrellamenti, catture, lavoro coatto), la Liberazione, il dopoguerra, possibili risarcimenti o riconoscimenti dello Stato italiano per quanto loro accaduto, riflessioni sulla memoria degli eventi e sul proprio ruolo di testimone, i rapporti con i tedeschi oggigiorno e con il fascismo. Nel caso di testimoni perseguitati per le proprie origini, è stato inoltre chiesto loro cosa ha significato l’emanazione delle leggi razziali (1938), eventuali fughe per sfuggire alle persecuzioni, notizie su arresti e deportazioni di familiari; relativamente agli Imi, la scelta di non aderire alla Repubblica di Salò e la deportazione; per quanto invece riguarda i superstiti di stragi, gli eventi concernenti gli eccidi; ai lavoratori coatti, la loro cattura e l’impiego.
Le memorie raccolte in formato audiovisivo sono state oggetto di un’attività di post-produzione che favorisse la fruizione di questi documenti, con brevi tagli laddove ritenuti opportuni da parte del comitato scientifico, quindi di pubblicazione all’interno del sito web del progetto6. Il convegno internazionale svolto online nei giorni 18-19 novembre 2020 ha visto una prima e importante valorizzazione scientifica delle memorie raccolte7, con l’analisi delle forme delle testimonianze e del ruolo dei testimoni, nonché della memoria (individuale, familiare, locale, privata e pubblica).
3. Le memorie delle vittime tra l’archivio orale e la public history
Come accennato in precedenza, le interviste raccolte sono state pubblicate all’interno del sito web del progetto con la possibilità di essere fruite previa registrazione al portale da parte dell’utente. Tuttavia non tutti i contenuti di quel portale erano riservati. Esso infatti ospitava altre tre sezioni rilevanti: una, denominata “Contesto storico”, dedicata ad un inquadramento generale sui temi oggetto delle interviste, utile all’utente – studioso o semplice appassionato – per muoversi tra i diversi documenti; un’altra, invece, ad un’ampia bibliografia di riferimento per eventuali approfondimenti; la terza ospitava una sitografia perlopiù atta a presentare altri portali realizzati per progetti relativi alla Seconda guerra mondiale o appartenenti alle associazione combattentistiche e reducistiche.
Quando nel 2024 il predetto Fondo italo-tedesco ha concesso un secondo finanziamento, è stata avviata una nuova progettualità dal titolo “Italian Victims of National Socialism. A project for Schools and Citizenship”, il cui principale obiettivo è stata la disseminazione dei contenuti raccolti nella prima fase del progetto attraverso la realizzazione di tre documentari (l’uno dedicato alla persecuzione antisemitica, uno agli Imi e l’altro ai superstiti di stragi) destinati soprattutto all’uso didattico.
Parallelamente ha preso piede un’operazione di restyling del sito web che ha interessato non solo la parte grafica, ma anche i suoi contenuti, con la precisa idea di offrire un prodotto idoneo ad attività di public history8. In questo senso, oltre ad una revisione formale dei testi presenti e a un opportuno aggiornamento delle bibliografie rispetto alle più recenti pubblicazioni sui diversi temi, si è ritenuto necessaria l’implementazione di contenuti iconografici con l’inserimento di gallery formate da immagini acquisite digitalmente dagli archivi del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto-Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra, dell’Istituto storico Parri di Bologna e del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Casrec) dell’Università di Padova. Tra i documenti sono presenti fotografie, manifesti, volantini e altro ancora. Una sezione specifica, invece, è riservata ai tre documentari, oggi disponibili in open access9 e corredati da infografiche.
L’attività più rilevante, nell’ambito della messa in rete di nuovi contenuti e della fruizione delle interviste lì contenute, è rappresentata dal lavoro di schedatura dell’intero archivio orale, consistente in 105 documenti audiovisivi10. Per ciascuno di essi è stata redatta una scheda analitica – preliminarmente condivisa con il team di lavoro e realizzata a seguito di un confronto con altre predisposte per progetti legati ad archivi orali – strutturata nelle seguenti aree:
- Identificazione: fornisce le informazioni fondamentali relative alla realizzazione dell’intervista e al testimone. Sono inclusi il titolo del progetto, il titolo dell’intervista, la data e il luogo dell’evento comunicativo, la durata, la lingua utilizzata, il nome e la tipologia dell’intervistato, nonché il nome dell’intervistatore. Se presenti, vengono indicati anche i nominativi di terze persone.
- Descrizione: sono raccolte informazioni pertinenti all’ambito e ai contenuti trattati nell’intervista. È presente una sintesi dell’evento comunicativo, con eventuali osservazioni o annotazioni dell’intervistatore, e un indice tematico sui principali argomenti affrontati nel corso dell’evento comunicativo. È inoltre indicato il periodo, ovvero gli estremi temporali del racconto. Completano la sezione un indice dei luoghi menzionati e i tag che evidenziano i temi centrali dell’intervista.
- Credits e Copyright: esplicita i diritti d’autore e le eventuali attribuzioni relative all’intervista.
- Collegamenti e riferimenti esterni: si forniscono link a interviste, precedenti o successive, realizzate dallo stesso testimone, nonché una bibliografia di riferimento specifica sull’intervistato, che può includere, ad esempio, opere autobiografiche. Sono altresì indicate le interviste correlate presenti nell’archivio del progetto ed eventuali allegati.
- Liberatoria e Privacy.
- Informazioni tecniche: contiene dettagli sul formato e sulla dimensione del file audiovisivo (mp4, mov), sugli strumenti utilizzati per la registrazione, nonché sul supporto originale del documento.
Ogni intervista, visibile attraverso una procedura di registrazione e di login all’archivio, presenta un’anteprima pubblica, formata da un frame dell’intervista, una breve biografia del testimone, l’indicazione della tipologia di intervistato, titolo del progetto di ricerca, titolo dell’intervista e durata dell’evento comunicativo.
Dal punto di vista dell’utente e della fruizione dell’intervista, l’abstract e l’indice dei temi rappresentano senza dubbio le chiavi di accesso più immediate ai contenuti del documento. La sintesi dell’intervista, in particolare, richiama le origini del testimone e i fatti più rilevanti per la comprensione del suo racconto, ad esempio: eventuali spostamenti, il lavoro svolto, l’esperienza personale o familiare relativa alla violenza subita, informazioni sulla sua vita nel dopoguerra e alla sua attività come testimone. L’indice tematico, invece, consente attraverso la segnalazione di specifici timecode di accedere al punto esatto dell’intervista in cui quell’argomento è trattato dal testimone. Nel caso di temi ampiamente approfonditi dal testimone, si è deciso di suddividere quegli argomenti in ulteriori sotto temi per facilitare la consultazione del documento.
Oggi il portale del progetto “Italian Victims of National Socialism. A project for Schools and Citizenship” offre un’ampia selezione di materiali, fruibili a diversi livelli sulla base delle proprie competenze e interessi, destinati a un pubblico diversificato, dal semplice appassionato allo studioso, in cui l’archivio orale dialoga con gli altri strumenti messi a disposizione dell’utente, quali i documentari, gli apparati iconografico e infografico, i testi di inquadramento storico e le bibliografie specifiche.
4. Dalle carte al web. L’archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto
In occasione della manifestazione “Quante storia nella storia” 2024 (6-12 maggio)11, il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto12 (d’ora in poi, Comitato onoranze) ha lanciato sul proprio sito web un nuovo progetto, nel quale si intrecciano la dimensione più propriamente archivistica e quella relativa alla valorizzazione e disseminazione del patrimonio. Si tratta di un portale digitale ricco di contenuti iconografici e audiovisivi che presenta al pubblico la ricchezza del patrimonio documentario conservato all’interno del proprio archivio, recentemente oggetto di un intervento di riordino, concluso nel febbraio 2023, atto a rendere disponibile alla cittadinanza e a studiose e studiosi le carte ivi conservate. Gli interventi effettuati si collocano all’interno di un progetto culturale di consolidamento e valorizzazione del patrimonio documentale ed extra-documentale (fotografico, iconografico, audio-video, librario) varato dal direttivo del Comitato, che ha visto la sistemazione del materiale archivistico e la sua messa in sicurezza, la realizzazione di inventari informatizzati, la digitalizzazione di documenti audiovisivi, fotografie e manifesti, quindi la catalogazione del patrimonio librario13.
L’archivio del Comitato accoglie diversi complessi archivistici14. La mole documentaria più ampia è rappresentata dalle carte appartenenti all’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto-Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra15, il quale contiene le carte prodotte dal Comitato nell’esercizio delle sue attività e le raccolte del Centro di documentazione. Questo nasce nella seconda metà degli anni Ottanta per volontà di Luigi Arbizzani16, al quale deve ancora oggi la sua struttura, per raccogliere in un unico punto la documentazione concernente la strage di Monte Sole e il suo ricordo, ma anche per promuovere l’attività di ricerca storico-scientifica del Comitato. Sono inoltre conservati l’Archivio Dante Cruicchi17, amministratore pubblico e presidente del Comitato onoranze dal 1982 sino alla sua scomparsa avvenuta nel 2011, e l’Archivio avvocati Giuseppe Giampaolo-Andrea Speranzoni18, avvocati di parte civile nei procedimenti penali contro i responsabili della strage di Monte Sole.
Proprio dai fondi del Comitato Onoranze-Centro di documentazione e Dante Crucchi sono tratti oltre un migliaio di documenti – tra fotografie, manifesti e audiovisivi – pubblicamente accessibili sul sito web dell’archivio digitale19 allestito dal Comitato onoranze, suddivisi per tipologia documentaria e organizzati mantenendo uno stretto legame con l’archivio analogico.
5. Voci della strage di Monte Sole-Marzabotto
Nella primavera 2025 è giunto a compimento il lavoro di organizzazione e messa a sistema del fondo di fonti orali conservato presso il Centro di documentazione di Marzabotto, ovvero della sezione “Testimonianze” del più ampio archivio audiovisivo. Si tratta di un complesso documentario, prodotto in parte dal Consorzio di gestione Parco storico di Monte Sole e in parte da singoli privati, che raccoglie diverse decine di testimonianze rese da superstiti della strage di Monte Sole e loro familiari, ma anche di partigiani della Brigata Stella Rossa, allora attivi in quell’area20.
Le interviste raccolte in questo fondo sono state realizzate tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Duemila, coprendo un arco cronologico di oltre trent’anni, all’interno del quale la memoria della strage di Marzabotto-Monte Sole si stratifica e consolida. In particolare, si tratta di sei collezioni21, ognuna delle quali individuata da uno specifico progetto, perlopiù legate ad attività di ricerca o documentaristiche22.
Dall’ascolto delle oltre cento ore di registrazioni emergono tratti comuni e trasversali alle diverse interviste conservate.
In primo luogo, appare evidente all’ascoltatore la differenza tra il punto di vista e il ricordo dei superstiti di stragi e dei partigiani rispetto agli anni 1943-1945 e alla lotta di Liberazione. Le testimonianze dei civili, in particolare nelle collezioni “Sono viva… credo” e “I testimoni di Monte Sole”, sono caratterizzate dalla drammaticità delle violenze subite, in un passato che persiste nel presente, dalla rottura della quotidianità sociale e familiare degli anni immediatamente precedenti all’occupazione tedesca a favore di uno stato di pericolo costante, determinato ora dai bombardamenti aerei alleati, ora dai rastrellamenti nazifascisti. Il racconto dei superstiti è ricco di dettagli, spesso legati alla materialità della vita quotidiana, dal vestiario al cibo, passando per i rapporti familiari, ma anche alla presenza dell’occupante tedesco, descritto nella sua fisicità e nelle sue componenti comportamentali e attitudinali. Un discorso opposto, invece, interessa le interviste svolte agli ex partigiani, qualunque fosse il grado ricoperto da loro all’interno della Brigata. Le testimonianze, al centro della collezione “Brigata Stella Rossa” e del “Video Archivio Stella Rossa”, sono accomunate dalla rivendicazione del proprio ruolo svolto nella guerra di Liberazione, dell’importanza dell’azione partigiana nel contesto di guerra per l’affrancamento dalla dittatura fascista e la liberazione dall’occupante tedesco fino al capovolgimento istituzionale del Paese. La narrazione, ricca di avventura e di pathos, descrive il partigiano mentre compie azioni di sabotaggio condotte ai danni delle linee tedesche e dell’organizzazione fascista, così come gli scontri a fuoco con l’occupante. Ma non solo, le interviste restituiscono anche le difficoltà della vita in montagna, connotata dalla fame, dalla sete, dalla scarsa igiene e dal pericolo costante dettato anche dall’infiltrazione di spie nemiche tra le proprie fila. La stessa Brigata rappresenta, inoltre, un motivo d’orgoglio per chiunque ne abbia fatto parte, che difende il suo onore e quello dei propri commilitoni. Relativamente alla difesa della Brigata, non poche sono le prese di posizione contro le accuse infamanti mosse dai detrattori della Resistenza contro la Stella Rossa, anche (e soprattutto) legate alla strage di Monte Sole, avvenuta secondo costoro proprio a causa dell’azione della Brigata nel territorio e alla sua successiva incapacità di difendere la popolazione civile dalla violenza e ferocia nazifascista.
Inoltre, diversi sono i temi ricorrenti nella memoria dei testimoni e comuni alle diverse collezioni, talvolta sollecitati dai ricercatori attraverso domande specifiche, altre volte ricordati autonomamente. Tra questi: la vita materiale prima della guerra, con particolare attenzione all’ambiente agricolo e al lavoro nei campi che ha caratterizzato l’infanzia e la giovinezza di molti; lo scoppio della guerra e la successiva occupazione nazifascista, che per le molte famiglie del territorio ha voluto dire prima un aggravamento delle condizioni economiche, già provate dalle restrizioni imposte dalla politica autarchica del regime fascista, poi lo sconvolgimento delle proprie abitudini, tema centrale nelle “Interviste sulla quotidianità durante la guerra”; l’incontro con gli sfollati giunti nell’area di Monte Sole da altre località, quindi l’abbandono delle proprie abitazioni a favore dei rifugi sotterranei per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi o ai bombardamenti alleati; la strage di Monte Sole (29 settembre-5 ottobre 1944), con riferimento particolare alle case bruciate, al rastrellamento inaspettato, ai luoghi del massacro, alla violenza inaudita mostrata dai nazifascisti contro la popolazione civile e al ritrovamento dei corpi dei propri familiari trucidati da parte dei superstiti, spesso costretti a provvedere alla loro sepoltura; il rapporto tra i partigiani della Brigata Stella Rossa e la popolazione civile, fatto di collaborazione e sostegno; l’incontro con gli alleati nei primi giorni dell’ottobre 1944, che restituisce ai superstiti un senso di libertà e la sensazione che la guerra fosse al termine; il territorio minato come eredità del conflitto, causa di numerosi morti per calpestamento negli anni successi alla liberazione del territorio.
L’organizzazione di questo fondo, parte della più ampia strategia di promozione culturale messa in campo dal Comitato onoranze, era iniziata il 30 settembre 2023 con la presentazione pubblica del “progetto di valorizzazione dell’archivio di fonti orali”. Da allora, diverse sono state le azioni che il gruppo di lavoro23 ha realizzato per il suo completamento.
La prima fase di lavoro ha visto l’individuazione delle collezioni e il riconoscimento dei files digitali contenenti le interviste, precedentemente riversati dai supporti originali24 e talvolta presenti in molteplici copie. Già durante la successiva fase di catalogazione sono emerse le prime difficoltà. L’individuazione delle date e dei luoghi di registrazione, nonché dei nomi dei testimoni, si rendeva particolarmente complicata non solo per l’assenza di documentazione di corredo, ma anche per le diverse indicazioni manoscritte errate presenti sui supporti originali. È quindi stata avviata una ricerca bibliografica sulle testimonianze relative alla strage di Monte Sole edite in volumi, saggi o articoli scientifici con l’obiettivo di individuare i testimoni, con eventuali notizie biografiche, e informazioni di corredo sulle interviste raccolte nel fondo in oggetto, come luogo e data dell’evento comunicativo. Successivamente è stato avviato un lavoro di trascrizione integrale di queste testimonianze, a seguito del quale sono state concluse le operazioni di riconoscimento dei testimoni e di datazione, nel tempo e nello spazio, delle interviste. Inoltre, per ciascuna di queste25 sono stati realizzati degli abstract, consistenti in brevi profili biografici del testimone redatti a partire da quanto raccontato, che illustrano gli episodi principali che lo hanno visto coinvolto.
L’esito di questo lavoro sul fondo di fonti orali dell’Archivio del Comitato onoranze è oggi confluito all’interno del predetto archivio digitale. Attualmente in fase di ultimazione e collaudo, il portale ospita una sezione denominata “Fonti orali”, caratterizzata da una parte pubblica e una privata. La prima permette all’utente di conoscere ogni collezione attraverso una sua breve descrizione, la scheda di catalogazione ed eventuali note degli archivisti; la seconda, invece, sarà prossimamente accessibile da parte del pubblico interessato previa registrazione e autenticazione tramite Spid, quindi compilazione di un modulo di accesso e di consultazione. Tale scelta è dovuta alle diverse considerazioni tenute internamente al gruppo di lavoro e successivamente discusse con soggetti terzi, nella convinzione che questa possa essere una procedura appropriata per consentire la visione di questi materiali da parte dell’utenza e contemporaneamente garantire il corretto utilizzo dei documenti d’archivio e la salvaguardia dell’onore dei testimoni. Infine, nell’area riservata l’utente avrà a disposizione l’abstract e la scheda di catalogazione dell’intervista, il file multimediale, in formato audio o audio-video, e la sua trascrizione a fronte.
6. Fuori dagli archivi
La messa in rete di questi archivi orali non desta esclusivamente l’interesse del pubblico accademico e degli studiosi impegnati sul tema della memoria, del nazifascismo e della Seconda guerra mondiale, ma anche della cittadinanza, a livello locale e nazionale, cui è restituito un insieme organico di racconti che si inseriscono in quel complicato intreccio di memorie individuali e collettive, private e pubbliche, presentato brevemente nell’apertura di questo articolo.
Tale aspetto evidenzia fortemente la declinazione public di questi progetti, che sfruttano efficacemente il web come canale di valorizzazione, diffusione e disseminazione dei contenuti, permettendo la loro fruizione e consultazione da remoto, quindi favorendo l’accessibilità alla documentazione attraverso la registrazione ai diversi portali digitali. Questi si presentano come vere e proprie bacheche in cui il dialogo tra materiali testuali, iconografici e audiovisivi consente all’utente di esplorarne i contenuti attraverso diversi livelli di lettura.
Ma gli aspetti public non si limitano al mondo digitale. Al contrario, il lavoro svolto nell’ambito di queste progettualità ha introdotto numerosi ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado a questi temi, portandoli a riflettere sul nostro passato e sulla nostra attualità. È il caso, ad esempio, delle attività didattiche svolte nel territorio bolognese, padovano e romano all’interno del progetto “Italian Victims of National Socialism. A project for Schools and Citizenship” tra l’autunno e l’inverno dell’anno scolastico 2024/2025, dove gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con le fonti orali a partire dai documentari prodotti dai documenti conservati in archivio26.
Attraverso queste interviste, le voci di uomini e donne che hanno vissuto il periodo bellico, subito le violenze nazifasciste e combattuto contro di esse, riemergono, ci spingono a riflettere sulle nostre origini democratiche e a interrogarci sul presente, rinnovando il monito sull’importanza della memoria e del ricordo. Nell’Ottantesimo anniversario della Liberazione voci del passato rompono le mura degli archivi e abbracciano la cittadinanza, in uno efficace scambio tra dimensione archivistica, pubblica, digitale e orale.
Note
1 Sulla guerra civile si veda Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
2 Sulla costruzione della memoria collettiva rispetto alla Seconda guerra mondiale, alla Resistenza e al fascismo si veda Giovanni De Luna, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Milano, Feltrinelli, 2015; Filippo Focardi, Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, foibe, Roma, Viella, 2020.
3 Sulle origini del mito del “bravo italiano” si veda Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2013.
4 Si veda Davide Conti, Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra, Roma, Odradek, 2011.
5 Si tratta di: Irene Bolzon, Federico Goddi, Roberta Mira, Amedeo Osti Guerrazzi, Toni Rovatti, Simona Salustri, Matteo Stefanori.
6 Sito web: https://memoriavittimenazismofascismo.it/, ultima consultazione di tutti i link: 10 agosto 2025., ultima consultazione di tutti i link: 10 agosto 2025.
7 Per una prima interpretazione delle interviste e dei temi che da esse emergono si veda la prima parte del volume che accoglie gli atti del convegno: Filippo Focardi (a cura di), Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Le memorie dei sopravvissuti tra testimonianza e ricerca storica, Roma, Viella, 2021.
8 Sulla public history: Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso Botti (a cura di), Public History. Discussioni e pratiche, Milano, Mimesis, 2017; Michael H. Frisch, A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History, Albany, NY, State University of New York Press, 1990; Robert Kelley, Public History. Its Origins, Nature, and Prospects, in “The Public Historian”, 1978, vol. 1, n. 1; Serge Noiret, La Public History, una disciplina fantasma?, in “Memoria e Ricerca”, maggio-agosto 2011, n. 37, pp. 9-35.
9 I tre prodotti audiovisivi sono stati realizzati da Andrea Bacci nel 2024. Nello specifico:
Memorie della persecuzione. Il racconto dei sopravvissuti ebrei (24:42 min.)
[https://memoriavittimenazismofascismo.it/portfolio/memorie-della-persecuzione-il-racconto-dei-sopravvissuti-ebrei/];
Il racconto dei superstiti. Le stragi nazifasciste in Italia (15:13 min.)
[https://memoriavittimenazismofascismo.it/portfolio/il-racconto-dei-superstiti-le-stragi-nazifasciste-in-italia/];
Non ci hanno piegati. Le testimonianze degli Internati Militari Italiani (17:29 min.)
[https://memoriavittimenazismofascismo.it/portfolio/non-ci-hanno-piegati-le-testimonianze-degli-internati-militari-italiani/].
10 Si tratta di 104 interviste realizzate nel biennio 2019-2020 e una nuova nel 2024.
11 “Quante storie nella storia” è un evento promosso dalla Regione Emilia-Romagna dedicato alla didattica e all’educazione al patrimonio archivistico conservato nel territorio regionale. La manifestazione è organizzata con Anai. Associazione nazionale archivistica italiana – Sezione Emilia Romagna e Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna. Nel 2024 giunge alla 23a edizione.
12 Il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto è istituito attraverso la Legge regionale n. 47 del 20 ottobre 1982. Il Comitato ha per fine statutario quello di “mantenere vivo il ricordo del sacrificio dei cittadini vittime dell’eccidio perpetrato dai nazi-fascisti nell’autunno del 1944. Si propone di promuovere e diffondere, fra le genti del nostro e di altri Paesi, gli ideali di libertà, di pace, di giustizia sociale, di solidarietà e di cooperazione internazionale, per un mondo affrancato dalla violenza, ideali che costituirono le basi del patto unitario delle forze antifasciste nella Resistenza, che sono fondamento della Carta Costituzionale”, art. 1, Statuto del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.
13 Sulle vicende dell’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto si veda Eloisa Betti, La memoria di Monte Sole nelle carte. Genealogia e sviluppo dell’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto – Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra, in Eloisa Betti (a cura di), Guida agli archivi del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto. Fonti e bibliografia ragionata, Bologna, Bologna University Press, 2024, pp. 11-34.
14 Per una panoramica si veda Marta Magrinelli, Fabrizio Monti, Guida agli archivi, in Betti (a cura di), Guida agli archivi del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, cit., pp. 37-100.
15 Fabrizio Monti, Allegra Paci, Matteo Marzocchi (EBLA), Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto – Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra, Inventario; con la collaborazione di Lina Rossi per le sezioni Manifesti e Audio video, 2023. Inventariazione e descrizione delle collezioni/raccolte fotografiche a cura di Marta Magrinelli e Lorenzo Gherlardini, 2025. https://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ead-str/IT-ER-IBC-AS01348-0000001.
16 Luigi Arbizzani (11 marzo 1924-8 aprile 2004) è stato una figura di spicco nel panorama politico-culturale bolognese della seconda metà del Novecento. Sulla sua figura si veda: Alessandro Albertazzi, Bruno Bertusi (a cura di), Luigi Arbizzani, Monte Sole, la Brigata Stella Rossa, l’eccidio di Marzabotto, Bologna, Digi Graf, 2018.
17 Pamela Galeazzi, Allegra Paci (EBLA), Archivio Dante Cruicchi, 2023. Inventario; Descrizione della serie “Fotografie” a cura di Marta Magrinelli e Lorenzo Ghelardini, 2023 [https://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ead-str/IT-ER-IBC-AS01465-0000001]. Dante Cruicchi (29 luglio 1921-01 aprile 2011) è stato segretario dell’Organizzazione mondiale dei giornalisti (1959-1961) e sindaco di Marzabotto (1975-1985). Sul piano internazionale, è stato importante il suo contributo nell’Unione mondiale delle città martiri, nell’Associazione nazionale delle città messaggere di pace e nella Federazione mondiale delle città unite. Si veda: Carlo De Maria (a cura di), L’artigiano della pace. Dante Cruicchi nel Novecento, Bologna, Clueb, 2013; Eloisa Betti, Federico Chiaricati e Tito Menzani (a cura di), Dante Cruicchi, l’artigiano della pace: mostra fotografica a 100 anni dalla nascita (1921-2021), Catalogo della mostra, Bologna, Bologna University Press, 2022.
18 Fabrizio Monti (EBLA), Archivio avvocati Giuseppe Giampaolo – Andrea Speranzoni, 2024. Inventario. https://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ead-str/IT-ER-IBC-AS01513-0000001.
19 Archivio digitale del Comitato Onoranze. https://archivio-martiri-marzabotto.azurewebsites.net/.
20 Sulla Brigata Stella Rossa si veda: Giampietro Lippi, La Stella rossa a Monte Sole. Uomini, fatti, cronache, storie della brigata partigiana “Stella rossa Lupo Leone”, Bologna, Ponte Nuovo, 1989; Luigi Paselli, Marzabotto, 29 settembre 1944. Leggenda e tragedia di una brigata partigiana, in “Archivio Trimestrale”, ottobre 1983, n. 2, pp. 392-421.
21 Nel dettaglio, in ordine cronologico: Collezione Giampietro Lippi-“Brigata Stella Rossa” (1974-1995); Collezione Mirco Dondi-“Interviste sulla quotidianità durante la guerra” (1994-1997); Collezione Parco Storico di Monte Sole-“Itinerari di Pace” (2001); Collezione Giampietro Lippi-“Sono viva… credo” (2003); Collezione Parco Storico di Monte Sole-“I testimoni di Monte Sole” (2003); Collezione Parco Storico di Monte Sole-“Video Archivio Stella Rossa” (2006-2007).
22 A queste collezioni si aggiunge un’ulteriore raccolta, “Miscellanea” (1989-2012).
23 Il gruppo di lavoro era formato da Marta Magrinelli e Benedetto Fragnelli per la parte archivistica, da Carloalberto Canobbi per quella informatica, con la supervisione scientifica di Eloisa Betti, responsabile dell’Archivio del Comitato onoranze.
24 Audiocassette, betacam, mini-dv, video8, vhs.
25 Per intervista si intende l’evento comunicativo realizzato in una singola giornata, talvolta suddiviso in più item (files). Eventi comunicativi realizzati in giorni diversi, anche consecutivi, sono stati interpretati come due diverse interviste.
26 Sulle attività didattiche si rimanda all’articolo di Stefania Ficacci e Tito Menzani presente in questo Dossier.