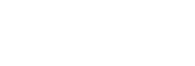In apertura: l’evento di avvio del progetto a Padova, in data 11 novembre 2024.
1. Premessa
Nel corso del 2025 si sono sviluppate e sono state portate a compimento le attività di Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Un progetto per le scuole e la cittadinanza1. Coordinato da Filippo Focardi, professore dell’Università di Padova, studioso di memoria del fascismo e della Seconda guerra mondiale2, il progetto aveva l’obiettivo di disseminare i risultati di un’attività precedente, denominata Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Conoscere, ricordare, diffondere, sviluppata tra il 2019 e il 2020. Entrambi i progetti sono stati finanziati dal Fondo italo-tedesco per il futuro, istituito dalla Germania per promuovere politiche di riconciliazione con l’Italia sui temi della memoria del Secondo conflitto mondiale. In particolare, ha sostenuto iniziative incentrate sui temi del rappacificamento, dell’identità e della storia comune. In questo contributo, si vuole dare conto di quanto fatto e discuterne l’efficacia alla luce dei più recenti dibattiti sulle memorie del Novecento e il loro utilizzo didattico. Ricapitoliamo innanzi tutto quali furono i risultati raggiunti con il primo progetto di cinque anni fa. Dopodiché, nei prossimi paragrafi, entreremo nel merito di quanto realizzato nel 2024 insieme con alcune scuole delle province di Padova, Roma e Bologna. Anche il progetto Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Conoscere, ricordare, diffondere era coordinato da Filippo Focardi. Nella fattispecie, il gruppo di lavoro era formato da undici persone e si occupò di raccogliere una serie di videointerviste fra le vittime italiane del nazismo. Si trattava per lo più di uomini e donne – tutti ultraottantenni o addirittura ultranovantenni – che da bambini o da ragazzi avevano vissuto sulla propria pelle la violenza nazista. In questa maniera, furono raccolte e preservate memorie preziose, altrimenti destinate a scomparire negli anni successivi, in considerazione del fatto che nessuno è eterno e prima o poi viene a mancare.
Nel 2024, tutte queste testimonianze sono state sistematizzate in un database con la trasformazione del portale precedente in cui era stato ospitato l’archivio digitale con le oltre cento videointerviste realizzate fra il 2019 e il 2020. L’obiettivo era creare in uno strumento di informazione e di dialogo con le scuole e la cittadinanza in un’ottica di public history3. Contestualmente, all’inizio del 2024 si è dato l’incarico al regista Andrea Bacci di realizzare tre documentari a scopo didattico basati rispettivamente sulle testimonianze di vittime della persecuzione antisemita, di ex internati militari e di sopravvissuti a stragi nazifasciste. La produzione di tali filmati è stata resa possibile grazie a un lavoro preparatorio che ha comportato una selezione delle interviste e una ricerca iconografica per il reperimento di fotografie storiche da inserire all’interno della narrazione. Quindi, è stato consultato l’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto – Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra4. Altre immagini sono reperite presso l’Istituto storico Parri di Bologna5 e presso il Centro di documentazione di Sant’Anna di Stazzema6.
Realizzati sotto la supervisione scientifica di docenti del Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova, i tre documentari sono stati poi utilizzati in incontri con docenti e studenti di scuole secondarie di primo e di secondo grado, che hanno avuto luogo nelle province di Padova, di Roma e di Bologna. Prima di passare a descrivere le varie attività, occorre ricordare come entrambi i progetti citati in apertura siano stati finanziati dal Fondo italo-tedesco per il futuro, creato dal governo della Germania al fine di sostenere la cultura della memoria, ad esempio con centri di documentazione, monumenti, memoriali, mostre e attività educative rivolte alle nuove generazioni.
2. Il kick-off a Padova
L’11 novembre 2024 si è tenuto l’evento che ha dato ufficiale avvio all’ultima parte del progetto, ovvero quella dei laboratori didattici rivolti alle scuole. Grazie ad un importante lavoro preparatorio dell’Ufficio «Progetto giovani» del Comune di Padova, si è interamente riempito di ragazzi e di ragazze l’Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, per un totale di circa duecentoventi studenti, oltre a quattordici insegnanti. Si trattava di classi o di delegazioni di classi degli Istituti superiori della provincia di Padova, che avrebbero affrontato un «viaggio della memoria» sui luoghi della Shoah e delle persecuzioni naziste. L’incontro è durato due ore ed era stato pensato e progettato con una funzione preparatoria e formativa, in vista della visita ai lager e ad altri contesti simili.
Sul palco dell’Auditorium, Filippo Focardi ha introdotto i lavori della mattinata, spiegando le caratteristiche dell’attività, la sua sinergia con i viaggi della memoria, e l’importanza della storia, quale disciplina scientifica. Successivamente c’è stato un bel video-saluto di Andreas Krüger, responsabile culturale dell’Ambasciata tedesca in Italia. Poi ha preso la parola Tito Menzani, che ha sinteticamente riassunto i fatti principali della Seconda guerra mondiale, dato che quest’ultima era lo scenario nel quale si inscrivevano i tre video che di lì a poco sono stati proiettati. Il primo, con le testimonianze degli ebrei perseguitati, è stato introdotto da Amedeo Osti Guerrazzi, docente dell’Università di Padova e autore di importanti ricerche su questi temi7; il secondo, incentrato sugli internati militari italiani, è stato illustrato da Filippo Focardi; e il terzo, relativo alle vittime civili delle stragi nazifasciste, è stato presentato da Eloisa Betti, ricercatrice dell’Ateneo di Padova e profonda conoscitrice delle questioni storiografiche incentrate sulla memoria8. Dopo la visione dei filmati, ci sono state alcune domande da parte degli studenti alle quali hanno risposto gli studiosi presenti sul palco. Poi Tito Menzani ha illustrato le possibilità di proseguire tale attività didattica, sia con laboratori dedicati in classe, sia con eventuali visite al Museo nazionale dell’internamento9 e al Museo della Padova ebraica10. Le parole di chiusura di tutta la mattinata sono state di Filippo Focardi, che ha ringraziato anche gli insegnanti per l’impegno messo in questo progetto11.
L’attenzione degli studenti è stata davvero molto elevata. Da alcune interlocuzioni successive con gli insegnanti, si è compreso come siano stati particolarmente colpiti da tre aspetti. Il primo è quello della varietà di esperienze differenti vissute dalla comunità ebraica italiana tra il 1943 e il 1945: chi venne deportato, chi riuscì a nascondersi, chi poté fortunosamente espatriare, chi, dopo la fine della guerra, dovette lottare per riavere l’appartamento che nel frattempo era stato espropriato e assegnato a terzi. Il secondo è la peculiarità della storia degli internati militari italiani, poco conosciuta anche se assolutamente cruciale per cogliere il significato e l’ampiezza dell’antifascismo. Il terzo riguarda l’efferatezza dei crimini di guerra commessi da alcuni soldati tedeschi contro la popolazione civile italiana, con atti particolarmente crudeli contro persone del tutto inermi, quali bambini, donne e anziani. In generale, quindi, si ritiene che la mattinata sia stata capace di trasmettere importanti contenuti storici ai ragazzi e alle ragazze presenti, preparandoli al successivo viaggio della memoria.
Anche se il progetto terminava ufficialmente il 31 dicembre 2024, con alcuni insegnanti del Liceo Concetto Marchesi di Padova si è concordato un intervento nell’Aula Magna nel plesso di Cadoneghe in data 19 febbraio 2025, a vantaggio di settanta studenti di tre classi riunite. In quell’occasione, Tito Menzani ha introdotto il progetto, spiegato il contesto storico e proposto i tre filmati, rispondendo contestualmente alle domande successivamente poste dai liceali.
3. L’attività didattica svolta a Roma
Nel contesto romano il progetto Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Un progetto per le scuole e la cittadinanza si è svolto presso l’Istituto comprensivo via Francesco Laparelli 60 e il Liceo Scientifico Isaac Newton, che sorgono nell’area metropolitana sudorientale e afferente alla prima fascia periferica della città (Municipio Roma 5 e Roma 7). Gli istituti scolastici operano nei quartieri di Tor Pignattara, Quadraro, San Giovanni ed Esquilino, territori con peculiari caratteristiche socio-culturali quali: una elevata presenza di studenti di origine straniera di prima e seconda generazione (tra il 40% e il 60%), provenienti, principalmente, dal sud-est asiatico (Bangladesh, Pakistan, India, Cina); un ruolo centrale nella lotta di liberazione dal nazifascismo, la cui memoria pubblica è ancora oggi visibile mediante targhe commemorative, pietre d’inciampo, monumenti e il museo della Liberazione di Via Tasso.
Il progetto – che ha coinvolto sei classi di terza media, per un totale di circa 150 studenti e 20 docenti e operatori scolastici, e una classe di 25 studenti di quarta superiore assistiti da due docenti – è stato promosso come attività semestrale preminente del più ampio servizio educativo e di formazione che l’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros12 offre come supporto alla comunità educante presente nel territorio di cui è ente gestore13. In questo modo il progetto è divenuto un’attività educativa integrativa del programma di storia contemporanea e di educazione civica, in sintonia con gli obiettivi perseguiti dall’attività didattica ordinaria degli istituti scolastici coinvolti. Il progetto, quindi, è divenuto uno strumento di sperimentazione della didattica della storia e di sviluppo di competenze interpretative e linguistiche specifiche, offrendo nuove e diversificate risorse per l’approfondimento e l’educazione alla cittadinanza attiva. La differenza di età anagrafica fra gli studenti coinvolti ha consentito anche una duplice lettura delle metodologie e dei risultati ottenuti. Nello specifico, se per gli studenti di terza media il progetto ha avuto un impatto maggiore sullo sviluppo di competenze definibili propedeutiche allo studio della storia contemporanea, per gli studenti delle superiori esso si è mostrato un utile strumento per avvicinarli alle pratiche storiografiche e di ricerca, quali l’attendibilità delle fonti scritte e orali nelle forme dei testi a stampa come dei prodotti digitali e audiovisivi, nonché all’elaborazione di un proprio pensiero critico riguardo la dittatura e le discriminazioni politiche, culturali ed etniche che essa ha prodotto.
Il progetto si è svolto fra l’ottobre e il dicembre del 2024 e ha coinvolto gli studenti in due attività principali: un laboratorio in classe e un’uscita didattica presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine. La pratica laboratoriale, svolta in orario scolastico da Stefania Ficacci e con il supporto dei docenti di storia e educazione civica, ha rappresentato il primo momento di incontro con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sebbene, nel perseguimento delle finalità del progetto, il principale obiettivo sia stato quello di introdurre il tema della persecuzione e della violenza nazifascista in Italia – mediante una comparazione fra le differenti aree geografiche indicate dalle testimonianze audiovisive presentate – studenti e docenti sono stati coinvolti in un percorso di comprensione della semiotica attraverso la quale i testimoni si esprimevano verbalmente e non. La scelta di dedicare ampio spazio all’osservazione dei gesti e all’ascolto delle modalità di autorappresentazione del testimone è emersa da un confronto preliminare con i docenti di riferimento, che hanno espresso le molteplicità difficoltà riscontrate nelle attività didattiche ordinarie di dialogare con una generazione che adotta il linguaggio visuale come principale strumento di comunicazione, attraverso cui propone una narrazione di sé e del proprio vissuto quotidiano spesso come unica forma di autorappresentazione e interpretazione della realtà. Concentrando l’attenzione sulle videotestimonianze dei sopravvissuti alle stragi nazifasciste dei comuni dell’appennino tosco-emiliano, con particolare attenzione alle stragi di Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto, sono state fornite in visione alcune testimonianze dei familiari delle vittime della strage delle Fosse Ardeatine14, invitando quindi gli studenti a ragionare sui significati semantici dei termini «testimone» e «sopravvissuto»15. Spiegate le differenze fra le due stragi (esecutori, motivazioni e contesti geografici) gli studenti hanno evidenziato come la rappresentazione di sé e dell’evento da parte dei testimoni sia generalmente basata sulla personale percezione emotiva e che la semiotica, verbale e non, riflette il trauma subìto dal singolo, dalla famiglia, dalla comunità, sottolineando anche come il riconoscimento di sopravvissuto – direttamente valido per le stragi perpetrate nell’appennino tosco-emiliano – nell’evento delle Ardeatine abbia acquistato un significato differente, perché relativo non a uomini e donne scampati alla violenza diretta, bensì a familiari (generalmente figli e nipoti) che si definiscono sopravvissuti perché hanno assunto su di sé il ruolo di testimoni del trauma personale e familiare, divenuto anche di comunità.
L’uscita didattica è diventata quindi un momento esperienziale. La vicinanza del Mausoleo delle Fosse Ardeatine16 agli istituti scolastici coinvolti e la presenza nei quartieri, che gli studenti abitano e frequentano, di opere artistiche, musei e monumenti che ricordano la strage ha contribuito a comprendere le connessioni fra la comunità in cui vivono (fra le più attive nel ricordo della strage) con il luogo della memoria che le Ardeatine sono diventate: una memoria non solo dell’evento drammatico, ma anche di tutta la lotta di liberazione dal nazifascismo della città di Roma e dell’Italia. Questo è stato reso possibile proprio dagli elementi simbolici presenti presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, ovvero l’area d’ingresso che ricorda la strage di Marzabotto e la stele accanto al museo dedicata alle vittime di Sant’Anna di Stazzema. In conclusione, l’uscita didattica ha rappresentato per gli studenti un ottimo strumento per trasferire la riflessione sulla semiotica, colta nelle videointerviste, su quella dell’incontro con il luogo fisico.
4. Il progetto nelle scuole della provincia di Bologna
In provincia di Bologna, si è lavorato con le singole classi, grazie a un laboratorio didattico appositamente progettato, denominato Voci delle vittime del nazifascismo. Questo è stato declinato in due versioni: per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, si è innanzi tutto proposto alle terze medie e alle quinte superiori, ovvero ai ragazzi e alle ragazze alle prese con lo studio del Novecento nel programma di storia. Tuttavia, hanno aderito anche altre classi, con studenti di differente età. Complessivamente, tra novembre e dicembre 2024, in provincia di Bologna si sono svolti sedici incontri – tra attività in aula ed escursioni –, che hanno coinvolto dieci classi per un totale di 202 studenti. In particolare, sono stati coinvolti gli Istituti comprensivi di Marzabotto e di Vado-Monzuno, con le scuole medie Giuseppe Dossetti e John Fitzgerald Kennedy, e l’Istituto superiore Luigi Fantini di Vergato. Anche in questo caso, pur se il progetto era formalmente concluso il 31 dicembre, 2024, nella primavera del 2025 c’è stata una coda di attività. Infatti, anche l’Istituto comprensivo di Vergato-Grizzana, con le scuole medie Emilio Veggetti e don Lorenzo Milani, e l’Istituto superiore Manfredi-Tanari avevano manifestato interesse verso il progetto, per cui si sono concordati laboratori didattici in aula ed escursioni dedicate. Le attività in classe sono state condotte da Tito Menzani. Sia alle medie che alle superiori si è voluta spiegare la violenza nazifascista, principalmente attraverso i tre documentari di videotestimonianze e altri materiali utili. Anche in questo caso si sono trattate tre categorie di vittime: gli ebrei, gli internati militari e i civili uccisi nelle stragi. Gli studenti hanno così potuto prendere contatto con il tema della violenza nazifascista nella Seconda guerra mondiale. Questa era messa in relazione all’ideologia razzista e suprematista che aveva scatenato il conflitto. Il laboratorio in aula è stato abbinato a una visita a un luogo esperienziale, in particolare, le classi hanno svolto un percorso a Marzabotto, nel già citato Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto – Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra, ma anche presso il Sacrario ai caduti17 ed il Centro di interpretazione18. Quest’ultimo fornisce un approfondimento sulla storia del territorio, con particolare riferimento all’eccidio e alla Seconda guerra mondiale. Ci sono tre sale, dedicate alla storia della comunità, alla strage di Monte Sole e alla brigata partigiana Stella Rossa, che offrono al visitatore pannelli informativi, materiale audio-video e un tavolo multimediale. I laboratori didattici realizzati in provincia di Bologna hanno seguito tre principi di fondo, che si riepilogano qui di seguito. Il primo è quello della varietà. Vale a dire che si sono utilizzati media differenti, ovvero slide, video e materiale ludico-didattico, alternandoli alla voce dell’operatore, così da rendere più fruibile l’incontro; infatti, una delle criticità principali delle nuove generazioni è la difficoltà di mantenere la concentrazione. Il secondo è quello del dialogo: per il medesimo motivo si è cercato di instaurare una interlocuzione con studenti e studentesse, sollecitando domande e commenti. Il terzo è quello dello sguardo locale e internazionale: sullo sfondo della Seconda guerra mondiale – evento su scala planetaria – si è focalizzata l’attenzione su territori e persone, con particolare riguardo all’area di Monte Sole; questa dialettica tra sfera internazionale e contesto locale è stata una chiave interpretativa utile in classi spesso contraddistinte da una presenza multietnica.
Nelle scuole secondarie di primo grado, al termine dei video, è stato spesso proposto un gioco didattico. La classe veniva divisa in quattro gruppi, ognuno dei quali riceveva un testo incentrato su una biografia di una persona coinvolta nella Seconda guerra mondiale: ce n’era una di un ebreo italiano, una di un internato militare, e due di civili scampati fortunosamente agli eccidi nazifascisti. Ogni testo biografico conteneva cinque errori. Il gruppo aveva il compito di individuarli, ragionando sulle incongruenze nel testo stesso e rispetto a quanto ascoltato in precedenza, nei video e nella spiegazione dell’operatore. Al termine del tempo assegnato per tale gioco didattico, si sono fornite le soluzioni. Infine, i docenti delle classi coinvolte hanno ricevuto un piccolo kit di materiali didattici, da utilizzarsi eventualmente per dare continuità o profondità all’attività svolta.
5. In conclusione: valutazioni e possibili sviluppi futuri
Il progetto ha rappresentato un’esperienza formativa e educativa sia per il gruppo di lavoro sia per gli studenti e i docenti, mostrando coerenza con gli obiettivi dichiarati, l’innovazione metodologica applicata e la qualità dei contenuti offerti, vista l’ampia partecipazione delle comunità scolastiche coinvolte e la profonda riflessione pedagogica che ne è scaturita. Proprio quest’ultima appare infatti il principale feedback positivo riscontrato, poiché ha valorizzato il progetto come strumento didattico e supporto formativo adottabile da parte dei docenti coinvolti nell’ambito curriculare ordinario. Fin dalle prime fasi, il progetto ha mostrato un forte allineamento con le finalità dichiarate: in particolare, si è confermato come prosecuzione virtuosa del precedente percorso Conoscere, ricordare, diffondere, mantenendo al centro la valorizzazione della memoria storica delle persecuzioni nazifasciste in Italia. In questa prospettiva di continuità con il progetto precedente, le attività proposte hanno contribuito a promuovere la consapevolezza storica e civica attraverso la sensibilizzazione di studenti e cittadinanza, privilegiando modalità esperienziali e multimediali, e confermando la centralità della scuola come luogo privilegiato di trasmissione attiva della memoria del Novecento.
Uno degli aspetti più riusciti è stata la capacità del progetto di integrare ricerca scientifica, public history e attività didattiche, articolando con efficacia i contenuti storici in una forma accessibile e coinvolgente in un ambito, quello scolastico, talvolta penalizzato da strumenti didattici non del tutto coerenti con i reali bisogni educativi espressi dai docenti, né al passo con le differenti e nuove forme di comunicazione e rappresentazione adottate dagli studenti. Particolarmente apprezzato è risultato l’uso dell’audiovisivo costruito su una semiotica il più possibile neutra, che concentra l’attenzione sulle testimonianze dirette e sulle fonti iconografiche, senza proporre un preciso storytelling, né pretendendo di presentarsi come documentario precostituito, dove prevalgono gli obiettivi e le finalità dei ricercatori. Al contrario la restituzione nuda della testimonianza orale e fotografica degli eventi personali e collettivi invita all’ascolto senza filtri da parte degli studenti, messi a contatto con le fonti e invitati all’interpretazione di questi attraverso un processo critico e dialogico, dove il ricercatore, come il docente, funge da mediatore piuttosto che da divulgatore scientifico.
Fra le tre tipologie di vittime del nazifascismo – cittadini di religione ebraica, militari internati e sopravvissuti alle stragi civili – proprio quest’ultima categoria ha attirato maggiore attenzione da parte degli studenti. Ciò probabilmente è dovuto alle caratteristiche stesse delle stragi civili, che in parte sono emerse proprio dagli incontri con gli studenti: un evento che si consuma in una comunità, coinvolgendo direttamente o indirettamente la maggioranza dei suoi abitanti, le motivazioni non dovute a specifiche categorie di persecuzione (razziale, politica, sessuale), che rimandano ad una più semplice comprensione, ovvero che, in particolare momenti storici e in determinati contesti, la persecuzione sia uno strumento di mantenimento del potere che può non seguire logiche precostituite, ma agisce senza particolari cause e che non può essere inserito in semplice sistema di “rispetto delle regole”. Il progetto ha raggiunto una rilevante diffusione territoriale. In provincia di Bologna, sono stati coinvolti oltre duecento studenti attraverso sedici incontri tra scuola e territorio, che hanno incluso attività d’aula e visite presso l’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il Sacrario ai caduti e il Centro di interpretazione. A Roma, il progetto ha raggiunto circa duecento studenti, appartenenti a scuole secondarie di primo e secondo grado, articolato in laboratori didattici in aula e la visita del Mausoleo delle Fosse Ardeatine. In tutte le fasi del progetto sono stati coinvolti docenti, educatori e operatori museali, consolidando una rete educativa e culturale in grado di connettere scuola, territorio e cittadinanza. L’adesione di istituti con background eterogenei e la collaborazione con ecomusei e luoghi della memoria ha rafforzato l’impatto locale dell’iniziativa, confermando il valore formativo dell’incontro diretto con la storia nei luoghi in cui essa è avvenuta.
Le attività didattiche sono state progettate secondo tre principi metodologici fondamentali: la varietà degli strumenti, la promozione del dialogo con gli studenti e l’attenzione alla connessione tra dimensione locale e globale. Particolarmente significativa è stata l’adozione di pratiche educative non convenzionali: il gioco didattico basato su biografie contenenti errori, che ha stimolato la partecipazione attiva, la capacità critica e la conoscenza della storia degli studenti. Ogni gruppo-classe ha lavorato per identificare le incongruenze presenti nei testi, mettendo in relazione le biografie con le informazioni ricevute nei documentari e negli interventi in aula; l’analisi semiotica delle testimonianze audiovisive ha favorito una riflessione più profonda sulle modalità della narrazione storica e sulla costruzione della memoria pubblica, accostando gli studenti a strumenti interpretativi di maggiore complessità. Dal punto di vista dell’integrazione curricolare, il progetto si è perfettamente inserito all’interno dei percorsi di storia, educazione civica e italiano. Le attività hanno rispecchiato le esigenze delle programmazioni scolastiche, contribuendo ad arricchire i percorsi formativi esistenti. I materiali forniti ai docenti – tra cui i kit didattici – hanno permesso di proseguire autonomamente l’approfondimento dei temi trattati.
Una riflessione pedagogica merita infine l’attenzione riservata al linguaggio e ai bisogni educativi delle nuove generazioni. Il progetto ha cercato di stabilire un dialogo diretto con gli studenti attraverso strumenti comunicativi visivi, simbolici ed emotivi, valorizzando l’immediatezza e la forza delle immagini e delle testimonianze. L’approccio semiotico applicato alle videointerviste ha permesso di esplorare le implicazioni narrative e valoriali delle fonti orali, favorendo un apprendimento critico e riflessivo. Nonostante il successo complessivo, alcune criticità sono emerse, come la necessità di differenziare ulteriormente le attività in base all’età e al livello delle classi, nonché le difficoltà logistiche legate all’organizzazione delle uscite didattiche, soprattutto nei mesi successivi alla conclusione formale del progetto.
In conclusione, il progetto Le vittime italiane del nazionalsocialismo ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra università, scuole, enti culturali e istituzioni della memoria. La sua capacità di coniugare ricerca storica, innovazione didattica e partecipazione civica in forme accessibili e coinvolgenti ne fa un modello replicabile e auspicabilmente estendibile ad altri contesti territoriali e scolastici, anche in chiave nazionale ed europea. L’auspicio è che esperienze di questo tipo possano consolidarsi come parte integrante della formazione storica e civica delle giovani generazioni, contribuendo alla costruzione di una memoria consapevole, inclusiva e profondamente radicata nei valori costituzionali della nostra democrazia.
Note
1 https://memoriavittimenazismofascismo.it/ (ultima consultazione di tutti i link: 18 agosto 2025). (ultima consultazione di tutti i link: 18 agosto 2025).
2 Filippo Focardi (a cura di), Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Le memorie dei sopravvissuti tra testimonianza e ricerca storica, Roma, Viella, 2021.
3 Cfr. Serge Noiret, The birth of a new discipline of the past? Public history in Italy, in “Ricerche storiche”, 2019, n. 3, pp. 131-165. Cfr. anche Luigi Tomassini, Raffaella Biscioni, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, in Gianfranco Bandini, Stefano Oliviero (a cura di), Public History of Education: riflessioni, testimonianze, esperienze, Firenze, Firenze University Press, 2020, pp. 3-23.
4 https://www.martirimarzabotto.it/archivio/.
5 https://www.istitutoparri.eu/.
7 Amedeo Osti Guerrazzi, Gli specialisti dell’odio. Delazioni, arresti, deportazioni di ebrei italiani, Firenze, Giuntina, 2020.
8 Eloisa Betti, Monte Sole, la memoria pubblica di una strage nazista, Roma, Carocci, 2024.
9 https://museodellinternamento.it/.
10 https://www.museopadovaebraica.com/.
11 Il video integrale è disponibile al seguente link: https://memoriavittimenazismofascismo.it/il-progetto/.
12 L’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros è un ente museale territoriale riconosciuto dalla Regione Lazio d’interesse regionale con determina G13389/2019 della Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio e accreditato all’Organizzazione Museale Regionale del Lazio. Nel 2024 è stato accreditato presso il Forum ONG dell’Unesco. https://www.ecomuseocasilino.it.
13 https://www.ecomuseocasilino.it/ecomuseo-0-25.
14 In particolare è stata visualizzata l’intervista a Domenico Venanzio Ricci, figlio di Domenico Ricci ucciso nella strage delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 e abitante nel quartiere romano di Centocelle. La videointervista è visibile sul canale YouTube dell’Ecomuseo Casilino ad Duas Mauros all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=SMgQD1n06JY&t=2s.
15 Fra i testi a cui si è fatto maggiore riferimento si vedano: Mario Avagliano, Marco Palmieri, Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine, Torino, Einaudi, 2024; Rosario Bentivegna, Operazione via Rasella. Verità e menzogna: i protagonisti raccontano, Roma, Editori Riuniti, 1996; Alessandro Portelli, L’ordine è già stato eseguito, Roma, Donzelli, 2005.
16 https://www.mausoleofosseardeatine.it/.
17 https://www.comune.marzabotto.bo.it/vivere-il-comune/luoghi/sacrario.
18 https://www.comune.marzabotto.bo.it/servizi/turismo/servizio-informazione-turistica.