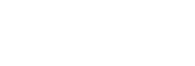In apertura: “Stadio”, 20 luglio 1966, p. 1 (Biblioteca nazionale centrale di Firenze).
1. Il calcio italiano fra il 1945 e il 1966: la questione dei calciatori stranieri
L’eliminazione della Nazionale dai Mondiali inglesi del 1966 rappresenta uno spartiacque fra due periodi del calcio italiano: il primo, compreso fra il 1945 e il 1965, caratterizzato da un incremento progressivo delle spese e da restrizioni/aperture all’importazione di calciatori stranieri; il secondo, dal 1966 al 1980, contraddistinto invece da una gestione economica più oculata delle società calcistiche e dal blocco totale all’importazione di giocatori esteri. Le vicende del football italiano non possono però essere separate dagli eventi storici del nostro paese. Infatti, gli anni del secondo dopoguerra furono contrassegnati dalla ripresa postbellica e dal boom economico; il periodo 1966-1980 dalla piccola recessione di metà anni Sessanta, dalla crisi economica del decennio seguente e dal processo di rafforzamento della Comunità europea. La “chiusura delle frontiere” agli atleti d’oltreconfine fu il prodotto delle vicende riguardanti la Figc, la Nazionale e i club italiani. Dopo il ristabilimento dell’unità federale sotto la presidenza Barassi, la ripresa dell’attività degli Azzurri guidati da Vittorio Pozzo e la ricostituzione del campionato nazionale a girone unico per la stagione 1946-1947, negli anni seguenti la Federazione regolamentò a più riprese il tesseramento dei calciatori stranieri, “aprendo” e “chiudendo” in base ai risultati della Nazionale e, verso la fine degli anni Cinquanta, al progressivo accrescimento del peso economico e politico delle squadre di club. A proposito degli Azzurri, fra il 1945 e il 1965 i risultati furono scarsi: vennero eliminati subito dai Mondiali del 1950, del 1954 e del 1962, mancando addirittura la qualificazione a quelli del 1958. Per quanto riguarda le Olimpiadi, a parte la parentesi fortunata di Roma 1960, la Nazionale espresse mediocri performance nel 1948 e nel 1952, decidendo preventivamente di non partecipare nel 1956. I vertici sportivi nazionali ravvisarono la causa principale di queste disfatte nella misera qualità dei calciatori italiani, qualità che sarebbe stata ulteriormente abbassata dall’importazione di giocatori stranieri. Per questo motivo, cercarono a più riprese di regolamentare la presenza di questi ultimi in Italia.
Dopo il Mondiale del 1962, alla guida della Nazionale venne chiamato Edmondo Fabbri, il quale inanellò una serie di vittorie consecutive che galvanizzarono l’ambiente. Emergeva però una preoccupante inclinazione: nelle gare di scarso valore le vittorie erano nette, nelle partite di una certa importanza i successi erano meno frequenti. La Figc considerava, comunque, l’operato del tecnico romagnolo molto buono. La qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo arrivò il 7 dicembre 1965 a Napoli contro la Scozia. Intanto, qualche mese prima, la Federazione aveva stabilito il blocco totale all’importazione dei calciatori stranieri. Nel gennaio 1966 vennero sorteggiati i gironi e l’Italia capitò con Corea del Nord, Cile e Unione Sovietica, sorteggio considerato benevolo. Dopo le amichevoli di preparazione disputate in primavera, a fine giugno la comitiva azzurra partì alla volta dell’Inghilterra.
2. L’eliminazione della Nazionale e la “grande chiusura”: reazione di stampa e politica
Dopo aver vinto la prima partita contro il Cile e aver perso la seconda contro l’Urss, il 19 luglio 1966 l’Italia venne sconfitta dalla Corea del Nord nell’ultimo incontro del girone eliminatorio e quindi eliminata. Ancora una volta, la Nazionale usciva anticipatamente dai Mondiali. Le cause del fallimento furono molteplici, ma Fabbri ebbe le responsabilità maggiori: per la preparazione, in quanto fece disputare agli Azzurri quattro amichevoli nel giro di due settimane, che stremarono giocatori già stanchi per il campionato appena concluso; per le convocazioni, che non tennero conto di alcuni calciatori che avevano ben figurato nel campionato 1965-1966 e di cui la Nazionale avrebbe potuto beneficiare; per le scelte tattiche; per Fabbri stesso, in quanto si dimostrò inadatto al ruolo non sapendo reagire adeguatamente alle polemiche pre-Mondiale e poiché instaurò un cattivo rapporto con la stampa durante la competizione. Anche l’eccessiva euforia intorno alla selezione azzurra nelle settimane precedenti l’inizio del torneo ebbe il suo peso. Al rientro a notte fonda all’aeroporto di Genova, gli atleti furono bersaglio di un lancio di ortaggi da parte dei tifosi inferociti. Fabbri aprì invece una controversia con la Figc per un presunto caso di “doping all’inverso”, che avrebbe coinvolto i giocatori scesi in campo contro la Corea. Il tecnico romagnolo ne uscì sconfitto, venendo così sollevato dall’incarico e squalificato dall’attività di allenatore per un anno. Al suo posto vennero nominati Herrera e Valcareggi, che dopo poche partite rimase commissario unico. La Federazione decise di confermare fino a data da destinarsi il blocco ai calciatori stranieri e la questione non fu più riaperta per molto tempo1.
La sconfitta contro i coreani ebbe un’ampia risonanza sulla stampa italiana, sportiva e non. Esaminando i principali giornali nazionali del giorno seguente la partita, ossia del 20 luglio 1966, è possibile cogliere alcuni punti in comune. Gli articoli definiscono aspramente la disfatta, utilizzando termini come “vergogna”, “fallimento”, “disastro” e “umiliazione”. Il discorso diventa poi spesso una critica verso il sistema calcistico italiano. L’Italia ha deluso le aspettative e quella di Middlesbrough non è stata una sconfitta casuale, ma è stata “preparata” nelle partite precedenti. Tuttavia, è stata la migliore prestazione degli Azzurri, i cui sforzi però sono risultati vani. I giornalisti cui è affidato il difficile compito di commentare, nella maggior parte dei casi puntano l’indice verso Edmondo Fabbri, giudicato inadatto al ruolo e reo di aver compiuto scelte sbagliate in fase di convocazione, di preparazione e di gestione tattica delle partite. In misura minore vengono riconosciute le responsabilità di giocatori e Figc. Inoltre, pressoché tutti gli autori convengono sul fatto che l’infortunio occorso a Bulgarelli sia stato condizionante. Non manca, infine, qualche nota sulla fortuna, giudicata contraria agli italiani, sull’arbitraggio, a favore dei coreani nel primo tempo e abbastanza equilibrato nel secondo, e un elogio agli asiatici per la gara disputata2.
La sconfitta dell’Ayresome Park non lasciò indifferente nemmeno la politica, com’è possibile notare dalle interrogazioni e dalle interpellanze riportate dalle maggiori testate giornalistiche nazionali il 20 luglio 1966. Le interrogazioni e le interpellanze presentate il giorno successivo all’eliminazione da esponenti dei più diversi partiti presentano alcuni tratti comuni. La disfatta inglese costituisce una sorta di punto di partenza per riformare il calcio, se non tutto lo sport, italiano. Essendo “interrogazioni” e “interpellanze”, queste sono volte a chiedere ai membri del governo quali provvedimenti intendano prendere per compiere questa riforma. Dopodiché, gli interroganti esprimono quella che per loro è la causa del basso livello cui è giunto il nostro calcio, che nella maggior parte degli atti parlamentari è l’enorme flusso di denaro dietro di esso. Infine, ognuno suggerisce al governo dove e come intervenire, ma anche in questo caso è possibile ravvisare una linea sostanzialmente prevalente: riportare il football nazionale alle origini, quindi a una dimensione più sportiva, più agonistica, limitando fortemente l’aspetto economico o addirittura eliminandolo. Da dove iniziare, dunque, questa riforma? Dalla base, ossia dalle infrastrutture preposte all’attività sportiva e dal sostegno allo sport giovanile e dilettantistico, premesse per una futura rifiorita del “pallone” italiano. Da ultimo, le varie interrogazioni e interpellanze presentano toni duri e caricano di gravità una sconfitta che, seppur ingloriosa, rimane pur sempre sportiva. Al fine di ridimensionare l’accaduto sono dunque da intendere rispettivamente le dichiarazioni dell’onorevole Evangelisti e il telegramma del Presidente della Repubblica Saragat3.
3. Il 1966 e la beat generation. Due casi emblematici: George Best e “Gigi” Meroni
Nel 1966 dal punto di vista culturale venne alla luce il fenomeno chiamato beat generation, nato negli Stati Uniti qualche anno prima e affermatosi poi in Europa e in Italia. I tratti principali di questo movimento furono: il pacifismo; l’antiautoritarismo; l’anticonformismo; l’ecologismo; la liberalizzazione spirituale, sessuale e del consumo di alcol e droghe leggere; il passaggio dal rhythm and blues al rock and roll; la riscoperta del viaggio e del marxismo. La beat generation influenzò vari settori, principalmente arte e moda. La versione italiana di questo movimento fece proprie molte delle istanze del beat americano, ma nel 1966 era ancora un fenomeno incipiente. Se la società sembrava chiusa a questo movimento, il mondo del calcio appariva quasi impermeabile. Facevano eccezione due calciatori: George Best e Luigi Meroni. Il primo, nordirlandese, fu uno dei più grandi giocatori a livello mondiale: militò per molto tempo nel Manchester United e raggiunse l’apice della sua carriera nella seconda metà degli anni Sessanta. Fu tanto talentuoso quanto sregolato nella vita privata. Condusse infatti un’esistenza costellata di eccessi: risse, sbronze, locali notturni, incidenti stradali e flirt con numerose modelle. Morì nel 2005 a Londra per un’infezione epatica. Anche Meroni fu un calciatore talentuoso, ma la sua fama rimase confinata all’ambito italiano. Vestì le maglie di Como, Genoa e Torino, venne convocato in Nazionale e partecipò ai Mondiali del 1966. Fu un tipo ribelle e anticonformista ma, a differenza di Best, non condusse vita sregolata. Morì prematuramente il 15 ottobre 1967, investito da un’auto a Torino.
Best e Meroni avevano diversi punti in comune: entrambi erano ottimi calciatori professionisti, toccarono l’apice della propria carriera nella seconda metà degli anni Sessanta, giocavano in un ruolo pressoché identico (ala), portavano lo stesso numero di maglia (il sette) ed erano anticonformisti, portando i capelli lunghi e la barba o le basette, indossando vestiti sgargianti e stravaganti e guidando macchine appariscenti. Ma se, riguardo a Best, a fare notizia era la sua condotta dissoluta, relativamente a Meroni, che al di là delle stravaganze conduceva vita regolare, facevano scandalo alcuni aspetti della sua esistenza stigmatizzati dalla società italiana d’allora. Molti comportamenti di Best vennero tollerati per il suo enorme talento e per la società britannica in sé, più cosmopolita e progredita di quella della Penisola (erano gli anni della Swinging London4 e più in generale della rivoluzione culturale inglese, a sua volta influenzata dalla beat generation americana). Nonostante le conseguenze sociali del boom economico, la società italiana rimaneva piuttosto arretrata e il mondo del calcio ancora di più. Meroni veniva criticato per i suoi capelli, considerati troppo lunghi, per il suo abbigliamento, definito bizzarro e “pagliaccesco”, e per la sua relazione con Cristiana Uderstadt, «ragazza appartenente a una famiglia di giostrai, di gente irregolare per la mentalità comune»5, reduce da un matrimonio fallito e con la quale conviveva senza essere sposato.
George Best e “Gigi” Meroni, il “Best italiano”, con il loro stile di vita alternativo furono emblematici di un comune sentire dei giovani dell’epoca, un sentire che prefigurava quello che sarebbe accaduto nel 1968. Ma Meroni assunse un ruolo ancora più importante. Come scritto in precedenza, nel 1966 la Figc confermò il blocco all’importazione di calciatori stranieri. Egli, oltre a essere uno degli Azzurri che presero parte alla disfatta mondiale, costituì una sorta di personaggio chiave. Infatti, il calcio italiano decideva di “chiudere le frontiere” proprio mentre i giovani guardavano al mondo, che stava cambiando sotto gli effetti della beat generation. Meroni era il “simbolo calcistico” dell’attenzione dei ragazzi italiani verso ciò che succedeva all’estero, verso il mutare dei costumi, dei gusti e degli stili di vita dei loro coetanei. Appare dunque chiara la contraddizione fra un mondo, quello giovanile, proiettato verso l’esterno e un altro, quello del calcio italiano, che decideva invece di chiudersi in se stesso. Allo stesso modo è evidente anche l’anacronismo di una scelta come quella della “chiusura delle frontiere” a dispetto di un mondo che tendeva ad abbatterle. Infine, come si è detto, non era solo il nostro football a essere chiuso in se stesso, ma anche la società. Meroni, attraverso le pesanti critiche che dovette subire, rese manifesti il conservatorismo e l’arretratezza culturale di cui era intrisa l’Italia dell’epoca6.
4. La “riapertura delle frontiere” del 1980
Dopo quasi quindici anni, nel 1980 la Figc decise di “riaprire le frontiere” ai calciatori stranieri. Non fu un caso che questa decisione fosse stata presa nella fase di passaggio da Comunità economica europea (Cee) a Unione europea (Ue), all’indomani delle prime elezioni dirette del nuovo Parlamento europeo nel 1979. Ma all’inizio degli anni Ottanta era mutata anche la società italiana, caratterizzata da un ritorno a posizioni di forza del ceto borghese-imprenditoriale, da una netta diminuzione dell’inflazione e da un miglioramento del tenore di vita della popolazione. La situazione economica del nostro paese ebbe un’accelerazione decisiva alla metà del decennio, in corrispondenza dei due governi Craxi dall’agosto 1983 all’aprile 19877.
Le progressive “aperture” agli stranieri viaggiavano su un binario quasi parallelo al processo costitutivo dell’Unione europea. In particolare, due fra gli atti che portarono alla nascita della Ue ebbero importanti ripercussioni sul calcio continentale: l’accordo, e la successiva Convenzione, di Schengen e il Trattato di Maastricht. Il primo è un trattato internazionale firmato il 14 giugno 1985, nella località lussemburghese di Schengen, da Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania Ovest e Francia e prevedeva la graduale eliminazione dei controlli alle frontiere fra i cinque Stati firmatari, sia in materia di merci che di persone. A quest’accordo seguì la Convenzione omonima, del 19 giugno 1990, che definì le condizioni applicative del precedente trattato. Nello stesso anno anche l’Italia aderì alla Convenzione. Il Trattato di Maastricht venne firmato da dodici nazioni, fra cui la nostra, il 7 febbraio 1992 nell’omonima cittadina olandese e delineò i parametri politici, economici e sociali che gli Stati aderenti avrebbero dovuto rispettare per far parte dell’Unione. Il Trattato di Maastricht, che entrò in vigore nel 1993, è considerato l’atto fondativo dell’Unione europea8.
Concludendo, la sconfitta contro la Corea del Nord e la conseguente eliminazione dell’Italia dal Mondiale, costituì un momento di grande vergogna e di profonda indignazione per l’opinione pubblica del Belpaese, poiché fu l’ennesima delusione nazionale a una Coppa del mondo, poiché si uscì contro avversari giudicati calcisticamente inferiori e poiché le aspettative erano alte. Vergogna e indignazione furono provate soprattutto da stampa e politica. I giornalisti gareggiarono fra loro nella ricerca delle cause e nella caccia ai colpevoli, mentre i politici, che fino allora si erano interessati poco al calcio, strumentalizzarono l’evento per scagliarsi contro il governo, anche all’interno della maggioranza stessa, e per muovere critiche all’intero sistema sportivo nazionale. Sia la carta stampata che i parlamentari non mancarono poi nemmeno di proporre le proprie soluzioni per risolvere la situazione. In questo modo, non si fece altro che ingigantire oltremisura una sconfitta che rimaneva pur sempre calcistica.
La “chiusura delle frontiere”, invece, sembrò sin da subito anacronistica non tanto verso la società italiana nel suo complesso, che appariva chiusa anch’essa, quanto verso l’universo giovanile italiano, che si stava aprendo al mondo e che si apprestava a “preparare” il Sessantotto. Come si è visto, Meroni fu figura emblematica in questo senso. Ma si dimostrò anacronistica anche negli anni seguenti, ossia dalla fine degli anni Settanta in avanti, quando l’Italia cominciava a compiere passi decisi verso un’integrazione europea, all’interno di una sempre più ampia globalizzazione.
Note
1 Cfr. Nicola De Ianni, Il calcio italiano 1898-1981. Economia e potere, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 151-214; Gianni Brera, Storia critica del calcio italiano, Milano, Baldini & Castoldi, 1998, pp. 185-365; Antonio Ghirelli, Storia del calcio in Italia. Con tutti i risultati, le squadre e i record, Torino, Einaudi, 1990, pp. 171-299.
2 Cfr. Emilio Violanti, Esce Bulgarelli al 36’ e la Corea (1-0) è padrona. Corea Nord – Italia 1-0 (1-0), in “La Gazzetta dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 1; Gualtiero Zanetti, C’è un solo responsabile, in “La Gazzetta dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 1; Antonio Ghirelli, Una sconfitta che viene di lontano, in “Corriere dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 8; G.C. Turrini, L’assurdo che rasenta il ridicolo, in “Stadio”, 20 luglio 1966, p. 2; Gino Palumbo, L’umiliazione più cocente, in “Corriere della Sera”, 20 luglio 1966, p. 16; Vittorio Pozzo, Di fronte ad una squadra modesta risultato umiliante. I coreani hanno lottato con coraggio e decisione, doti che sono mancate ai nostri calciatori – La squadra aveva già deluso contro Cile ed Urss, in “La Stampa”, 20 luglio 1966, p. 8; Gianni Brera, Corea: azzurri a casa! Si è avverato l’incredibile, siamo stati eliminati – Al 34’ Bulgarelli, contuso, ha lasciato il campo – 7’ dopo i coreani hanno segnato il gol – Vani attacchi italiani nella ripresa, in “Il Giorno”, 20 luglio 1966, p. 1.
3 Cfr. Interrogazioni in Parlamento sul C.T. Fabbri e sul calcio azzurro, in “Corriere dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 9; R.T. Fabbri, Trova eco in Parlamento la sconfitta dell’Italia. Intervento polemico del presidente della Roma on. Evangelisti, in “Stadio”, 20 luglio 1966, p. 5; I parlamentari “interrogano” (e l’on. Evangelisti li smaschera con coraggio), in “La Gazzetta dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 1; I deputati interrogano il ministro, in “Corriere dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 4; Saragat ha telegrafato a Salvadore. Presentate numerose interpellanze sul comportamento dei nostri calciatori, in “Il Giorno”, 20 luglio 1966, ultima p.; Vasta eco in Parlamento alla sconfitta italiana, in “L’Unità”, 20 luglio 1966, p. 12; Evangelisti “Basta con i politici che cercano pubblicità”, in “Corriere dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 4; Saragat agli Azzurri, in “La Gazzetta dello Sport”, 20 luglio 1966, p. 1.
4 Per un approfondimento sulla Swinging London si veda Marco Innocenti, Quando il calcio ci piaceva più delle ragazze. I favolosi Sessanta, Milano, Mursia, 2008, pp. 213-214.
5 Antonio Papa, Guido Panico, Storia sociale del calcio in Italia, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 320.
6 Cfr. Innocenti, Quando il calcio ci piaceva più delle ragazze, cit., pp. 116-127; 209-221; John Foot, Calcio 1898-2007. Storia dello sport che ha fatto l’Italia, Milano, Rizzoli, 2007, pp. 191-198; Papa, Panico, Storia sociale del calcio in Italia, cit., pp. 319-321.
7 Cfr. Andrea Di Michele, Storia dell’Italia repubblicana, 1948-2008, Milano, Garzanti, 2008, pp. 220-227; Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 345-347; 356-378.
8 Cfr. Tony Judt, Postwar. La nostra storia 1945-2005, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 647-660; 880-1023.