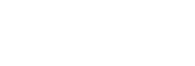In apertura: il Palazzo delle Poste di Ferrara, inaugurazione, 1 giugno 1930.
1. Introduzione
Negli anni Venti e Trenta del Novecento l’architettura è stata sicuramente uno degli strumenti prediletti nella costruzione del consenso mussoliniano e Roma il luogo privilegiato dove il «fascismo di pietra realizzò, con il maggior impegno, la rappresentazione dei miti fascisti negli edifici pubblici, nelle vie, nei monumenti e nell’assetto urbanistico»1. Dal dopoguerra ad oggi, le strutture razionaliste hanno attirato l’attenzione di storici e politici, hanno stuzzicato la fantasia di turisti ed architetti, perciò non possiamo tralasciare la complessità interpretativa di cui, tuttora, esse sono protagoniste.
Paolo Nicoloso nel saggio Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista2, affrontando la tematica dell’architettura tra le due guerre, si domanda:
Non dichiarano forse questi monumenti, al di là delle loro non eguali qualità artistiche, una storia dominata dalla dittatura, dalla soppressione delle libertà democratiche, da guerra di aggressione verso altri popoli, da politiche di segregazione razziale? […] È possibile, in altre parole, curare un paese in crisi di democrazia, identificando figurativamente la propria memoria storica in edifici, simboli di una dittatura che educava e praticava un profondo odio anti-democratico?
Nell’ultimo decennio gli storici hanno iniziato, infatti, a parlare di patrimonio dissonante per definire tutti quegli oggetti patrimoniali che possono dare origine a interpretazioni conflittuali, o comunque in contrasto tra loro, da parte di gruppi socio-culturali diversi o dallo stesso gruppo che cambia idea nel corso del tempo. Tralasciando le discutibili operazioni volte a demolire, celebrare o musealizzare le opere razionaliste, va menzionato un recente percorso metodologico che abbraccia la storicizzazione degli edifici e, in alcuni casi, la risemantizzazione degli stessi, come è avvenuto a Bolzano.
In piazza del Tribunale, ex piazza Arnaldo Mussolini, è presente il più grande bassorilievo di epoca fascista ancora esistente in Italia, opera di Hans Piffrader, funzionale allora ad abbellire ed esaltare la figura del Duce sulla facciata della Casa Littoria, sede del Pnf. Lo spazio al centro del fregio è occupato dall’immagine di Mussolini a cavallo che alza il braccio destro nel “saluto romano”. La forte connotazione propagandistica ed ideologica del monumento, datato 1939-1942, contrasta coi valori democratici della società attuale, di conseguenza l’Amministrazione provinciale altoatesina ha tentato di innescare un processo di elaborazione del passato cercando di sottoporre a critica lo slogan preesistente. L’iscrizione originale «Credere, obbedire, combattere», difatti, posizionata di fianco al Duce, è stata accompagnata da una grande scritta luminosa – proposta dagli artisti Arnold Holzknecht e Michele Bernardi – che riporta una frase della filosofa Hannah Arendt a proposito del processo al nazista Adolf Eichmann: «Nessuno ha il diritto di obbedire». In questo caso, la scelta artistica non si è tradotta in una superfetazione che è andata a ledere l’opera, ma si è destrutturato il significato di un motto molto in voga durante il fascismo e altrettanto conosciuto a livello popolare anche ai giorni nostri3.
Nel noto quartiere EUR, invece, le architetture controverse sono state trattate in modo conservativo, ossia sono state privilegiate grandi opere di restauro volte a riproporre gli edifici nella loro maestosità originaria, eludendo in parte il problema della faziosità comunicativa.
L’edificio più rappresentativo è sicuramente il Palazzo della Civiltà Italiana, rinominato Colosseo Quadrato: un parallelepipedo a pianta quadrata con quattro facciate uguali di 54 archi, 9 in linea e 6 in colonna, con la struttura in cemento armato e la copertura di travertino. Inaugurato ancora incompleto nel 1940, i lavori continuarono fino al 1943 per poi essere ripresi nel dopoguerra. Oggi come allora, sulla sommità dell’edificio campeggia l’iscrizione: «Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori»; parole d’ordine espunte da un discorso che Benito Mussolini tenne il 2 ottobre 1935, durante la guerra d’Etiopia, divenute presto un compendio dell’identità italiana secondo l’ideologia fascista4. Quelle frasi che guardano dall’alto Roma, i romani e gli italiani non lasciano indifferenti, hanno la necessità, quindi, di essere contestualizzate nel periodo in cui sono state elaborate.
I luoghi che verranno indagati di seguito vanno inseriti nel contesto storico di riferimento: è il caso del Palazzo delle Poste di Ferrara e di Anita, piccola città di fondazione oggi frazione del Comune di Argenta (Ferrara). Nello specifico, si è deciso di analizzare e rileggere il momento della fondazione del villaggio rurale e il giorno dell’inaugurazione di un importante edificio cittadino della città estense.
2. Anita, villaggio rurale. Una periferia del Novecento
20 dicembre 1939, XVIII dell’era fascista. In aperta campagna, poco distante dalle Valli di Comacchio, su una porzione di terra incolta e inospitale, davanti ad una tribuna d’onore ornata di tricolori, centinaia di contadini in divisa da lavoro e massaie rurali con fazzoletti multicolori pestano il fango in attesa dell’arrivo di importanti autorità politiche. Il colpo d’occhio è degno di nota: tra la folla non passa inosservata la composita rappresentanza fascista costituita dalla “colonna del XX Dicembre”, dai reparti della 76esima legione M.V.S.N., dalle fanfare della G.I.L. di Ferrara e Copparo, dal Nucleo universitario fascista di Argenta, dalle rappresentanze di tutti i paesi della provincia con i relativi gagliardetti. Il giorno è di quelli che fanno storia: nella sperduta landa deltizia viene inaugurata una nuova città.
Italo Balbo, maresciallo dell’aria e governatore della Libia, secondo le cronache partito da Tripoli per presenziare all’inaugurazione del primo lotto dell’appoderamento, giunge a Ferrara alle ore 19 del giorno precedente. L’indomani si reca di fronte alla Casa del Fascio, in viale Cavour, per rendere omaggio ai morti dei «Fatti del castello estense» del 20 dicembre 19205, quando in uno scontro tra diverse fazioni politiche morirono sei persone, quattro fascisti e due socialisti6. Quella data, che lega a livello simbolico e ideologico il passato col presente, è diventata a posteriori una tappa fondamentale per l’affermarsi del fascismo in città. La mistica fascista si nutre del sangue dei morti, e ne sono consapevoli le autorità che affiancano Balbo, giunte appositamente per le celebrazioni: sostano alcuni momenti in raccoglimento dopo la deposizione di una corona d’alloro davanti al sacrario, poi partono in direzione del basso ferrarese. La folla entusiasta della palude, però, dovrà aspettare ancora qualche ora per poter assistere al rito della fondazione, infatti i gerarchi devono prima incontrare autorità e possidenti locali e constatare de visu i lavori in essere e quelli programmati7.
Come riporta con dovizia di particolari il “Corriere Padano” di Nello Quilici, le automobili sui cui viaggiano Italo Balbo, Giuseppe Tassinari (ministro dell’Agricoltura e Foreste), Ferdinando Mezzasoma (vicesegretario del Pnf), Mario Muzzarini (consigliere nazionale della Confederazione fascista degli agricoltori) e Vincenzo Lai (consigliere nazionale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’agricoltura), seguite da un codazzo di agenti di scorta, si lasciano alle spalle l’Arco della Prospettiva e arrivano nell’area di bonifica: nella zona Testa inaugurano una casa del primo lotto di appoderamento; nella zona Umana il ministro Tassinari posa la prima pietra di una casa del secondo lotto, quindi sostano a Valle Boccagrande per visitare una pompa di irrigazione8. Poi visitano lo stabilimento idrovoro Umana ricevuti, di fronte ad un generoso rinfresco, dal dottor Giacometti (presidente del Consorzio della Bonifica Argentana), dal rag. Soldati (direttore) e dall’ingegner Braglia, progettista del neonato villaggio agricolo. Infine, si spostano nello spiazzo in cui sarebbe sorta la piazza del nuovo centro rurale. Il pubblico delle grandi occasioni accoglie i gerarchi sulle note di “Giovinezza”, consapevole di apprestarsi a vivere un momento storico. Di fronte ad un reparto di avanguardisti disposti sull’attenti, viene posata la prima pietra della Casa del Fascio del nuovo insediamento, a cui viene assegnato il nome di Anita, in memoria di Ana Maria de Jesus Ribeiro, conosciuta come Anita Garibaldi, moglie dell’eroe dei due mondi, morta il 4 agosto 1849 nella fattoria Guiccioli, in località Mandriole, poco lontano da questi luoghi. Il mito della fondazione della città si esprime attraverso gesti rituali densi di significato, scenografie studiate nei minimi dettagli, paramenti e pose plastiche, inni militareschi e benedizioni sacerdotali, in una commistione di sacro e profano funzionale a far breccia nel cuore delle masse. Infatti la folla rimane a bocca aperta quando vede il ministro Tassinari porre una pergamena dentro un bossolo di ottone, che verrà poi inserito nel blocco di cemento da interrare, dopo la consueta benedizione. Solo successivamente Tassinari e Balbo possono dare il primo strato di calce alla pietra davanti alla numerosa stampa e alle camere attente del Luce. Chiusosi il sipario sulla manifestazione, gli invitati tornano nei paesi di residenza, i contadini alle proprie cascine e il silenzio della campagna si riappropria dei suoi spazi: restano un borgo incompleto, una comunità sfilacciata e gli annosi problemi di disoccupazione.
Anita, difatti, è nata dalla necessità di creare un centro agricolo conseguentemente alle politiche d’appoderamento proposte dal regime, a bonifica già effettuata, come accaduto in altri luoghi d’Italia, dall’Agro Pontino alla Sardegna. Qui nel basso ferrarese prossimo al Delta, le opere di prosciugamento della terra sono iniziate su vasta scala nella seconda metà dell’Ottocento, e vengono intensificate negli anni Venti quando hanno inizio le bonifiche del “Mantello” (1921), della zona “Testa” (1924), del bacino “Umana-Montecatina” (1925), poi della zona “Umana” (1930) e “Gramigne” (1934)9.
Bisogna immaginarsi una terra caratterizzata dalla grande impresa capitalistica a vocazione cerealicola legata alle colture industriali (barbabietola, canapa, tabacco), da una massa imponente di braccianti in compartecipazione e di lavoratori avventizi costretti a fare i conti con una trasformazione fondiaria mai veramente realizzata, a dispetto di quanto proclamato dal fascismo. Difatti gli annunci al VII Congresso ferrarese del Pnf, nel febbraio del 1928, del segretario federale Umberto Klinger, a nome anche di Balbo e Vittorio Cini, che proponevano una duplice bonifica, idraulica e agraria, l’eliminazione dell’avventiziato agricolo e la formazione di una nuova classe di contadini, rimangono lettera morta10. A metà anni Trenta, poi, la parola «appoderamento» viene riproposta: l’Ispettorato agricolo regionale stila un nuovo progetto e arrivano ulteriori finanziamenti pubblici e agevolazioni creditizie usati per bonificare, ristrutturare idraulicamente o irrigare miglia di ettari di terreno. Nonostante ciò i grandi proprietari terrieri eludono il progetto e non si avventurano in ristrutturazioni aziendali continuando a godere della situazione di privilegio in cui si sono sempre trovati. Quando viene fondata Anita, quindi, l’appoderamento inizialmente ideato per la provincia di Ferrara è stato realizzato solo in parte, ma nel rettangolo di terra tra Lagosanto, Comacchio e Argenta si possono effettivamente apprezzare centinaia di nuovi poderi, fabbricati, stalle e servizi. La campagna è disseminata di cascine in cui risiede la forza lavoro e al centro dell’area vasta vi è il «borgo di servizio» che non ha carattere residenziale, bensì deve fungere da centro di aggregazione, quindi è dotato solamente di servizi essenziali quali chiesa, scuola, casa del fascio, bottega, barbiere, locanda. Il Consorzio delle Bonifiche Argentane è il grande artefice di quest’intervento, per una spesa totale di 1.200.000 lire: il 75% a carico dello Stato e il 25% restante suddiviso tra Comune di Argenta e Consorzio.
Ancora oggi si notano tracce di quegli anni turbolenti sulle facciate di alcune case coloniche, sopra le quali è presente l’anno di costruzione con i caratteristici font del periodo. Anita, invece, è un cumulo di case nel centro di una pianura sterminata ed è anticipata da lunghi rettifili a perdita d’occhio, strade che sezionano il territorio in campi coltivati in modo intensivo, vecchi e nuovi toponimi che denotano la densità storica del luogo nei suoi cambiamenti secolari: via Pagana, via Fossa dei Socialisti, via Valle Umana, via Madonna del Bosco, via Collettore. Degli anni del fascismo rimane, sebbene alterato, lo schema urbanistico ortogonale a croce, rinvenibile nella piazza su cui si affacciano la scuola, la casa del fascio e la chiesa. Negi isolati quadrangolari esterni, invece, sono presenti abitazioni costruite in tempi più recenti, quasi interamente nel secondo dopoguerra. Al di là dei titoli reboanti del “Corriere Padano”, Anita non è mai stata conclusa: i tre edifici razionalisti, ad esempio, sono ultimati dopo alcuni anni, nel settembre del 1943; i lavori previsti per il completamento della piazza vengono sospesi per motivi bellici; negli anni della guerra, poi, i pochi edifici costruiti vengono lesionati o razziati e occupati dagli sfollati della zona.
3. Il Palazzo delle Poste: «una balena in secca sulla spiaggia di Ferrara»
Cielo terso, temperatura mite, Spal reduce da una sconfitta per 3 a 0 contro la Comense nel girone finale del campionato di Prima Divisione. È il primo giugno 1930 quando il vociare di centinaia di persone si propaga a pochi metri dal castello estense, tra via Cavour e via Spadari. Superando le due ali di folla assiepate ai bordi dei binari del tram che percorrono tutto il rettifilo fino alla stazione, spiccano, come sospinti su un podio dalle sperticate lodi e dagli incessanti gesti di magnificazione del pubblico, le figure distinte di Ferdinando Pierazzi, sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni, Renzo Ravenna, il podestà avvocato di origini ebraiche, e Italo Balbo, l’immancabile ras che nel giro di un decennio è riuscito a controllare Ferrara, convincendo ceti produttivi e borghesia cittadina. Tra autorità locali, reparti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, fanfare e gagliardetti delle rappresentanze delle più svariate categorie e tanti curiosi, molti puntano gli occhi su Angiolo Mazzoni del Grande, l’architetto-ingegnere bolognese abituato a frequentare i salotti della capitale sin dall’adolescenza, quando vi si è trasferito con la famiglia11. Di modi affascinanti, elegante nel portamento, iscritto al Partito nazionale fascista dal 1926, è sicuramente tra i più grandi professionisti della sua generazione. Lo sanno tutti i dirigenti comunali che hanno dovuto sopportare la sua presenza in città per anni e ne è convinto anche Balbo, che durante la solenne cerimonia, davanti ai presenti, è costretto ad esprime il proprio compiacimento e la stima di convenienza richiesta in tali occasioni. L’indomani, puntuale, Il “Corriere Padano” dà notizia dell’evento utilizzando toni esaltanti. Ma dietro alle fredde strette di mano tra l’architetto e l’entourage che segue Renzo Ravenna si celano dissapori, colpi bassi, capricci, interessi personali, parcelle e soldi.
Angiolo Mazzoni quando si è presentato a Ferrara nei primi mesi del 1926 ha 32 anni, ha già avuto importanti rapporti con Gustavo Giovannoni, è ispettore di prima classe presso il Servizio Lavori e Costruzioni delle Ferrovie dello Stato, con Marcello Piacentini sta imbastendo i progetti per partecipare al concorso per il Palazzo della Società delle Nazioni di Ginevra e, soprattutto, ha ricevuto ex cathedra dal Ministero delle Comunicazioni presso cui lavora, senza che sia stato bandito alcun concorso, l’incarico di progettare il nuovo ufficio delle poste della città. Alla notizia, molti architetti ferraresi hanno scosso il capo: aspettavano da decenni – se ne parlava dal 1906 – che venisse sostituito il vecchio spazio di piazza Teatini, sudicio e angusto per un centro urbano in aumento, ma sicuramente credevano che la questione si potesse risolvere dentro le mura.
Lo storico Lucio Scardino, che ha ricostruito bene tutta la vicenda nel terzo capitolo dell’importante volume Angiolo Mazzoni, Architetto Ingegnere del Ministero delle Comunicazioni12, spiega come sono nati i dissapori, a partire dalla riunione del 14 settembre 1926 – la seconda dopo quella dell’aprile dello stesso anno – tenutasi negli uffici comunali. In quell’occasione Mazzoni deve illustrare il progetto a tutti gli interessati: ha di fronte a sé diversi dipendenti comunali della commissione edilizia e, soprattutto, gli architetti ferraresi che avrebbero dovuto collaborare alla realizzazione dell’edificio. «Il fabbricato a smussatura avrà in un angolo un porticato al quale si accederà a mezzo gradinata e servirà d’ingresso principale. Altro ingresso sarà sull’angolo tra viale Cavour e la nuova via (l’odierna via Beretta)» afferma. È tutto molto chiaro: il retro dell’edificio sarebbe stato decorato in modo semplice, mentre per il fronte, «oltre alla pietra d’Istria e al cotto, sarebbe stato utilizzato il marmo: nero per le basi e i capitelli, marmo statuario per le colonne in modo che nella parte centrale dell’edificio campeggeranno il bianco e il nero, a ricordo dei colori della città»13. La controparte richiede alcune modifiche al progetto mostrato, in seguito viene approvato e a distanza di tre mesi iniziano i lavori. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma nel corso degli anni si accende un aspro contrasto tra Mazzoni e l’ingegner Ermanno Tedeschi, direttore dei lavori. Il primo predispone diverse varianti, come la sostituzione della pietra d’Istria con il marmo Spagnago; l’eliminazione del contrasto cromatico bianco-nero; il secondo non può accettare che i colori di Ferrara vengano calpestati tanto facilmente. I ferraresi si alleano e l’asse Tedeschi-Ravenna-Nello Quilici risulta essere una vera e propria spina nel fianco per l’architetto bolognese14. Nel novembre del 1928 le Commissioni di Edilità e Belle Arti presentano un esposto al Ministero preposto sottolineando come le varianti in itinere sarebbero andate ad alterare le originarie forme signorili dell’immobile; Renzo Ravenna, poi, invia accesi telegrammi all’amico Balbo e a Costanzo Ciano, Ministro delle Poste e Telegrafi, auspicando in un dietrofront; infine il 2 aprile 1929, Nello Quilici, direttore del “Corriere Padano”, lancia strali direttamente dal massimo organo di stampa della città: paragona il palazzo ad «una balena in secca sulla spiaggia di Ferrara», a un «torrone di pietra e calcinaccio», ad una «cassata al ribes selvatico». Quilici non accetta l’eclettismo dell’architetto inviato da Roma né la poca considerazione per la tradizione locale. L’inaugurazione viene rinviata diverse volte, fino al primo giugno 1930, quando, con un colpo di spugna, vengono dimenticati anni di contrasti e ostilità: i ferraresi sono riusciti a farsi ascoltare.
Nonostante l’affaire abbia rappresentato un motivo di scontro tra centralismo e localismo di regime, il Palazzo delle Poste risente delle diverse correnti e sensibilità artistico-architettoniche sostenute dai protagonisti dei lavori: è, probabilmente, l’edificio degli anni Trenta che meglio si integra al contesto preesistente: da una parte vengono rispettate le dimensioni e i riferimenti al Rinascimento ferrarese, si veda, nei prospetti, l’uso del laterizio, che richiama il vicino castello estense e il cotto; dall’altra è possibile osservare la coesistenza e il dialogo tra linguaggi diversi afferenti a monumentalismo, razionalismo, metafisica.
Il palazzo è un’opera sincretica che scompagina le visioni artistiche del periodo di costruzione e diventa bene culturale con una sua spiccata originalità a tal punto di diventare parte integrante di quel plurisecolare patrimonio architettonico che caratterizza Ferrara.
Note
1 Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2007.
2 Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Torino, Einaudi, 2008.
3 Cfr. Tomaso Montanari, Le statue giuste, Roma-Bari, Laterza, 2024.
4 Cfr. Maristella Casciato, Sergio Poretti (a cura di), Il Palazzo della civiltà italiana. Architettura e costruzione del Colosseo quadrato, Milano, Federico Motta, 2002.
5 Cfr. Antonella Guarnieri, Il fascismo ferrarese. Dodici articoli per raccontarlo, Ferrara, Tresogni, 2011.
6 Sugli eventi del 20 dicembre 1920, si veda Girolamo De Michele, Un delitto di regime. Vita e morte di Don Minzoni, prete del popolo, Vicenza, Neri Pozza, 2023.
7 Cfr. “Anita” è stata ieri fondata per volontà del Duce, in “Corriere Padano”, 21 dicembre 1939.
8 Cfr. Nel nome del Duce e nel segno dei Caduti oggi si fonda il villaggio rurale di “Anita”, in “Corriere di Ferrara”, 20 dicembre 1939.
9 Cfr. Vander Penazzi, Anita. Dall’Antica Humana al 7 aprile 1945. Una terra, la sua gente, Ravenna, Tipolito Grafica Alfonsinese, 2007.
10 Cfr. Alessandro Roveri, Tutta la verità su Balbo, Quilici e le leggi razziali, Ferrara, Este Edition, 2006.
11 Alfredo Forti, Angiolo Mazzoni: architetto fra fascismo e libertà, Firenze, Edam, 1978.
12 Mauro Cozzi, Ezio Godoli, Paola Pettenella, Angiolo Mazzoni (1894-1979): architetto ingegnere del Ministero delle Comunicazioni, Milano, Skira, 2003 (“Quaderni di architettura Mart, 4”).
13 Ibid.
14 Nel 1973, in un’intervista rilasciata allo storico dell’architettura Alfredo Forti, Angiolo Mazzoni ricorda il progetto con queste parole: «Ah, il famigerato Palazzo di Ferrara. Qui ci avevo due…che mi hanno fatto sudare. Il sindaco che si chiamava Renzo (Ravenna), tradizionalista stilisticamente e il direttore lavori, che si chiamava Tedeschi (ing. Ermanno)».